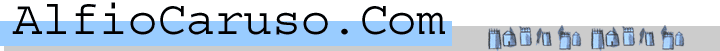
|
|
|
|
1
Che gran bell’anno, il 1847
 Il successo più rilevante Maria Luigia, all’anagrafe Maria Luisa d’Asburgo Lorena, lo coglie da defunta scompaginando nel dicembre 1847 il complesso mosaico degli staterelli italiani.
Il successo più rilevante Maria Luigia, all’anagrafe Maria Luisa d’Asburgo Lorena, lo coglie da defunta scompaginando nel dicembre 1847 il complesso mosaico degli staterelli italiani.
E dire che pure da viva non ha scherzato. A diciannove anni, nel 1810, è diventata moglie di Napoleone, che per lei rappresentava il diavolo, che aveva escluso, nella lettera al padre, l’imperatore d’Austria, Francesco I, di volere per marito prima di arrendersi alle manovre di Metternich. Il futuro controllore dei destini europei stava per compiere il balzo decisivo della sua strepitosa carriera: da ambasciatore a ministro degli Esteri. La bellezza e l’incomparabile lignaggio della principessa gli sono serviti per garantire la sopravvivenza politica degli Asburgo, assai in bilico dopo la sconfitta di Wagram. Napoleone cercava una legittimazione internazionale attraverso il matrimonio con una principessa di sangue blu, che più blu non si potesse. Erano rimaste in lizza la sorella dello zar Alessandro, la quattordicenne Anna, e Maria Luisa. L’ostinato rifiuto della zarina di mollare la figlioletta, alquanto bruttina, a un parvenu corso avevano lasciato campo libero a quella che veniva considerata il più appetibile partito europeo. Matrimonio per procura a Vienna, replicato con rito civile al castello di Saint Cloud e con rito religioso al Louvre, modificato in cappella. Cerimonia, per altro, controversa: Napoleone era sotto scomunica e ufficialmente bigamo giacché il divorzio da Giuseppina Beauharnais non aveva ricevuto la ratifica da Pio VII. Parecchi cardinali gli hanno messo il broncio, è tornato utile aver procurato la porpora al mezzo zio materno Joseph Fesch, fratellastro di mamma Letizia. L’anno seguente (1811) Maria Luisa ha partorito l’unico figlio legittimo di Napoleone, Napoleone Francesco Albertina Maria Guglielmo Alberto, colui che avrebbe dovuto ereditare il mondo, o quanto meno l’Europa, se le pulsioni guerrafondaie del genitore non avessero alla fine sortito la catastrofe. E quando questa s’è appalesata (1813), colei che Napoleone definiva la consorte perfetta - giudiziosa, accorta, accomodante, sorridente di giorno, disponibile di notte - non ha avuto dubbi nel privilegiare la famiglia d’origine alla nuova, benché fosse stata nominata reggente di Francia e avesse da difendere i diritti del figlioletto. I passaggi da un campo all’altro sono stati testimoniati dal cambiamento del nome: inizialmente era Marie Luise alla tedesca, la lingua che si parlava nella corte viennese, poi è stato Marie Louise alla francese, infine è tornato a essere Marie Luise. Di sé diceva che portava sfortuna a quanti gli stavano intorno. Eppure per l’intera esistenza attirerà pretendenti meglio del miele con le mosche. E se la sconfitta di Napoleone a Lipsia e il confino dell’Elba l’hanno all’apparenza coinvolta, in occasione di Waterloo e dell’esilio perpetuo del marito a Sant’Elena è già rientrata a Vienna. Anzi, si è portata avanti dapprima accogliendo nel proprio letto il generale Adam Albert von Neipperg, l’uomo di fiducia messole accanto dal padre; in seguito respingendo l’invito di Napoleone a raggiungerlo. Indifferente alla vasta riprovazione suscitata persino in patria dalla relazione extraconiugale, la ventitreenne Marie Luise si è preoccupata soltanto di garantirsi un buen retiro, il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Paradossalmente l’aveva contrattato per lei Napoleone, ai tempi dell’Elba, e Metternich si è impegnato con le altre potenze, durante il congresso di Vienna, per farlo confermare. La resistenza di quanti, castigati in battaglia per vent’anni da Napoleone, temevano che garantire un trono all’erede potesse trasformarsi in autolesionismo, è stata superata con l’assicurazione che i possedimenti della principessa, ex imperatrice e futura duchessa, non sarebbero stati trasmettibili. Alla sua dipartita li avrebbe ereditati Ludovico di Borbone principe di Lucca. Per sicurezza hanno trattenuto a Vienna, con il consenso della madre, il bimbetto Napoleone Francesco. Così Maria Luigia - il nome è stato ancora modificato per ruffianeria nei confronti dei nuovi sudditi e addirittura annunciato con decreto - ha intrapreso la nuova avventura a fianco dell’amore suo, Neipperg, e sostenuta dal formidabile reticolo familiare. Infatti il Regno Lombardo-Veneto - di freschissima costituzione: l’abilità di Metternich ha consentito di aggiungere la Valtellina, Venezia e Ragusa con annesse province all’antico possedimento milanese - stava alle dirette dipendenze di papà ; il Granducato di Toscana era governato da Ferdinando III, uno degli zii più cari; a Modena regnava Francesco IV, fratello dell’imperatrice Maria Ludovica, la terza moglie di Francesco I, sulla carta matrigna di Maria Luigia, ma soprattutto sua vecchia amica; sul trono di Napoli sedeva il nonno Ferdinando I. I parmensi le hanno riservato un’accoglienza trionfale, lei se n’è beata avendo però l’intelligenza di lasciare la gestione degli affari pubblici a Neipperg, che agiva da cinghia di trasmissione di Metternich. La duchessa si è dedicata alle gioie della famiglia, a sfornare figli, un paio prematuramente morti, a ricreare l’ambiente romantico caratterizzante la sua infanzia austriaca. La dipartita di Napoleone (1821) le ha consentito di regolarizzare l’unione con il compagno: nozze, però , segrete e morganatiche visto il rango inferiore di Neipperg. Alla sua morte nel 1829 Maria Luigia l’ha molto pianto trovando tuttavia consolazione nei tanti pronti a sfidare l’infausta nomea pur di giacerle accanto. Leggende, testimonianze, dicerie raccontano che fosse, malgrado i quarant’anni suonati, il sogno erotico di ogni maschietto del ducato: tutti ammaliati dai modi e dall’avvenenza sempre più prorompente, pronti a diffondere e a ingigantire ogni aspetto del suo robusto appetito sessuale, che secondo gli estimatori si sarebbe rivolto perfino a uno stallone. Accanto ai passatempi privati sono emerse l’indole generosa e la dichiarata volontà di non scontentare gli amati sudditi. Nei moti del 1831 e nei successivi incasinamenti Maria Luigia si è schierata con l’opinione pubblica, ha provato a limitarne le conseguenze e soprattutto le esecuzioni capitali, ha chiesto al padre di ritirare un paio di ministri inviati da Vienna. Si è , tuttavia, sposata con il terzo ministro, il conte francese Charles-René de Bombelles, per il bisogno mai sopito di avere accanto un marito, che si prendesse cura di lei. Gli ultimi anni sono scivolati tra le gioie dei figli, dei nipoti, di un rapporto sempre più idilliaco con Parma, che le si è stretta intorno, silenziosa e affranta, nelle ore dell’addio. Il testamento ha confermato ciò che già si sapeva: ha designato erede il cugino Leopoldo Luigi, figlio dello zio Ranieri d’Asburgo, viceré del Lombardo-Veneto. E qui incominciano i problemi. L’Italia e l’Europa sono sottosopra per l’elevazione al soglio pontificio, nel giugno dell’anno precedente, di Pio IX (Giovanni Mastai Ferretti). Non pronosticata e figlia del mancato arrivo in conclave del cardinale di Milano, l’austriaco Karl Gaysruck con le tassative direttive di Metternich: bloccare il cardinale di Forlì , Gizzi, in sospetto di liberalismo e favorire Lambruschini, il potentissimo segretario di Stato, anima del precedente pontificato, massima garanzia di continuità . Il caso ha però stabilito di entrare in azione. A Fidenza si è rotta una ruota della carrozza di Gaysrueck. Per ripararla è occorsa una settimana. Il cardinale anziché cambiare carrozza, ha preferito godersi l’inaspettata vacanza, sicuro che a Roma, mancando lui, non avrebbero osato procedere alla votazione decisiva. Al contrario, il Conclave ha proceduto per le spicce. Dei 62 porporati accreditati, erano presenti 50, soltanto 8 stranieri: gli altri hanno evitato le insidie del lungo viaggio in un Paese dipinto dai dispacci diplomatici preda di fermenti rivoluzionari. E poi che gusto ci sarebbe stato ad affrontare disagi e pericoli sol per eleggere il favorito di Metternich? Eh sì : anche fra i guardinghi e conservatori cardinali di Santa Romana Chiesa la soverchiante volontà del cancelliere qualche fastidio lo produceva. Lui, d’altronde, svolge al meglio il lavoro, che ritiene di sua esclusiva pertinenza: garantire la sovranità multinazionale dell’impero asburgico, comprese le sfere d’influenze. E non è nemmeno animato da fieri sentimenti anti-italiani. La frase attribuitagli («L’Italia è un’espressione geografica»), che da centosettantacinque anni lo addita quale arci-nemico per eccellenza del Risorgimento, mai la pronunciò . Fausto Brunetti ha appurato che in uno scambio epistolare con Palmerston, primo ministro britannico, Metternich definì l’Italia «nome geografico come quello di Germania». Dal suo punto di vista, l’Italia non è un’entità politica. Difficile dargli torto dopo secoli di vassallaggio e la perdurante suddivisione in staterelli impegnati soprattutto a bloccarsi l’un con l’altro. A Metternich importa che nessuno insidi il possesso austriaco di Lombardia, Veneto, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. In tale ottica risulta determinante mantenere un rapporto privilegiato con la Santa Sede ed era ciò che Metternich ha contato di fare mediante l’influenza di Gaysrueck. Ma in sua assenza i cardinali hanno organizzato una specie di golpe. In due giorni, non accadeva dall’elezione di Gregorio XV (1621), il nuovo Papa è stato scelto. La prima votazione doveva esser d’assaggio e ha visto la leggera prevalenza di Lambruschini su Gizzi. Ma accanto ai favoriti si è affacciato il nome a sorpresa, Mastai Ferretti, che neppure nella sua Imola giudicavano papabile. Al quarto scrutinio (16 giugno 1846), approfittando dello stallo tra i due galli, ha raccolto 34 voti. La leggenda tramanda che Lambruschini sia svenuto per il dolore e Mastai Ferretti per la gioia. Sono seguite le immancabili lacrime, il pezzo forte della casa, e l’annuncio del nome: Pio IX in onore del Pio VII, cui il novello pontefice ha attribuito la propria vocazione. Il novello pontefice è nato nel 1792 a Senigallia, suddito quindi della Chiesa, il cui territorio comprende Lazio, Umbria, Marche, Emilia, Romagna. Il padre, Giordano, apparteneva alla riverita famiglia dei conti Mastai Ferretti. Noblesse oblige, dunque, infliggere una sequela di nomi ai figli: il futuro Pontefice, nono della nidiata, è stato battezzato Giovanni Maria Battista Pellegrino Isidoro. Dal 1803 al 1808 ha studiato presso il celebre collegio degli Scolopi a Volterra. Ripetuti attacchi di epilessia, conseguenza di una gravissima caduta da bambino, l’hanno costretto a interrompere le lezioni e rientrare a Senigallia. I genitori hanno temuto che potesse risentirne nel morale, a causa dell’instabilità di carattere legata alla malattia. Il ragazzo, invece, se n’è approfittato per dedicarsi alla vita di società , verso cui ha mostrato una naturale propensione. I ritratti dell’epoca ce lo mostrano bene in carne, già con il volto da luna piena, che esibirà nelle foto dell’età matura. Ha palesato doti di cavallerizzo, di schermidore, se la cavava nel pallone con il bracciale, sport assai in voga, era imbattibile al biliardo. Tuttavia il meglio di sé l’ha offerto nei rapporti con l’altro sesso: un successo straripante, le donne non gli resistevano, soprattutto se sposate. Le sue avventure sono state considerate quasi un naturale corso di crescita finché non s’è incapricciato di un’attricetta, che a sua volta si era incapricciata del blasone e delle rendite del casato. Per evitare conseguenze hanno spedito Giovanni a Roma dallo zio Paolino canonico di San Pietro. Qui ha chiesto di entrare nella Guardia Nobile, la milizia personale del Pontefice, ma la visita medica l’avrebbe bloccato a causa dell’epilessia, dalla quale è ufficialmente guarito nel 1815 dopo un pellegrinaggio a Loreto. Ripresi gli studi in teologia e filosofia prima al Collegio romano, in seguito all’università ha conseguito la laurea quand’era già seminarista e si era distinto per l’assistenza ai ragazzi abbandonati dell’ospizio Tata Giovanni. Secondo i suoi detrattori, avrebbe subito compreso che le uniche opportunità di carriera a Roma le assicurava il Vaticano e senza nemmeno esplicite richieste di stretta osservanza nei comportamenti privati. Gli annali, difatti, sono pieni di ecclesiastici contornati da concubine e figli illegittimi, ma non è stato il caso di Mastai Ferretti. Una volta consacratosi alla Chiesa, ne è divenuto uno degli adepti più rigorosi. Ha scelto di essere un terziario francescano per caratterizzare la vicinanza ai più poveri, al contempo ha mietuto successi da predicatore. Una serie di sermoni a Senigallia ha ottenuto un così vasto seguito di pubblico da riempire la piazza principale. Indro Montanelli nell’Italia del risorgimento riferisce la maldicenza ottocentesca, che attribuiva la metà delle presenze femminili alle ex amanti. Pur avendo rinunciato a ogni carica, nel ’23 l’hanno inviato presso la missione in Cile. Sono stati due anni di duro apostolato in un Paese caratterizzato dal violento anti clericalismo del governo. Mastai Ferretti ha sfoderato tenacia, intraprendenza, vocazione all’apostolato. Al rientro a Roma ha proseguito nell’opera in favore degli ultimi. Nel ’27 Leone XII, il conte Annibale della Genga, l’ha nominato arcivescovo di Spoleto. Per il prete, decisissimo in passato nel dire no alla carriera, si è trattato di un bel salto in avanti alla tenerissima età di trentacinque anni. Più di uno storico vi ha visto un episodio di favoritismo all’interno delle correnti ecclesiastiche: il Papa marchigiano che ha promosso il conterraneo, la cui consacrazione avverrà ad opera di un terzo marchigiano, il cardinale Francesco Saverio Castiglioni, futuro Pio VIII. Forse la comune estrazione geografica e i giochi di curia avranno svolto un ruolo, ma il giovanissimo arcivescovo ha continuato a meritare la fiducia accordata. Al rigore nella disciplina religiosa ha accoppiato un atteggiamento assai caritatevole nei confronti di chi ne aveva bisogno. Quando si è diffusa la voce che aveva impegnato i propri mobili per soccorrere alcune famiglie indigenti la sua popolarità ha toccato lo zenit. L’ha sfruttata durante l’insurrezione del 1831. Ha convinto i generali pontifici a non aprire il fuoco e i rivoltosi a barattare la consegna delle armi con soldi e passaporti. In tali frangenti gli è capitato anche di salvare la vita al ventitreenne Carlo Luigi Napoleone Bonaparte, figlio del re di Olanda, Luigi, soprattutto nipote di Napoleone (per quanto si sussurri che la madre Ortensia, degna figlia di Giuseppina Beauharnais, l’abbia avuto con un amante). Carlo Luigi e il fratello maggiore Napoleone Luigi, cresciuti a Roma, si erano infiammati per le idee rivoluzionarie in funzione anti austriaca. Avevano aderito alla carboneria, nonostante manchino prove certe per Carlo Luigi, sono stati in prima linea nei moti del ’31. Napoleone Luigi ha perso in seguito la vita a Forli, mentre il futuro imperatore dei francesi è dovuto scappare da Bologna con gli agenti asburgici alle calcagna. Ha trovato riparo a Spoleto; grazie all’aiuto di Mastai Ferretti ha raggiunto la Francia. Dopo pochi mesi la cittadina umbra ha patito un grave terremoto. Pure in questa occasione l’arcivescovo è diventato il personaggio di riferimento: ha guidato gli aiuti, organizzato l’evacuazione, visitato i quartieri disastrati, strappato al nuovo Pontefice, Gregorio XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari), i fondi necessari alla ricostruzione. Il credito conquistato, le qualità dispiegate hanno indotto il Papa a spostarlo nella sede più importante, e anche più calda, di Imola. La Romagna da decenni nutriva propositi di rivolta; il suo territorio, al pari di quello emiliano, era diviso in circoscrizioni provinciali, denominate Legazioni. Ciascuna era governata da un cardinale-legato, spesso identificato da repubblicani e patrioti come l’espressione di un potere occhiuto e straniero. Intendiamoci: si tratta di minoranze, ma sono quelle che, dopo lo sdoganamento a opera della Rivoluzione francese, hanno cominciato a permeare la nascente opinione pubblica. Il fallimento dell’ultima rivolta aveva però prodotto un vasto sconforto. L’insediamento di Mastai Ferretti ha coinciso, quindi, con una fase di stanca, di rassegnazione: attentati e complotti non incontravano più il favore dei tanti scontenti della pessima amministrazione romana. La soluzione è stata ricercata attraverso le riforme. La guida l’hanno assunta i moderati pronti a puntare sul dialogo con le autorità ecclesiastiche per giungere a un graduale cambiamento. Mastai Ferretti è stato lesto nel cogliere l’opportunità . Ha proseguito la politica del buon senso già applicata a Spoleto, condannato i metodi infami dei centurioni (i bravacci usati dalla polizia per compiti di bassa macelleria), smussato gli aspetti più ruvidi del governo papale, concesso una libertà di critica fin lì sconosciuta ai predecessori. A giudicarli con il metro odierno, sono stati piccoli accorgimenti tattici; sul momento, invece, hanno costituito una clamorosa rottura con il passato. L’arcivescovo ha registrato un notevole guadagno di popolarità : si è conquistato la nomea di liberale e la simpatia di quanti avrebbero ambito a liberarsi dalle redini del Papa Re. Nella sostanza è cambiato poco - l’ossessivo controllo poliziesco, le libertà individuali quasi inesistenti, la censura implacabile -, ma la semplice idea che se ne potesse parlare è servita ad accantonare qualsiasi ricorso alla forza. Si è scommesso sulle aspettative suscitate dal nuovo corso. Perfino Gregorio XVI è stupito dall’improvvisa bonaccia della sanguigna Romagna: il premio per Mastai Ferretti è stato il cappello cardinalizio a soli quarantotto anni. La quiete, tuttavia, è durata poco. Nel ’43 la carboneria ci ha riprovato. I cospiratori confidavano di creare un collegamento fra le sommosse di Salerno, regno borbonico delle Due Sicilie, e quelle di Bologna, cuore delle Legazioni. E’ andata male ovunque. La repressione dell’esercito pontificio è stata spietata. Si è combattuto con grave spargimento di sangue a Castel del Rio, a Savigno. L’8 settembre una schiera nutrita di rivoltosi ha marciato su Imola. Il piano era di prendere in ostaggio Mastai Ferretti e due cardinali di Ravenna, passerà alle cronache come l’operazione dei «tre cardellini». Gli alti prelati sono stati, però , allertati da una soffiata. Si sono messi in salvo, la loro popolarità è visibilmente aumenta. Anzi a Imola hanno considerato una sorta di oltraggio l’azione ai danni del proprio cardinale, indicato come il principale alleato del moderatismo. L’oppositore più conosciuto della zona, il conte Giuseppe Pasolini, ormai un sodale di Mastai Ferretti, ha raccontato agli amici sbigottiti che le preferenze politiche di sua eminenza erano rivolte ai due cugini piemontesi Cesare Balbo e Massimo d’Azeglio propugnatori di un’unità d’Italia da perseguire per via confederata, magari sotto l’alto patrocinio del Papa. Siamo più o meno dalle parti di Gioberti, che nel ’43 ha pubblicato il suo cervellotico Primato (titolo completo: Del primato morale e civile degli italiani), cui Balbo ha fatto seguire Le speranze d’Italia. Speranze alquanto singolari: consistevano nello spostare l’interesse e il peso dell’Austria sull’impero ottomano di modo che essa rinunciasse all’Italia e gli italiani unirla sulla base di trattative e di trattati. Insomma, senza pagare l’inevitabile prezzo di vite umane, su cui abitualmente nascono le Nazioni. Ma ciò che ha contato nel giudizio pubblico è stata l’attenzione di Mastai Ferretti alle discussioni e ai propositi miranti all’unità del Paese. Di conseguenza è stata con la fama di liberale che nel giugno del ’46 Mastai Ferretti ha presenziato alla sua prima elezione vaticana in seguito alla scomparsa di Gregorio XVI. Il Conclave è caduto in un periodo di notevoli fermenti alimentati dal libro di d’Azeglio, Degli ultimi casi di Romagna. Il marchese torinese, testimone diretto dei moti del ’43, li ha adoperati per sostenere due tesi: che l’Italia non si sarebbe fatta con i tumulti di piazza, bensì con un’unione di forze in grado di battersi contro l’oppressore e che simile unione non poteva essere affidata a un Papa responsabile di un regime dispotico. D’Azeglio ha scartato anche i re e i principi degli staterelli legati all’impero asburgico: per esclusione l’unico nome sul quale puntare è rimasto quello di Carlo Alberto, il monarca piemontese, le cui ambizioni di espansione territoriale erano direttamente proporzionali alla sua altezza, 204 centimetri, ma inversamente proporzionali allo spessore di sovrano e, ahilui, di comandante in capo. D’Azeglio il nome si è ben guardato dal farlo, tuttavia sul pallido e titubante erede dei Carignano, asceso al trono dei Savoia per un’incredibile serie di coincidenze, si sono appuntate la curiosità e le speranze dei patrioti. Formalmente guidava un regno con l’epicentro in Piemonte, le cui classi dirigenti si esprimevano in francese, eppure egli portava il titolo di re di Sardegna, visitata per obbligo due anni prima dell’incoronazione. E’ stato nominato in mancanza di eredi maschi del ramo principale della casa regnante, rappresentato da Vittorio Emanuele I e da Carlo Felice. Dopo averlo tenuto in bilico per anni, i due fratelli succedutisi sul trono l’hanno valutato il male minore, ma egli ha ritenuto di essere obbligato a proseguire l’opera dei predecessori, che avevano ingrandito l’originale ducato tra mance altrui (così sono arrivate la Liguria, Nizza, la Savoia) e baratti (la Sardegna acquisita in cambio della Sicilia). Carlo Alberto ha ignorato o non si è curato della caratteristica della dinastia: mai i Savoia hanno concluso una guerra con l’alleato assieme al quale l’hanno avviata. In quei frangenti ha sperato di sfruttare il corso degli eventi e di potersi ingrandire ulteriormente. Pensava già a un’Italia unita? Mah… Parlando della Romagna e dell’inutile spargimento di sangue, d’Azeglio ha tessuto le lodi del cardinale-legato di Forlì , Tommaso Pasquale Gizzi. Molti, dei pochi che leggono libri e hanno a cuore le sorti del Paese, l’hanno valutato il miglior candidato possibile al soglio. Gli stessi notabili romagnoli hanno stilato un documento di sostegno, in cui ci si è augurato che lo Spirito Santo illuminasse adeguatamente le Eminenze Reverendissime per una scelta così importante in una fase così delicata. Frasi ossequiose e nessun accenno a Gizzi per non urtare le suscettibilità e ancor più la severissima censura, che incombeva a tal da punto da indurre i firmatari a inviare l’appello con un messo privato. Utilizzando il servizio postale era scontato che il Collegio dei Cardinali non l’avrebbe ricevuto. Ecco spiegata, dunque, l’avversione a Gizzi di Metternich, cancelliere austriaco e quindi parecchio interessato al mantenimento dello statu quo, in cui il suo governo rappresenta l’ago della bilancia. Da secoli l’Austria, la Francia e la Spagna detengono un potere di veto sulla scelta del Pontefice. Ci vorrà la schiena dritta di Pio X, eletto nel 1903 grazie al veto austro-ungarico abbattutosi sul cardinale Rampolla, per revocare con la minaccia della scomunica l’anacronistico diritto. L’ascesa di Mastai Ferretti ha assai inquietato le cancellerie europee: nella suggestiva e falsa suddivisione dell’epoca Pio IX è stato ritenuto un progressista. E la nomina di Gizzi a segretario di Stato è sembrata l’annuncio di mutamenti epocali. Con l’immancabile senno del poi, diversi storici vi leggeranno un’anticipazione delle rivolte del ’48, capaci di scuotere il Vecchio Continente e di abbattere gli equilibri sanciti alla caduta di Napoleone. In realtà la sua nomina era legata all’inesperienza internazionale del Pontefice. Gizzi, invece, godeva di buon credito nelle capitali estere: a esso si accompagnava un vasto favore popolare, dal quale Pio IX è rimasto molto impressionato. Gizzi ha ispirato i primi provvedimenti, dettati da semplice buon senso, di cui il Papa ha goduto, quasi esterrefatto, gli entusiasmanti consensi. E’ persino capitato che i romani in festa abbiano staccato i cavalli e trascinato a braccia la sua carrozza. Le manifestazioni in favore di Pio IX hanno contagiato numerose piazze italiane. Il rappresentante di un potere, che da seicento anni si batteva per impedire l’unità del Paese, è stato trasformato dall’entusiasmo popolare nel suo bardo. Il Papa è apparso vittima del suo stesso successo: non se lo è spiegato, ma gli è piaciuto. Ha intuito che non sarà facile controllarlo, tuttavia si è sforzato d’incentivarlo. Sulle ali di un consenso, dove gli acclamanti hanno trasformato le proprie suggestioni in realtà , ogni decisione assunta in Vaticano si è tramutata nella prova della deriva liberale: dall’approntamento della guardia civica all’attenuazione della censura sui giornali; da un pizzico di tolleranza nei confronti degli ebrei alla formazione del municipio romano; dalla costruzione di una rete ferrata alla proposta di una lega doganale fra gli Stati della Penisola. Persino Gizzi, il presunto campione dei liberali, si è messo paura di tali esagerate aspettative e ha abbandonato la segreteria di Stato. L’ha sostituito il cardinale Ferretti, legatissimo al Papa. L’Austria si è preoccupata. Metternich ha paventato che i bollori di Roma mettessero in fibrillazione i domini del Nord Italia. A mo’ di ammonimento ha inviato un migliaio di soldati a Ferrara, in pieno territorio delle Legazioni. Era previsto da un antico accordo diplomatico, tuttavia ha suscitato la protesta ufficiale di Ferretti. A sostegno del Pontefice sono intervenuti anche i due simboli del patriottismo italico, mai teneri con preti e precetti, più atei che credenti: Pippo Mazzini, da oltre quindici anni esule per la fede in una Patria repubblicana, fondatore della Giovane Italia, e Peppino Garibaldi anch’egli ramingo, che in Sud America ha fatto le prove generali delle future battaglie nella Penisola. Ha conquistato proseliti ovunque il neo guelfismo (dalla famiglia bavarese Welfen favorevole nel XIII secolo al Pontefice) auspicato da Gioberti, canonico, ribelle controvoglia, autore del Primato morale e civile degli italiani, e incentivato da una visita a Roma di D’Azeglio, sempre fiducioso nel ruolo del Piemonte. Sulle facciate delle chiese è stato scritto W Pio IX. Allorché alla Cannobiana di Milano, l’attuale Teatro Lirico, durante uno spettacolo di beneficienza l’orchestra ha eseguito l’inno a Pio IX, il pubblico ha richiesto per cinque volte il bis. Sono echeggiate interminabili acclamazioni al Papa, all’amnistia, a Roma capitale. Il Viceré austriaco, l’arciduca Ranieri, ha capito l’antifona e lasciato la manifestazione. Mazzini ha fatto pervenire una lettera in Vaticano con la richiesta di un accordo per il bene della Nazione. A Bruxelles un congresso di economisti ha misteriosamente proclamato Pio IX il «più grande uomo del secolo». Gli unici a nutrire qualche dubbio sono stati gli ecclesiastici della curia fedelissimi all’eredità di Gregorio e contrarissimi a qualsiasi riforma. Nel nome del Pontefice il moderatismo ha guadagnato consensi ai danni delle due organizzazioni, che fin lì hanno tentato la via della rivolta armata: la Giovane Italia e la Carboneria (l’associazione segreta paramassonica fondata a Napoli e diffusasi nel resto della Penisola). Per le polizie di regni, granducati, ducati e dello stesso impero asburgico è diventato problematico perseguitare quanti invocavano un cambiamento pacifico sotto l’egida del Papa, fin lì rappresentante della conservazione più reazionaria. Incredibilmente il diavolo e l’acqua santa camminavano appaiati: molti si sono convinti di poter realizzare la rivoluzione con l’accordo degli sbirri. Era un clamoroso errore di prospettiva storica, ma grazie a questo errore migliaia di cittadini si sono impastati con un progetto, al quale fino al giorno prima erano rimasti insensibili. Pio IX ha assunto un atteggiamento molto severo nei confronti dell’Austria: la sua risposta alle manovre intimidatorie di Metternich è stata il definitivo via libera alla formazione della Guardia Civica. Immediatamente l’hanno pretesa a Firenze e a Torino assieme alle altre riforme concesse a Roma. Il tentennante Carlo Alberto, si è addirittura spinto a invocare la grazia divina di «poter un giorno intraprendere la guerra d’indipendenza e sarò io e io solo a prendere il comando dell’esercito». Dichiarazioni che non cancellano il ricordo dei tanti voltafaccia, i quali da un esordio quasi rivoluzionario l’hanno condotto su posizioni più che reazionarie per ascendere al trono. Ma non è soltanto il passato a giocargli contro: gli manca il carisma. La rigida educazione lo rende di scarsa empatia; è incapace di creare il minimo feeling con l’interlocutore. Insomma, ci si può entusiasmare per il Papa, e il risveglio sarà traumatico, mentre non si riesce a vincere l’innata diffidenza nei confronti del Carignano, che s’è fatto Savoia. Il boccino è dunque rimasto in mano al Pontefice: il suo più ascoltato consigliere ha lanciato la proposta di costituire una Lega italica sul modello dello Zollverein, con cui la Prussia stava unificando la Germania. Nei progetti sarebbe dovuto rimanere fuori il Lombardo-Veneto, provincia austriaca, ma nelle speranze veniva auspicato un ripensamento di Vienna con la concessione di una così larga autonomia da consentire l’inserimento nella Lega di quelle terre italianissime. Il Granduca di Toscana, Leopoldo II d’Asburgo-Lorena, ha aderito per primo, mentre Carlo Alberto è stato deluso dal contenuto federale della proposta: lui era per bandire la crociata della conquista nazionale nel desiderio, non tanto segreto, di poterne essere il campione designato. Fedele alla sua natura, il re ha nicchiato, ha tirato le trattative per lunghe, ma ha dovuto misurarsi con l’entusiasmo delle piazze appena gli spazientiti diplomatici del Vaticano hanno fatto trapelare l’ipotesi in discussione. Ai tanti scesi in piazza la Lega è apparsa la via più breve verso l’unità , paroletta magica, cui ciascuno ambiva in maniera diversa. Dinanzi alla prospettiva di restare isolato nel quadro delle alleanze e malvisto dall’opinione pubblica, Carlo Alberto ha dovuto accantonare le richieste commerciali, mercanteggiate dietro lo schermo degli alti ideali, e aderire. Alla fine l’accordo è stato firmato, ma soltanto da Piemonte, Toscana e Vaticano. A Napoli Ferdinando II, che aveva considerato l’elezione di Pio IX peggio di un dito nell’occhio, non ha voluto nemmeno sentirne parlare. Sotto il Po, tutto è stato rinviato al dopo Maria Luigia. A Vienna una riunione del gabinetto ristretto - l’imperatore Ferdinando I, Metternich, il presidente del consiglio di guerra Hardegg, il ministro del tesoro Kubeck - ha predisposto, nel luglio 1847, un pronto intervento militare in qualsiasi angolo del Belpaese e alla faccia della presunta indipendenza degli Stati coinvolti. Di conseguenza l’armata nel Lombardo-Veneto è stata accresciuta da 50 a 64 mila uomini, ma con il convincimento che per tenere a bada i velleitarismi degli irriducibili bastasse inasprire le misure poliziesche. Preservare la «pax austriaca» dalle insidie del nascente patriottismo italiano è stato valutato l’interesse primario. Metternich si era premurato di strappare un assenso preventivo alle grandi cancellerie europee, Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, sempre nel nome degli intangibili principi fissati dal Congresso di Vienna. E che risalissero a trentadue anni prima è stato ritenuto un trascurabile dettaglio In attesa del trapasso di Maria Luigia, Ludovico ha consegnato a Leopoldo il principato di Lucca e si è trasferito a Genova. Di suo avrebbe fatto anche a meno del ducato di Parma, ma gli serviva per pagare i notevoli debiti. Appena gli comunicano la notizia che la sua benefattrice ha tolto il disturbo, va di nascosto a Milano per conferire con il maresciallo Radetzky, comandante in capo dell’armata imperiale nel Lombardo-Veneto. Il secondo incontro l’ha con Francesco V, il duca di Modena, degno figlio di suo padre, ossessionato dall’assolutismo e dalla carboneria, favorevole a una confederazione degli Stati italiani presieduta dall’Austria. Ludovico ha voluto intendersi con Francesco sulle concessioni da elargire ai nuovi sudditi e con Radeztky sulla disponibilità di spedirgli qualche battaglione in caso di disordini. Ricevuti gli avalli, s’insedia nel ducato con il nome di Carlo II. La prima mossa è di acconsentire all’acquartieramento a Parma e a Piacenza di alcuni distaccamenti austriaci. Per riaffermare la potenza e la prepotenza dell’aquila asburgica nella Penisola Metternich stoppa anche le velleità di Pio IX e di Carlo Alberto di aiutare il granduca Leopoldo nella disputa territoriale con l’invadente Francesco, forte dell’appoggio asburgico. Ciascuno dei tre contraenti della Lega china il capo dinanzi alle minacce del cancelliere. Significa certificare l’inutilità pratica del loro progetto: nel momento decisivo l’interesse della propria bottega prevale sul presunto bene comune. Il personaggio da tener d’occhio è il solito, enigmatico, inattendibile Carlo Alberto: nel 1821 da reggente si era entusiasmato per i bollori rivoluzionari e aveva concesso la costituzione, ma al primo sbatter di tacchi s’era tirato indietro. Anzi, per cancellare ogni macchia, aveva accettato di andare in Spagna per combattere insieme ai reazionari di don Carlos: attentavano alla monarchia legittima, liberale, costituzionale di Maria Cristina, con la quale stavano tutti i fuorusciti italiani, pronti a immolarsi negli anni a venire per il Risorgimento. Lo stesso Carlo Alberto da monarca ha chiesto nel 1831 l’appoggio di Metternich per salvarsi dalle fiammate rivoluzionarie dei liberali e per respingere le pretese al trono di Francesco IV, il duca di Modena, che da marito di una Savoia sosteneva di poter vantare più diritti dell’erede di un ramo secondario com’erano i Carignano. E la Convenzione militare firmata dal regno di Sardegna con l’Austria è equivalsa a una dichiarata sottomissione. Ma sedici anni dopo, le ambiguità di Carlo Alberto sono sbocciate nell’adesione a una causa italiana, di cui non gli sono nemmeno chiari i contorni, però gli appare l’unica strada verso la gloria fin lì mancata. Indecisioni, marce indietro, ritrattazioni confermano che l’Italia sia un’entità geografica. Metternich, tuttavia, non ha tempo di gioire: risolti i problemi della successione di Maria Luigia, sussulti inquietanti provengono dal cuore del più importante dei possedimenti austriaci, Milano. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

