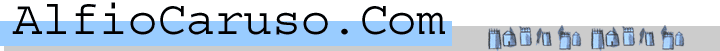
|
|
|
| - Primo capitolo - acquista il libro on line torna all’archivio Quella mattina di maggio 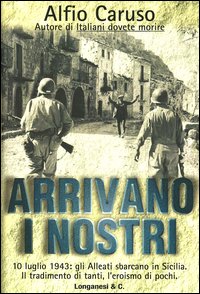 Giosuè appoggiò la doppietta al grosso albero di castagno ed estrasse dalla bisaccia lo spesso tovagliolo a quadratoni azzurri. Mentre lo apriva si diffuse il penetrante effluvio dell’aglio misto al profumo dell’olio invecchiato e delle olive che vi si erano macerate.
Giosuè appoggiò la doppietta al grosso albero di castagno ed estrasse dalla bisaccia lo spesso tovagliolo a quadratoni azzurri. Mentre lo apriva si diffuse il penetrante effluvio dell’aglio misto al profumo dell’olio invecchiato e delle olive che vi si erano macerate."Proprio ora?" chiese Pippo spazientito. Con il fucile a canne sovrapposte inquadrò la fetta di terreno fino a pochi secondi prima tenuta sotto mira dalla doppietta di Giosuè. "Alla fame non si comanda" rispose Giosuè addentando le due fette di pane casereccio guarnite con olio, aglio e olive. Le aveva preparate in casa che era ancora buio, attento persino ai sospiri: la cucina confinava con la stanza da letto dei genitori e il sonno di sua madre era come il foglio di carta velina. A contatto con la lama del coltello, la crosta del pane ormai vecchio di sei giorni aveva crocchiato. Giosuè si era fermato: vuoi vedere che la mamma… Per fortuna, niente. Le olive ’cunsate’ stavano nel panciuto barattolo di vetro, secondo ripiano della credenza. Erano la cura di suo padre preoccupato che il livello dell’olio superasse di un buon dito quelle delle olive. Non era preoccupazione da niente con il prezzo raggiunto dall’olio al mercato nero e con la crescente difficoltà di procurarselo, benché il paese fosse circondato da terrazze di uliveti. Giosuè era stato molto scrupoloso nel prelevare assieme alle olive una quantità minima di olio. Gli sembrava quasi di rubare alla famiglia, ma il turbamento era stato subito scacciato da ciò che aveva annusato: una fragranza che sapeva di sole, di vento, di terra morbida, di zagara. Almeno così sosteneva il suo professore di storia e filosofia al liceo classico di Adrano. A Giosuè, molto più semplicemente, sapeva di bontà, di solleticamento sul palato, di gioia che preparava un’altra gioia: il vino con cui spegnere il sapore asprigno rimasto in bocca e che a sua volta spianava la strada al prossimo morso. Ma il vino andava conquistato. Doveva versarlo dal bottiglione nella borraccia ed era ad altissimo rischio di rumore. Con la lingua Giosuè aveva pulito e ripulito il cucchiaio adoperato per le olive e gli era parso un anticipo delle delizie future. Poi con lo stesso cucchiaio aveva cominciato il travaso del vino fino a riempire la borraccia per un terzo, a quel punto si era spostato verso la porta e aveva completato l’opera direttamente, fino all’orlo del tappo. Con il vino si poteva anche esagerare: lo forniva zio Alfio, il papà di Pippo; proveniva da un vigneto a quasi mille metri, quattordici gradi uno più vero dell’altro, da far secco quanti non fossero abituati. Ma a Biancavilla dai sei anni in su erano tutti abituati. Quand’era uscito di casa il vecchio orologio a pendolo dell’ingresso segnava un quarto alle cinque. L’appuntamento con Pippo era all’abbeveratoio, appena oltre le ultime case sulla strada che s’inerpicava verso l’Etna. Si erano confusi in mezzo a gabellotti e braccianti diretti ai vigneti, ai castagneti, agli uliveti. Qualcuno a dorso di mulo, qualcuno a sospingere la bici che sarebbe servita al ritorno in discesa, molti a piedi. Uomini, donne, ragazzi confortati dall’aria tiepida di una primavera che già annunciava l’estate e dalla prospettiva che l’indomani sarebbe stata domenica e anche per loro avrebbe significato ventiquattr’ore di riposo. Dopo due chilometri Giosuè e Pippo avevano lasciato la lingua d’asfalto e si erano inoltrati per viottoli e sentieri. Le zone intorno all’Etna venivano ormai pattugliate dall’esercito alla ricerca di sabotatori, di spie, di agenti infiltrati, di accaparratori, di borsaneristi, di profittatori, di tutti i fantasmi, insomma, che la paventata invasione della Sicilia e l’agonia del regime fascista ingigantivano. Erano pattugliamenti saltuari, casuali, affidati alla buona volontà dei comandi e della truppa, ma Giosuè e Pippo avrebbero avuto problemi a giustificare i due fucili con i quali si accompagnavano. Magari non li avrebbero presi per quinte colonne degli anglo-americani, tuttavia nella migliore delle ipotesi i militari avrebbero sequestrato le armi e questo, al di là del danno economico, avrebbe significato la rinuncia alla caccia. Una rinuncia dolorosissima: per entrambi rappresentava lo svago principale assieme alle furtive visite al casino, considerato che dovevano ancora compiere diciott’anni. La modesta battuta di quel sabato 8 maggio 1943, alla ricerca di uccelli di passo e di qualche coniglio selvatico sfuggito alla fame dei contadini, rappresentava per Giosuè e Pippo il modo migliore di festeggiare la notizia sussurrata il giorno prima dal professore Gioacchino Biondi, il giovanissimo docente di latino e greco: con gli Alleati a un passo dalla Sicilia niente esami di licenza liceale. Addio all’incubo di tre anni, dunque promozione garantita per Giosuè e Pippo, che comunque avevano la media dell’8, e soprattutto vacanze anticipate. Allora, domattina si va a caccia aveva detto Pippo a Giosuè mentre la carrozzella percorreva i tre chilometri di vialone che univa Adrano a Biancavilla. Adesso erano lì nella postazione abituale sul poggio da cui dominavano il boschetto e la spianata, pronti a far fuoco su qualsiasi cosa si muovesse. In verità solo Pippo appariva pronto, Giosuè stava, infatti, combattendo con ottimi esiti la sua battaglia contro la fame: le due fette di pane con olive nere, aglio e olio erano sul punto di soccombere e lo stesso si poteva dire del vino nella borraccia. "Hai finito?" chiese Pippo. "Mi manca il ruttino" rispose Giosuè con un sorrisetto d’intesa. Pippo rimase di vedetta pregustando il momento in cui avrebbe attinto dal borsone in pelle stipato sin dalla sera prima. Era sovrappeso e felice di esserlo, la guerra non aveva interferito con le abitudini alimentari della sua famiglia. Il padre possedeva aranceti, vigneti, campi di grano, allevamenti di maiali, ma il colpo di fortuna erano diventati il mulino e il trappeto, gli unici in quei mesi a servire Biancavilla, Adrano e i dintorni. Pippo aveva portato una forma di pane fresco - a casa sua impastavano il martedì e il venerdì - pecorino con il pepe, salame, una bottiglia di vino e in più il dolce: due fette di sanguinaccio, una era per Giosuè. Il quale Giosuè se la prendeva comoda, ora si stava stiracchiando. Pippo decise che conigli e uccelli potevano continuare a spassarsela, lui avrebbe mangiato. Nell’aria immota del mattino il silenzio fu scalfito da un fruscio lento e regolare. Pippo e Giosuè si guardarono smarriti: vuoi vedere che ci hanno visti, ci hanno seguiti e stanno venendo a prenderci? Circondati e catturati dal regio esercito. Non solo la confisca dei fucili, ma anche gli sfottò degli amici, dei conoscenti, dell’intero Circolo Castriota, che raccoglieva la buona società di Biancavilla. Di morire dalla vergogna per i prossimi sei mesi, maledizione agli esami di licenza liceale e a chi li aveva annullati… Probabilmente furono la rabbia, la frustrazione, il senso d’impotenza a indurre Pippo a puntare il fucile verso il fruscio lento e regolare in avvicinamento sulla salitella sfociante sul poggio. Gli occhi di Pippo e di Giosuè vi si erano fissati in attesa del peggio, nemmeno badarono alle tre beccacce in transito a volo radente sulla spianata. Dapprima scorsero la mola, poi la ruota e il manubrio, infine un tipo di città, che per lo stupore di trovarsi a dieci metri da un fucile spianato si piantò all’istante. Stava irrigidito accanto alla bicicletta nel suo doppiopetto di lana autarchica e grigiolina. Portava una camicia bianca, cravatta fantasia, sandali a buon mercato e calzini beige. "Amici?" Chiese il tipo di città. "Ma voi siete davvero un arrotino?" Giosuè stentava a capacitarsi di ciò che vedeva. Il tipo di città esibì una sciolta parlantina: certo che era un arrotino, girava per campagne e paesi, aveva fatto Centuripe e Adrano, era diretto a Biancavilla e Licodia, tagliava attraverso i campi per evitare brutti incontri e nella speranza di trovare clienti nelle masserie. I ’carusi’ potevano garantirgli che si trovava nella direzione giusta verso Biancavilla? Pippo non capiva. Non capiva che cosa ci facesse un arrotino alle otto della mattina dove Dio aveva perso le scarpe. Non capiva perché un arrotino se ne andasse in giro agghindato come un damerino. E poi non capiva quel dialetto che all’apparenza era il loro, però aveva termini e suoni forestieri, un’inflessione che gli ricordava quella di Turidduzzu, il figlio del notaio di Enna suo compagno in terza elementare al collegio Capizzi di Bronte. Di modo che più Pippo non capiva, più non abbassava le canne sovrapposte del fucile, alle quali il tipo di città continuava a lanciare sguardi preoccupati. Tranquillizzato da Giosuè, l’arrotino ridiscese il dolce pendio del poggio e s’avvio sulla trazzera che dalle Vigne conduceva allo stradone prima dell’abbeveratoio di Biancavilla. Lo seguirono con i fucili in braccio finché non fu inghiottito da una macchia di arbusti. L’incontro mandò di traverso la giornata. Giosuè e Pippo tornarono in paese sicuri di avere incontrato un impostore, che tutto era fuorché ciò che diceva di essere. Domandarono al pizzicagnolo e al macellaio se si fosse presentato un arrotino. Mai visto. Non l’aveva visto don Peppino, che teneva le cassette di frutta e verdura dinanzi a casa, e neppure zia Concettina di postazione dall’alba al tramonto sulla sedia impagliata all’inizio di corso Vittorio Emanuele. Nei giorni a seguire, nell’andirivieni in calesse fra casa e scuola, l’enigmatica figura dell’arrotino occupò un posto fisso nelle elucubrazioni, e soprattutto nei rimpianti, di Giosuè e di Pippo. Rimpiangevano di non averlo perquisito, sicuri che avrebbero rinvenuto armi e mappe, rimpiangevano di non averlo trascinato fino alla caserma dei carabinieri, rimpiangevano di non averne scoperto la vera identità. Magari era un americano… A quella parola venivano trasportati in un mondo sconosciuto fatto di sigarette, di libertà, di grandi incontri con femmine meravigliose e con uomini ricchissimi come non se ne vedevano neanche a Catania. La rabbia di essersi fatti infinocchiare sfumava nel disappunto di aver mancato l’occasione di parlare con un americano autentico, non come quelli che erano rientrati a Biancavilla tra il ’40 e il ’41, incapaci persino di pronunciare good morning nonostante vent’anni di Brooklyn. Giosuè e Pippo conservarono nitido il ricordo dell’arrotino mentre l’euforia per l’abolizione degli esami di licenza si trasformava in preoccupazione per l’invasione dell’isola data per imminente. In giugno s’aggravarono i problemi dei rifornimenti e dei collegamenti con il resto del Paese, s’intensificarono i bombardamenti su Palermo, Catania e le altre città siciliane. Su Biancavilla cadde una sola bomba: centrò l’unica banca e mettendola fuori uso mise in ambasce i quindicimila abitanti, impossibilitati ad attingere ai depositi e di conseguenza senza il denaro necessario per procacciarsi al mercato nero il tanto che era sparito dalle tessere annonarie. Lo sbarco del 10 luglio, preceduto da un terrificante bombardamento di Catania - di cui a Biancavilla, distante oltre trenta chilometri, si udivano gli scoppi e si vedevano le colonne di fumo delle esplosioni e degli incendi -, riversò nelle campagne una marea di sfollati. Biancavilla fu abbandonata il 12 luglio. Pippo ebbe assegnato dal padre il compito di garantire che il mulino e il trappeto non interrompessero la produzione. Lui provvedeva muovendosi a cavallo: la qualcosa significava una totale indipendenza in tempi di generale costrizione. Nei rari posti di blocco soldati e carabinieri chiudevano un occhio dato che le pagnotte del rancio dipendevano dal mulino di don Alfio. In breve tempo Pippo fu a conoscenza di ogni segreto: in quale solaio si era rifugiato il gerarchetto con l’amante e in quale ovile stavano i tre aviatori inglesi abbattuti dalla contraerea di Paternò; sapeva che nel boschetto di Montalto erano accampati un pugno di marinai scappati da Augusta e che nella caverna della Pomici gli aderenti al Mis (Movimento indipendentista siciliano) avevano nascosto moschetti, pistole e bombe a mano. Pippo visse settimane indimenticabili, la sua stessa esistenza ne fu segnata. Durante una galoppata per rifornire di farina alcuni amici s’imbatté in una ragazza identica a Norma Shearer, la protagonista con Leslie Howard di un’acclamata trasposizione cinematografica di Romeo e Giulietta: sarebbe diventata sua moglie, la madre dei suoi figli e con lei avrebbe trascorso più di mezzo secolo. L’arrivo ad Adrano di un battaglione della divisione Goering aggiunse il brivido del pericolo. I tedeschi prima sparavano poi s’informavano, avevano voglia di razziare ed erano portati ad assimilare ogni civile a una spia degli inglesi, impegnati sul fiume Simeto a sfondare l’ultima resistenza prima di Messina. Catania cadde il 5 agosto, le avanguardie dell’8a armata raggiunsero Biancavilla il 6, la popolazione fece rientro l’8, domenica. Una settimana dopo - era ferragosto, ma nessuno ci badò - venne celebrata a mezzogiorno una messa solenne di ringraziamento. La Matrice era stracolma di fedeli. Pippo e Giosuè stavano seduti sui gradini a godersi il sole. Una pattuglia di soldati canadesi in assetto di combattimento vigilava dall’estremità occidentale della grande piazza. L’eccitazione di alcuni bambini annunciò l’arrivo di una jeep americana. Il conducente frenò di colpo in un nube di polvere, il passeggero che gli stava a fianco con un salto superò lo sportello. Indossava la divisa di capitano dell’esercito Usa. Giosuè attirò l’attenzione di Pippo: era l’arrotino. Anche lui li aveva riconosciuti. "Come va, carusi?" disse con un bel sorriso. Giosuè e Pippo s’alzarono in piedi e farfugliarono qualcosa d’incomprensibile. "Tu" disse ancora l’ufficiale indicando Pippo "quel giorno morivi dalla voglia di usare il tuo fucile. E avresti fatto male perché ti saresti giocato questo…" un pacchetto intonso di Lucky Strike venne lanciato con noncuranza e afferrato al volo da Giosuè. "Adesso che siamo amici, me la date un’informazione?" Giosuè e Pippo non chiedevano di meglio. "Mi sapete dire dove posso trovare padre Nino Arcidiacono?" Era il sacerdote che si occupava dei giovani dell’Azione Cattolica e che in quei giorni aveva appena chiesto a Pippo e al suo amico Nino se avevano voglia di partecipare alle riunioni preparatorie per la rinascita del partito cattolico, che si sarebbe chiamato Democrazia Cristiana. Il fervore e l’ascendente di padre Arcidiacono derivavano dall’esser stato fra i segretari di don Luigi Sturzo, il fondatore del Partito Popolare. Negli infuocati anni Venti padre Nino lo aveva rappresentato nella Sicilia orientale e dopo l’esilio a Londra imposto dal Vaticano ne aveva continuato l’opera politica. Padre Arcidiacono era rientrato nella natia Biancavilla ad attendere che la Storia facesse il suo corso. Il filo con don Sturzo non si era mai spezzato, neppure quando fra i due ci si era messo di mezzo l’Oceano Atlantico. Nel ’41 l’ostinato sacerdote di Caltagirone - discendente di Giuseppe Sturdza, un barone moldavo rifugiatosi a Odessa a metà del sedicesimo secolo e da qui trasmigrato a Catania - viveva a New York ed era entrato in contatto con gli ambienti dell’amministrazione Roosevelt. La sera in cui padre Arcidiacono aveva sussurrato ai ragazzi che don Luigi (Sturzo) stava con gli americani parecchie braccia si erano levate al cielo. Già nel ’42 molti siciliani, soprattutto tra quelli nati dopo la Grande Guerra, sentivano i cow boy molto più prossimi dei polentoni, che non erano semplicemente gli abitanti del Nord Italia, bensì quelli del Nord diventati fascisti. Giosuè spiegò al capitano che padre Arcidiacono era uno degli officianti la messa solenne, dunque bisognava avere pazienza. "Vabbe’, nell’attesa vado a dare un’occhiata." "Capitano" chiese Pippo "anche quel giorno cercavate padre Arcidiacono?" "L’amico tuo è un po’ curioso, no?…Un po’ troppo…" Giosuè, cui era stata rivolta la domanda, non seppe che cosa rispondere. "Paisà" disse il capitano a Pippo "lascia stare, è una storia lunga." Infatti era cominciata più di dieci anni prima. acquista il libro on line torna all’archivio |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

