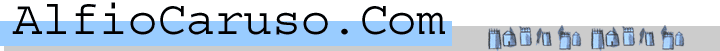
|
|
|
|
1
Ma dov’è Trieste?
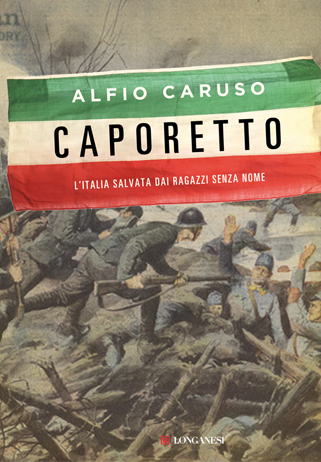 Le cartoline precetto arrivano a Biancavilla il 27 maggio: bianche per la fanteria, granate per i bersaglieri, verdi per gli alpini, gialle per gli artiglieri. Da tre giorni il regno d’Italia ha dichiarato guerra all’impero austro-ungarico. Per quanti hanno preso in mano qualche libro rappresenta il nemico storico del Risorgimento, che però in Sicilia conserva connotati alquanto confusi: se ne sa poco, quel poco è legato all’impresa dei Mille e questa ha lasciato intatti gli antichi equilibri di potere nell’isola. Cioè, nessuna differenza fra prima e dopo, fra il tempo dei Borboni e il tempo dei Savoia. Continuano a comandare i «galantuomini », che s’identificano con i latifondisti, con i proprietari delle miniere di zolfo, con i rarissimi imprenditori, tutti più o meno intrecciati alla massoneria e alla mafia. L’ha appena raccontato l’amarissimo romanzo di Luigi Pirandello, I vecchi e i giovani.
Le cartoline precetto arrivano a Biancavilla il 27 maggio: bianche per la fanteria, granate per i bersaglieri, verdi per gli alpini, gialle per gli artiglieri. Da tre giorni il regno d’Italia ha dichiarato guerra all’impero austro-ungarico. Per quanti hanno preso in mano qualche libro rappresenta il nemico storico del Risorgimento, che però in Sicilia conserva connotati alquanto confusi: se ne sa poco, quel poco è legato all’impresa dei Mille e questa ha lasciato intatti gli antichi equilibri di potere nell’isola. Cioè, nessuna differenza fra prima e dopo, fra il tempo dei Borboni e il tempo dei Savoia. Continuano a comandare i «galantuomini », che s’identificano con i latifondisti, con i proprietari delle miniere di zolfo, con i rarissimi imprenditori, tutti più o meno intrecciati alla massoneria e alla mafia. L’ha appena raccontato l’amarissimo romanzo di Luigi Pirandello, I vecchi e i giovani.Nell’ultima categoria rientrano Alfio e Ciccio, che il libro non l’hanno letto e che dei problemi dell’Italia se ne sbatterebbero, se non ricevessero l’ordine di andare in guerra. Alfio è figlio unico, ha ventidue anni, la quinta elementare e tanti piccioli, sotto forma di aranceti, ereditati dal padre morto vecchissimo all’inizio del secolo. Ciccio è il maggiore di sette fratelli, ha vent’anni, il diploma di maestro elementare, l’ambizione di diventare avvocato. E quindi da studente al secondo anno della facoltà di giurisprudenza sa benissimo dove si trovi Trieste, la cui conquista accoppiata a quella della meno conosciuta Trento, ha spinto diversi suoi colleghi universitari a occupare urlanti e minacciosi alcune piazze di Catania, la sede dell’ateneo, l’ingresso della prefettura. Alfio, che da anni lavora sotto i filari di alberi e che ha testa soltanto per le arance e per le gioie che possono procurare, niente invece sa di Trieste, della quale tutti parlano, mentre Trento e Gorizia, poverine, anche a Biancavilla sono circondante dall’indifferenza generale. Per farla breve: dove minchia sta Trieste? Alla vigilia della partenza Alfio entra con passo baldanzoso nell’unica rivendita di materiale scolastico del paese. Chiede di poter consultare un atlante, se lo ricorda dai tempi delle elementari. Lo sfoglia a casaccio finché il titolare non suggerisce di cercare Trieste attraverso l’indice dei nomi. Da l&ėgrave; è facile risalire alla pagina. Ecco la scritta in lettere gotiche indicante la città. Si affaccia sul mare chiamato Adriatico, appartiene all’impero d’Austria e Ungheria, ma il desiderio di tanti giovani, almeno cos&ėgrave; hanno spiegato a Alfio in quelle ore frenetiche, è che torni all’Italia, malgrado galleggi dal medio evo nella sfera d’influenza asburgica. L’individuazione di Trieste placa, comunque, l’ansia di Alfio. Adesso conosce il punto esatto, cui bisogna arrivare per vincere la guerra. E nel lungo viaggio della tradotta verso Verona scoprirà che pure moltissimi dei coscritti saliti in ognuna delle tante fermate ignorano dove sia Trieste. Nelle stesse ore Ciccio cerca di assicurarsi qualche garanzia sul futuro. Al seguito di Concettina, la formosa diciassettenne, cui si ritiene già promesso, si reca nella matrice, intitolata a Maria Santissima dell’Elemosina. Raggiunta la pala raffigurante la Madonna con il Bambino, Concettina pone nel ripiano alle spalle la foto in ghingheri di Ciccio. Con voce rotta dalla commozione mormora: «Ve l’affido, Madonnina bella», mentre l’oggetto della raccomandazione si guarda intorno, preoccupato che qualcuno possa scorgere i maneggi di Concettina. Alfio e Ciccio ancora non lo sanno, ma sul loro destino incideranno anche il censo e l’ambizione. L’agiatezza ha infatti indotto Alfio a procurarsi il giocattolo più ambito e più alla moda, un’automobile. L’estate precedente la prima vettura è apparsa lungo le strade polverose di Biancavilla fin l&ėgrave; solcate da calessi, cavalli, muli, asini, greggi di pecore e capre durante la transumanza. Alfio ha acquistato, attraverso la concessionaria stanziata a Palermo, una Lancia Theta decapottabile, recapitata sotto casa dopo un’attesa lunga mesi da un autista, che ha fornito pure i primi rudimenti di guida. Alfio in seguito si è procurato la patente, merce rara nell’Italia del 1915 e della quale l’esercito va in caccia per far funzionare gli autoreparti di recente costituzione. Di conseguenza Alfio è subito preposto alla guida dei Fiat 15 Ter, i camion dell’intendenza. Un incarico di tutta tranquillità, lontano dai pericoli della prima linea, dall’inferno delle trincee, dalle mattanze degli assalti. Al contrario, Ciccio sconta paradossalmente i sacrifici della famiglia per farlo studiare. Gli studenti universitari sono inviati all’Accademia di Modena, la fucina degli ufficiali. Tre mesi di corso, la nomina a sottotenente, l’immediata destinazione in prima linea. Ciccio lo spediscono sul Carso. Ma dopo nove mesi di saggia neutralità che cosa spinge l’Italia a ficcarsi dentro una guerra già ferocissima, per di più accanto ai presunti nemici e contro i presunti amici di una politica estera trentennale? Dal 1882 siamo stati accolti dalla Germania e dall’Austria-Ungheria dentro la Duplice Alleanza, che si è quindi trasformata in Triplice. La marcia di avvicinamento ai due Imperi era cominciata con il non intervento dell’Italia nella guerra del ’70 tra la Francia e la Prussia. Malgrado i fremiti e le manovre di Vittorio Emanuele II per restituire a Napoleone III il favore del ’59, il governo Lanza aveva rifiutato di aiutare il primo protagonista dell’unità nazionale. Lanza era un medico monferrino, figlio di un fabbro, espressione della piccola borghesia ansiosa di affacciarsi sul palcoscenico della grande politica: probabilmente avrebbe ceduto alle insistenze, alle lusinghe, all’aura di Vittorio Emanuele, se non fosse stato sostenuto da Sella e da Visconti Venosta, l’uno ministro delle Finanze, l’altro degli Esteri, probabilmente i migliori della nostra Storia, entrambi molto attenti alle esigenze del proprio ruolo. Sella escludeva che il giovane Regno potesse sopportare i costi economici di un’altra guerra, dopo il disastro del ’66; Visconti Venosta escludeva che la Francia potesse vincere e soprattutto aveva già patteggiato con Bismarck la ricompensa della neutralità: l’annessione di Roma come capitale del Regno. Visconti Venosta aveva visto bene: le armate del feldmaresciallo von Moltke avevano squinternato in pochi mesi l’esercito transalpino; il 18 gennaio ’71 nelle sale di Versailles Guglielmo I era stato proclamato imperatore della Germania riunita. La Francia repubblicana sorta dalle ceneri dell’Impero non aveva perdonato il pragmatismo dell’Italia, «questa Nazione creata dall’infelice cecità di Napoleone», nella definizione del presidente Thiers. Nemmeno il successo epocale della Sinistra di De Pretis aveva mutato il comportamento del nostro ministero. Anzi, l’occupazione francese della Tunisia nel 1880 aveva acuito un generale desiderio di rivalsa, benché potessimo incolpare dapprima le titubanze del capo di governo Cairoli, di fronte all’iniziale offerta di Bismarck di prenderla noi, e in seguito i traccheggi del console italiano a Tunisi inarrestabile nell’accendere una guerra personale contro il collega transalpino. Nell’Europa, in cui i nemici dei propri nemici contavano più degli amici, Bismarck aveva tessuto la trama per parare l’antica ossessione tedesca di un accerchiamento franco-russo. Era cos&ėgrave; riuscito a divenire l’arbitro dell’accordo fra due nemici storici: gli Asburgo e i Savoia. Ma molte parole risultavano scritte sulla sabbia. Francesco Giuseppe imperatore di Austria e Ungheria - dal 1867 formavano una Duplice Monarchia distinta fra Vienna e Budapest e con pari diritti - non perdonava a Vittorio Emanuele di essere assurto a re di un’Italia formata in gran parte con territori sottrattigli. E Vittorio Emanuele ambiva a sottrargliene altri per completare il processo di unificazione. Neppure il tempo di far asciugare l’inchiostro del trattato, in cui ciascuno dei contraenti s’impegnava a prestare soccorso in caso di aggressione, che il suddito austriaco Guglielmo Oberdan, nato Wilhelm Oberdank a Trieste, veniva impiccato per aver affermato di voler attentare a Francesco Giuseppe durante la visita in città. Un altro abile ministro degli Esteri, il conte torinese Di Robilant, era riuscito nell’87 a rinnovare il patto. Sfruttando i quindici anni trascorsi da ambasciatore a Vienna e la nomea di austriacante aveva ottenuto di migliorare l’intesa attraverso due trattati separati. Il primo obbligava la Germania a intervenire in favore dell’Italia, se questa si fosse opposta all’iniziativa della Francia in Marocco o in Tripolitania; il secondo obbligava l’Austria a non modificare l’assetto dei Balcani, dopo la recente occupazione della Bosnia Erzegovina, a meno di non concedere «soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate» dell’Italia. In parole povere, un qualche compenso in Trentino o nella Venezia Giulia. Con il che erano serviti i prodromi del futuro voltafaccia. Lo sviluppo del Paese ha vissuto a cavallo del nuovo secolo una fase caotica. Abbiamo pagato, in tutti i sensi, l’enormità delle spese militari: dall’unità all’ingresso nella prima guerra mondiale hanno rappresentato il 23,7 del bilancio statale, la voce più alta delle uscite, più di quanto sia stato speso per istruzione, giustizia, lavori pubblici, amministrazione, sanità, sviluppo. E nonostante tale sciupio, è fallita l’espansione in Africa, costellata da inutili stragi: si è cominciato a Dogali, si è finito ad Adua. La ricaduta principale ha significato non provare nemmeno a risolvere i problemi di sopravvivenza del Meridione, dell’agro pontino, della «bassa» tra la Romagna e il Polesine. Fortunatamente la ripresa dell’Europa ha favorito anche quella della Penisola grazie alla nascita di due moderne banche - la Commerciale a Milano, il Credito Italiano a Genova - e agli investimenti, che sono stati capaci d’indirizzare verso la nascente energia elettrica. Tale timido ingresso nella modernità si è potuto ascrivere all’appartenenza alla Triplice, per il resto assai avara di vantaggi. E’ stato Crispi nel ’94, nel pieno della crisi economica causata dal fallimento della Banca Romana, a chiedere aiuto all’amico e protettore Bismarck. Malgrado non fosse più cancelliere, il «conte di ferro» ha persuaso alcuni finanzieri tedeschi a incanalare un po’ di capitali nella nascita dei due istituti di credito. Tuttavia il mattatore del periodo è stato l’anti mattatore per eccellenza della nostra politica, Giovanni Giolitti, nato a Mondov&ėgrave;, cresciuto a Torino, silenzioso testimone delle passeggiate serali dello zio con Cavour. Laureato a diciannove anni, a venti l’avevano già chiamato nella macchina statale alle prese con gli enormi problemi dell’unità. Ruvido, introverso, onesto, però abilissimo nello sfruttare le disonestà altrui («il ministro della mala vita» lo definirà Salvemini), si è impratichito con Sella, di cui è stato il burocrate di fiducia, i due si parlavano in dialetto. A segnalarlo a re Umberto un altro piemontese di rango, Urbanino Rattazzi, gran ciambellano di corte e nipote del famoso Urbano: insediato nel maggio ’92, il primo governo di Giolitti, il primo anche privo di benemerenze risorgimentali, è durato diciotto mesi. L’ha mandato per aria l’affaire della Banca Romana, malgrado le implicazioni di Giolitti fossero nettamente inferiori a quelle di Crispi, che pure ne ha inizialmente beneficiato. Per tornare al potere Giolitti ha impiegato dieci anni destreggiandosi fra la crescita del partito socialista, scioperi generali compresi, e l’ingresso nell’arena politica dei cattolici. Per altri dieci anni ha guidato le sorti del ministero, anche quando ne è stato formalmente al di fuori. Dopo mezzo secolo di maggioranze personali, di morte delle ideologie e dei partiti, di Parlamento diviso tra una gran massa di governativi e una sparuta minoranza di oppositori, Giolitti si è dovuto misurare con il ritorno dei grandi movimenti popolari. Sotto di lui il Paese ha definitivamente superato la recessione, ha registrato, assieme alla Russia, il più alto tasso di crescita, ha pareggiato il bilancio, ha avviato una forte industrializzazione. E se le circostanze l’hanno favorito proiettandolo al centro di una fase espansionistica, di suo ci ha messo la considerevole attenzione alle condizioni degli ultimi. L’hanno sancita il riconoscimento dello sciopero, quale legittima forma di dialettica sociale, e il suffragio universale, ovviamente riservato ai maschietti. In tanto frenetico cambiamento l’Italia si è mantenuta fedele alla Triplice per mancanza di alternative. Gli sgarbi della Francia, dalle restrizioni doganali alla politica internazionale, non ne hanno consentito l’abbandono. Eppure nel 1903, un anno dopo aver rinnovato l’Alleanza, il cancelliere germanico von Bulow ha pronosticato a sua suocera, che era la vedova dell’ex presidente del consiglio Minghetti: «L’Italia dovrà scegliere molto presto fra il matrimonio e il concubinaggio». Si riferiva alle tresche del premier Zanardelli e del ministro degli Esteri Prinetti con l’ambasciatore francese a Roma, Barrere. In ballo ancora l’Africa, le nostre pretese di allargare i modesti possedimenti. Da ex protagonista delle «dieci giornate» di Brescia, Zanardelli ha portato nelle trattative con Barrere il vecchio piglio anti austriaco: l’interlocutore ne è rimasto colpito, ha intravisto uno spazio di manovra. E’ stata raggiunta un’intesa: l’Italia avrebbe lasciato mano libera alla Francia in Marocco e la Francia avrebbe lasciato mano libera all’Italia nelle due province dell’impero ottomano in disfacimento, la Tripolitania e la Cirenaica, l’attuale Libia, la mitica «quarta sponda» del Mediterraneo. Nel giudizio dei tedeschi ha continuato a pesare l’antica battuta di Bismarck: «Gl’italiani hanno pessimi denti, ma eccellente appetito». Questi turbinosi giri di valzer - anche di tale azzeccata definizione siamo debitori a von Bulow - sono stati subito indicati dai nostri partner vicini e lontani come una specialità della casa. Purtroppo non rappresentavano un complimento. Francia, Gran Bretagna e Russia ci hanno tenuti a distanza per manifesta adesione al fronte avverso. Ma anche Germania e Austria-Ungheria hanno aumentato la diffidenza nei nostri confronti, per eccesso di trasporto verso i rivali, e in certe occasioni avrebbero avuto voglia d’infliggerci una lezione. E’ capitato durante la conferenza internazionale di Algeciras, convocata in tutta fretta all’inizio del 1906 per scongiurare il conflitto tra i due blocchi, di nuovo a causa a del Marocco. Il Kaiser Guglielmo II era infatti sbarcato a Tangeri e aveva dichiarato il proprio interesse per quelle invitanti spiagge assolate. Nuovo ministro degli Esteri era il marchese di San Giuliano, assai apprezzato dalla nobiltà britannica, però filo tedesco. Ad Algeciras siamo stati rappresentati dall’ottantenne Visconti Venosta: si è impadronito del ruolo di mediatore, l’ha adoperato con scaltrezza per allestire un compromesso, che all’apparenza ha lasciato la situazione intatta, invece ha dato via libera alle ambizioni francesi. E Guglielmo l’ha capito bene: all’ambasciatore austriaco ha confidato che non vedeva l’ora di farcela pagare. La Triplice è stata rinnovata più per forza d’inerzia che per sincero convincimento dei soci. Ha molto traballato nel 1908 con l’annessione austro-ungarica della Bosnia: a dispetto di quanto sottoscritto nel 1887, l’Italia non ha ricevuto alcuna «soddisfazione». Francesco Giuseppe si è tenuto ben stretti il Trentino e la Venezia Giulia senza mollare alcun centimetro. Anzi il capo di stato maggiore von Hotzendorf, coltivatore di una profondissima avversione nei nostri confronti maturata negli anni di servizio fra Bolzano e Trieste, ha proposto, dopo il terremoto di Messina, una spedizione punitiva (Strafexpedition) a prevenzione dei futuri, e per lui immancabili, tradimenti. L’imperatore se n’è stupito, fin l&ėgrave; l’assillo di Hotzendorf era stata la Serbia, e preoccupato: per evitare complicazioni internazionali l’ha sollevato dall’incarico. Più che con il parlamento Giolitti ha dovuto fare i conti con l’opinione pubblica aizzata da Gabriele D’Annunzio. La sua velocità nell’abbracciare il sentimento comune diventandone il trascinatore, in barba a qualsiasi coerenza, ha cancellato gli accesi precedenti di pacifista e di anti colonialista: il nascente nazionalismo poggiato sulla prevalenza dell’uomo bianco ha trovato il coniatore di slogan e di frasi a effetto indispensabili nell’eccitare le folle. Sulla scia di D’Annunzio si sono posti il padre del futurismo, Marinetti, e un modesto intellettuale fiorentino, Corradini, sempre a rimorchio delle idee altrui, ma abile nell’estrarre l’occorrente del momento: «l’imperialismo operaio», il «posto al sole», lo sprezzamento della democrazia, le «plutocrazie» da combattere, l’autarchia, il protezionismo, le leggi antisciopero. Hanno rappresentato il frutto dell’indigesto frullato, nel quale Mussolini pescherà a piene mani. In attesa di scoprire l’irredentismo, derivato da un atteggiamento parecchio arcigno di Vienna nei confronti dei sudditi italiani, la crescente ansia di grandezza è stata di nuovo rivolta verso l’Africa, verso le colonie. Bisognava soddisfare il legittimo desiderio di benessere delle classi più umili e la necessità di trovare un mercato all’industria in sboccio, il tutto ammantato dal diffuso e ribollente desiderio di vendicare le numerose sconfitte militari. Rientrato in personale possesso della barra governativa, Giolitti non ha potuto prescindere dagli umori dell’opinione pubblica. A stimolarli ulteriormente, un’altra mossa azzardata del Kaiser: l’invio di un incrociatore nel porto di Agadir in replica all’occupazione francese del Marocco. Giolitti scriverà nelle memorie che era stata l’ultima occasione per l’Italia di far valere i propri interessi coloniali. La Tripolitania e la Cirenaica rappresentavano l’estremo lembo disponibile. L’avventatezza di Guglielmo II ha consentito di chiedere alla Francia l’ottemperanza delle intese Zanardelli-Barrere; le aderenze e il prestigio di San Giuliano a Berlino hanno garantito il tacito assenso tedesco. L’ultimatum inviato dal governo italiano a Costantinopoli - con il sofferto s&ėgrave; della massoneria, che aveva da poco ricevuto il permesso di aprire logge all’ombra della Sublime Porta -, ha scatenato l’entusiastica adesione delle persone comuni oltre che dei poeti, dei santi, dei navigatori, degli aspiranti eroi. Il poeta ispiratore di tanta gioventù, Giovanni Pascoli, nazionalista, socialista e gran massone, ha ideato lo slogan più azzeccato: «La grande proletaria si è mossa», e l’implacabile Corradini glielo ruberà. Tutti hanno finto di non accorgersi che l’ultimatum fosse infondato e tracotante. L’esaltazione ha resistito anche alle immediate difficoltà del corpo di spedizione, nonostante contasse 50.000 uomini bene armati ed equipaggiati, di fronte a una richiesta dello Stato maggiore di 20.000 soldati. Alla resistenza della sparuta guarnigione turca si sono uniti gli indigeni inferociti dalle inutili rappresaglie di chi, presentatosi come liberatore, si era presto tramutato in sanguinario invasore. Dopo un anno di combattimenti sono state occupate soltanto le zone costiere della Tripolitania e della Cirenaica. L’incapacità di avanzare verso l’interno ha persuaso Giolitti a un’azione diretta contro la Turchia. Ma per muoversi occorreva il placet dei due partner della Triplice, molto sensibili alle sorti dell’impero ottomano in funzione anti russa. San Giuliano si è superato nel procurare l’assenso della Germania all’incursione navale nel Dodecaneso e nel convincere i plenipotenziari austriaci che il medesimo Dodecaneso non fosse in Europa, bens&ėgrave; in Asia quindi non sarebbe stato toccato il delicato quadro d’insieme continentale. L’imperversare delle nostre corazzate nello stretto dei Dardanelli, l’occupazione di un bel mazzo d’isole, l’aver ridestato gli spiriti patriottici di Grecia, Serbia, Bulgaria e Montenegro contro la Turchia hanno riesumato l’avvizzito orgoglio guerresco degli italiani. Poco ha contato che siano dovuti intervenire i rappresentanti di Guglielmo II e di Francesco Giuseppe per costringere il Sultano a firmare la pace con l’Italia e che la modesta impresa abbia dissestato il bilancio. A pesare è stata l’inebriante sensazione di esser tornati al centro della Storia e di esserci tornati mostrando i muscoli. Inevitabile il richiamo alle glorie di Roma e dei colli fatali. Altro materiale al quale Mussolini attingerà. I problemi causati dall’Italia ai suoi trentennali alleati hanno convinto Parigi e Londra che fosse più conveniente per l’Intesa averla all’interno della Triplice che fuori. Paul Cambon, ambasciatore francese in Gran Bretagna, ha scritto al primo ministro Poincaré che eravamo «un alleato più ingombrante che utile». D’altronde il presunto trionfatore, cioè Giolitti, è stato punito alle elezioni di fine 1913, quando si attendeva di raccogliere i frutti dell’impresa libica, spacciata per felicemente conclusa, benché non lo fosse. La sua trasformistica maggioranza ha pagato pegno nei confronti dei radicali e dei socialisti, che hanno espulso l’ala riformista. L’introduzione del suffragio universale, con la platea di votanti passata da 500.000 a 8 milioni, ha paralizzato l’abituale influenza dei prefetti. Questa significava l’influenza del governo e in ultima analisi di Giolitti, che su tale controllo aveva basato il suo successo di leader privo di un partito. L’uscita dei radicali dalla coalizione governativa ha spinto Giolitti a tirarsi da parte nel convincimento che avrebbe continuato a guidare l’opera del successore per poi ripresentarsi sul proscenio al momento per lui opportuno. Non è andata esattamente cos&ėgrave;. E non perché il successore Salandra abbia dimostrato qualità inattese, bens&ėgrave; per l’improvvida testardaggine del principe ereditario d’Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando, in visita con la consorte a Sarajevo, il 28 giugno 1914. Sfuggito al lancio di una bomba, anziché allontanarsi, ha deciso di visitare i feriti in ospedale. L’autista ha sbagliato percorso: in tal modo Francesco Ferdinando e la moglie sono finiti sull’auto scoperta a pochi metri dalla pistola di Gavrilo Princip. Era uno studente militante nella «Giovane Bosnia» raggruppamento mirante alla riunificazione di tutti gli jugoslavi (gli slavi del sud) in stretto contatto con la Serbia. I due colpi della Browning di Princip hanno mortalmente ferito l’arciduca e la moglie. Francesco Ferdinando ha scontato la fama di protettore degli slavi e il progetto di costituire, una volta salito al trono, una terza entità statuale da affiancare all’Austria e all’Ungheria. Un pericolo agli occhi della «Mano Nera», il movimento guidato dal capo dei servizi segreti di Belgrado, Dragutin Dimitrijevic, detto Apis, e aspirante alla costituzione di una Nazione jugoslava. Da qui l’ispessirsi dei rapporti con i patrioti della «Giovane Bosnia». L’attentato ha messo in fibrillazione governi e alti comandi. Per molti versi è equivalso all’attentato dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York. Ha rotto l’apparente esistenza spensierata dei popoli e l’imponente mole di trattati, che dovrebbero garantirla. Alla fine è stato usato per regolare vecchi conti. Nessuno poteva immaginare che le sue impreviste conseguenze avrebbero modellato un nuovo mondo. Tre giorni dopo Alberto Pollio, il capo di stato maggiore italiano, è stato stroncato da un infarto. Malgrado i conosciuti problemi di cuore, in Germania hanno sospettato che il decesso del generale non fosse avvenuto per cause naturali, ma che egli avesse scontato la nota fedeltà alla «Dreibund» (Triplice Alleanza). Dunque, un ostacolo da rimuovere per trasportare l’Italia sull’altro lato della barricata. Pollio mai aveva nascosto le sue preferenze, gli ottimi rapporti coltivati con i parigrado von Moltke (nipote del famoso generale trionfatore nel 1870) e von Hotzendorf, risalito in sella. Soltanto nell’estate del ’13, durante i sussulti balcanici, Pollio si era trovato in disaccordo con gli alleati, in particolar modo con von Hotzendorf: dai vertici dell’esercito erano trapelate l’insofferenza del comandante in capo e la sua richiesta di preparare il piano per la guerra contro l’Austria. Una nube passeggera in un cielo sempre azzurrissimo. Per le usanze italiane Pollio era giunto abbastanza giovane (56 anni) all’apice della carriera. La sua nomina nel 1908 era scaturita dalla doppia bocciatura di Cadorna, di due anni più anziano, mai impegnato in un’azione bellica, con credenziali esclusivamente di scrivania, che lo dipingevano come il candidato naturale. Il primo no l’aveva pronunciato Giolitti, cui Montanelli attribuisce una di quelle frasi, che anche se non fossero vere, poco importa, tanto sono efficaci: «Conosco Cadorna. Ma appunto perché lo conosco, gli preferisco Pollio, che non conosco», ma secondo le malelingue, conosceva, e non poco, la moglie. Il secondo no, quello definitivo, era stato pronunciato da Vittorio Emanuele III, il quale sulle questioni militari pretendeva una sorta di primazia e di conseguenza non aveva gradito la condizione posta da Cadorna: in caso di guerra, il re conservasse pure tutti i pennacchi, ma la responsabilità totale, senza limitazioni di sorta, poteva essere soltanto sua. Cos&ėgrave; era stato designato Pollio, il terzo capo di stato maggiore, su quattro, a uscire dal celebrato collegio della Nunziatella, cioè dalla fucina di ufficiali fondata dai Borboni. E al pari di Cosenz e di Primerano, i primi due comandanti, pure Pollio era campano. Fin l&ėgrave; il torinese Scaletta aveva costituito l’eccezione: motivo in più per stupirsi che un Savoia l’avesse preferito al piemontese Cadorna, figlio del generale conquistatore di Roma nel 1870 ed espressione di una tradizione sempre sollecita nel vantarsi di aver fatto militarmente l’Italia. Non era vero, tuttavia costituiva bagaglio professionale. Quello di Pollio era di prim’ordine senza dover ricorrere ai sotterfugi della consorteria. Gli studi sull’epoca napoleonica, il libro sulla battaglia di Waterloo gli erano valsi una bella nomea anche all’estero. Di suo ci aveva aggiunto la flessibilità di ogni strategia, l’aver inteso l’importanza crescente delle artiglierie. Convinto estimatore del militarismo prussiano, aveva accentuato la propensione per gli Imperi Centrali con l’incarico all’ambasciata di Vienna e le nozze con un’aristocratica austriaca, accusata di coltivare troppe amicizie maschili e nel mazzo figuravano pure un paio di spioni casalinghi. Durante la fase acuta della crisi a Pollio era venuto naturale suggerire a von Moltke e a von Hotzendorf un attacco preventivo: «In piena sintonia con il vostro grande re Federico, quando nel 1756 spezzò il cerchio ferreo dei suoi avversari, perché non cominciamo noi adesso questa guerra inevitabile?». E per avvalorare l’indicazione che la Triplice dovesse «agire in guerra come un unico Stato», Pollio aveva accettato l’ipotesi del trasferimento ferroviario delle divisioni italiane sino al confine renano: qui il blitz contro la Francia architettato nel 1905 dallo stato maggiore tedesco (piano Schlieffen) aveva previsto il loro schieramento in sostegno dell’ala sinistra. Nessuno, neppure Vittorio Emanuele, l’aveva avvisato, che dai tempi di Prinetti e Barrere ci tenevamo aperta anche l’altra porta. Von Moltke si era entusiasmato per le intenzioni di Pollio, tuttavia il suo entourage l’aveva invitato a non confondere il generale con i connazionali: «L’eccellente capo di Stato maggiore italiano è una grande mente, un uomo affidabile. Ma fino a quando durerà la sua influenza? La nuova Italia sinora ha sempre fatto i suoi affari con le vittorie degli altri». Il segretario particolare del cancelliere von Bethmann, Kurt Riezler, aveva rincarato la diffidenza: «Molto improbabile che l’Italia mantenga i suoi impegni, a meno che a lungo andare la nostra vittoria sia sicura o la ritenga tale». Ecco perché la perdita di un amico fidato ha indotto i tedeschi a immaginare un complotto contro di loro. Viceversa il primo atto di Cadorna, inevitabile successore di Pollio, è stato d’inviare una lettera a von Moltke, in cui ha ribadito la lealtà italiana. Per conferire maggiore forza alla propria affermazione anche Cadorna ha predisposto il trasporto in Germania di un’armata. Come accaduto con Pollio, nessuno l’ha avvertito di quanto bolliva in pentola. D’altronde, il re ha subito la nomina: i curricula non offrivano altro. Non l’essersi mosso dall’ufficio aveva evitato a Cadorna le macchie africane, che imbrattavano il pedigree dei possibili concorrenti. E un imbronciato Vittorio Emanuele ha dovuto perfino riconoscergli i pieni poteri bocciati sei anni prima. All’ingresso in guerra Cadorna lo ricambierà con la consueta arroganza: quello che ovunque è il Quartier Generale diventerà nei bollettini il Comando Supremo, quasi uno schiaffo al sovrano, cui compete il comando supremo di tutte le forze armate. A Vienna hanno considerato il doppio omicidio di Sarajevo la prova definitiva degli intrighi serbi per disgregare la Duplice Monarchia. Le tre settimane riservate all’accurata indagine sono servite per verificare che la Germania avrebbe onorato la sua alleanza militare e per convincere lo scettico conte ungherese Tisza, capo del governo magiaro. Il 24 luglio l’Austria-Ungheria ha inviato un ultimatum pesantissimo alle autorità di Belgrado: venivano lasciate soltanto 48 ore per la risposta. Lo stesso giorno, dopo un incontro riservato con Pio X e il segretario di Stato, cardinale Merry del Val, Otto von Ritter, ministro della Baviera presso la Santa Sede, ha spedito il seguente telegramma: «Il Papa approva l’azione vigorosa dell’Austria contro la Serbia e, in caso di guerra contro la Russia, ritiene che le armate, sia russe sia francesi, non siano di livello elevato. Il Cardinale Segretario di Stato spera anche che l’Austria questa volta tenga duro». Il Vaticano era preoccupato dalla politica russa nei Balcani: temeva che avrebbe favorito i cristiani ortodossi a danno dei cattolici; era convinto che l’Austria rappresentasse il più efficace dei baluardi; intravedeva nelle scelte della Gran Bretagna e della Francia l’interventismo massonico e quindi assegnava agl’Imperi Centrali il compito di proteggere gl’interessi della Chiesa dimenticando, opportunamente, che la maggioranza tedesca fosse protestante. Dei dieci punti la Serbia ne ha accettato la gran parte, si è mostrata disponibile pure dove ha espresso qualche riserva, ma al fondo è rimasto il sapore della sfida, figlio del ripetuto sostegno russo. L’influenza del ministro degli Esteri, Sergej Sazonov, ha infatti trascinato lo zar Nicola II e l’accomodante governo su posizioni oltranziste. Le stesse di von Sturgkh e di von Hotzendorf. Si è rassegnato pure l’84enne Francesco Giuseppe. La guerra è stata decisa quasi a cuor leggero nella capitale più affascinante d’Europa, da dieci anni crogiolo di civiltà e di culture, dai valzer travolgenti di Strauss alle teorie spiazzanti di Freud. Ogni giorno nei suoi caffè, nei suoi teatri, nei suoi viali alberati si alzavano inni alla felicità della vita: talenti di ogni Continente ne erano attratti, a eccezione del giovane Adolf Hitler respinto e indotto ad abbandonarla. Purtroppo tutti erano convinti che sarebbe stata una scaramuccia, che con poche schioppettate e in breve tempo si sarebbe tornati a celebrare i riti della Belle Epoque. Guerra inevitabile, ma solo per la pessima influenza della Russia sui serbi e della Germania sull’Austria-Ungheria. Tuttavia, non l’hanno scatenata soltanto l’assicurazione della prima di salvaguardare la sopravvivenza della Serbia e la sprezzante esultanza della seconda nel poter finalmente ricorrere alle armi. Le oligarchie di Berlino, di San Pietroburgo, di Vienna hanno inseguito nel conflitto la soluzione dei crescenti problemi interni: in Germania opporre una vittoria militare ai successi politici del partito socialdemocratico; in Russia bloccare il dilagante malcontento di contadini e operai; in Austria mettere un freno alle tante nazionalità ansiose di autonomia. E allora possiamo immaginare come una vendetta dei 9 milioni e mezzo di morti e dei 21 milioni di feriti (8 milioni i mutilati e gl’invalidi) che i tre Imperi responsabili del conflitto - russo, tedesco e austroungarico - siano saltati per aria. Il 28 luglio è incominciata l’invasione della Serbia. Il 1° agosto la Germania ha dichiarato guerra alla Russia, che aveva già annunciato l’intervento in difesa del proprio alleato, e due giorni più tardi alla Francia. Nel giro di poche ore la Gran Bretagna ha ufficializzato la discesa in campo al fianco di Parigi. Un coinvolgimento a cascata, senza precedenti. Eppure a Vienna e nelle altre cancellerie europee ha campeggiato l’idea che potesse trattarsi soltanto della terza guerra balcanica, che a dicembre ci si sarebbe riuniti attorno al tavolo della pace e per Natale tutti a casa. In fondo ciascuno dei contendenti ha affermato di accontentarsi di poco. L’Austria voleva infliggere una lezione alla Serbia e cancellare dalle menti più accese ogni ipotesi di Stato jugoslavo in contrapposizione alla Duplice Monarchia. La Germania, accantonata la politica dialogante di Bismarck, voleva intimorire Gran Bretagna e Russia e chiarire alla Francia che sui confini indietro non si tornava. La Russia pretendeva di essere considerata la santa protettrice dei popoli slavi e la principale potenza del mondo, da cui non si poteva prescindere. La Francia accarezzava il sogno di riprendersi l’Alsazia e la Lorena grazie alla forza degli alleati. La Gran Bretagna non desiderava concedere spazio al militarismo prussiano frenando la crescita della sua flotta. Al di là delle discutibili motivazioni dei singoli Stati, il più deciso a cercare la guerra era anche il più autocratico di tutti, la Germania estensione del Regno di Prussia, di cui aveva conservato la dinastia, gli Hohenzollern, l’impianto militaristico, la soverchieria degli junker (gli antichi proprietari terrieri capaci di trasformarsi in ottimi comandanti) e, infine, il disprezzo per democrazia e parlamentarismo. Pur ingranditasi a Impero, anche alla Germania si attagliava, fino al 1914, ciò che Mirabeau aveva detto della Prussia: «Un esercito con uno Stato». Non a caso Guglielmo II era solito ricordare che la corona gli era stata «accordata solo da Dio, non dai parlamenti, dalle assemblee o dalle decisioni popolari Mi considero uno strumento del Signore e proseguo per la mia via». E per oltre un trentennio l’Austria, sonoramente umiliata nella guerra del 1866, ha accettato di mettersi al traino e di farsene condizionare all’appuntamento decisivo con la Storia. In simile marasma l’Italia si è affrettata ad annunciare il 2 agosto la neutralità. Abbiamo sfruttato la clausola del trattato, secondo cui la partecipazione diventa obbligatoria soltanto in caso di aggressione. E stavolta è avvenuto il contrario, per di più senza averci nemmeno consultato. A Berlino e soprattutto a Vienna siamo stati giudicati inaffidabili: l’immancabile ascendenza di Machiavelli ha contribuito ad affibbiarci il timbro dei doppiogiochisti. Malgrado nel ’13 fossimo stati i promotori del rinnovo della Triplice con venti mesi di anticipo sulla scadenza e prolungamento fino al ’26, i successivi dissapori sull’Albania e sulla gestione complessiva dei Balcani hanno riacceso le antiche incomprensioni con gli austriaci. Pur conservandosi «triplicista convinto», lo stesso San Giuliano ha dovuto prendere atto della scarsa considerazione intorno a noi. Il meno preoccupato è apparso von Moltke: non aveva già preso sul serio la promessa di Cadorna d’inviare truppe in Germania. Per lui l’importante era che l’Italia rimanesse alla finestra. E von Moltke ci ha azzeccato: fin quasi all’ultimo Cadorna è stato tenuto all’oscuro delle intenzioni e dei contatti. Ha perfino ricevuto dall’aiutante di campo del re una lettera d’approvazione al trasloco delle divisioni in Germania. La scelta di Salandra e San Giuliano, caldeggiata da Giolitti, ha incontrato il favore di quasi tutto il Paese. Hanno applaudito i borghesi di città e i braccianti delle campagne, hanno applaudito i nazionalisti e i simpatizzanti degli irredentisti, hanno applaudito i socialisti e i cattolici, per quanto Pio X (il veneto Giuseppe Sarto) giustificasse l’invasione della Serbia: paradossale atteggiamento in chi appena eletto al soglio di Pietro aveva revocato il potere di veto fin l&ėgrave; riconosciuto all’imperatore asburgico e grazie al quale era stato bocciato il pretendente più autorevole, il cardinale Rampolla segretario di Stato. Il 20 agosto Pio X è però deceduto e il suo successore Benedetto XV (il patrizio ligure Giacomo Della Chiesa) ha sposato in toto le tesi pacifiste. A parole anche San Giuliano si è professato pacifista, ma è stato il comodo schermo dietro il quale celare corteggiamenti altrui e tentennamenti personali. La gotta, acuitasi in quei mesi, l’ha costretto a lunghi soggiorni alle terme di Fiuggi. Tutti l’hanno giudicata una malattia diplomatica per allontanarsi da Roma e sottrarsi alle pressioni dei belligeranti. Invece la salute del marchese era assai malconcia. Tornato nella Capitale, San Giuliano si è fatto preparare una camera da letto al ministero e da l&ėgrave; non si è più mosso. Il fautore della Triplice ha cominciato a rammentare ai collaboratori di essere pure un lontano cugino del popolo britannico, «ex antiquissima stirpe nortmannica oriundus»: cos&ėgrave; l’aveva fatto proclamare, nel 1909, Edoardo VII dall’università di Oxford. San Giuliano ha scritto a Cadorna che l’Italia sarebbe entrata in guerra quando avrebbe avuto il 99 per cento di probabilità di vittoria ed egli sino a fine agosto le ha attribuite al Kaiser. Tuttavia, aspirando a essere «saggio e patriottico», mai ha dimenticato che dalla Gran Bretagna dipendevano i rifornimenti dell’indispensabile carbone. E unendosi alla Triplice la flotta italiana avrebbe saputo impedire il blocco del Mediterraneo? Già l’essersi posto la domanda implicava la risposta, indicava il sentimento dilagante nella classe politica. L’eccezione più clamorosa è stato ancora Giolitti: ha continuato ad affermare che passare «all’aggressione (degli ex alleati, nda) sarebbe un tradimento come ce n’è pochi nella storia». «Sprofondato negli angosciosi dubbi», Salandra ha accolto con sollievo l’invito di Cadorna: con una lettera il comandante in capo ha suggerito al governo di rinviare ogni decisione sull’intervento alla primavera del ’15, in modo da ovviare alla scarsità dell’equipaggiamento pesante necessario ad affrontare i rigori delle Alpi, sulle cui cime si prevedeva di combattere. Ma oltre a divise, pastrani, scarponi, difettavano anche i numeri: del milione abbondante di soldati, sotto mano ce n’erano 400.000 e con un armamento sommario, i due anni di guerricciola in Libia avevano svuotato i magazzini. L’inizio delle operazioni è stato sfavorevole all’Austria, bastonata in Serbia per eccesso di sicumera, e favorevole alla Germania. Le disperate richieste della Francia di aprire un secondo fronte sono state accolte dallo zar. I russi hanno attaccato in anticipo nella Prussia orientale e sono stati duramente puniti, anche per le reciproche gelosie dei loro generali, Rennenkampf e Samsonov, comandante della distrutta 2a armata e suicida per evitare l’onta della resa. A Tannenberg fra il 17 agosto e il 2 settembre la decrittazione dei codici russi ha favorito il genio e l’azzardo del quarantanovenne Ludendorff, capo di stato maggiore di von Hindenburg, richiamato a quasi settant’anni per guidare il fronte orientale. La vittoria ha però avuto un costo: von Moltke è stato costretto a trasferire sul fronte orientale due corpi d’armata. La mancanza è stata avvertita sulla Marna, il fiume a est di Parigi. I francesi in cinque giorni di furibondi combattimenti, dal 5 al 10 settembre, hanno bloccato la progressione tedesca, già ritardata dall’inopinata resistenza del minuscolo esercito belga. Gli eccessi e le violenze consumati fra Liegi e Bruxelles («lo stupro del Belgio») hanno prodotto una violenta impressione anche in Italia: appariva sempre più difficile condividere le sorti di un popolo accusato di seviziare donne e bambini. Lo stesso Kaiser ha involontariamente contribuito al discredito del proprio esercito: ha infatti sostenuto che la difesa a oltranza dei belgi, la spietatezza dei civili non inferiore a quella dei militari, l’uso di ogni mezzo per contrastare l’avanzata dei suoi uomini ne avessero prodotto la durissima risposta. Il «miracolo della Marna» ha costituito, secondo lo storico inglese Holger Herwig, la battaglia di terra più decisiva dai tempi di Waterloo. Nel mito della selvaggia determinazione dei reparti transalpini è entrata pure la leggenda dei soldati trasferiti in prima linea con i taxi. Ne sono partiti - alle 20 del 7 settembre - 600 da Livry Gargand con 2400 fanti e 550 da Gagni con 1600. Numeri ridottissimi, ma di enorme impatto mediatico. Forse un ruolo più importante i taxi l’hanno avuto nel fare avanti e indietro per accompagnare i feriti in ospedale. A guadagnarci è stata di sicuro la Renault: il suo modello AG, poi AG1 rosso e nero, in produzione dal 1905, si è trasformato nell’auto della Patria, ogni buon francese ha ambito ad averne una. Parigi è stata salvata al prezzo di un milione complessivo di morti. Von Moltke ci ha rimesso il posto: l’ha sostituito il ministro della Guerra von Falkenhayn. La Marna ha soprattutto cambiato l’orientamento strategico. Niente più manovre in campo aperto, ma estenuante guerra di posizione inchiodata alle trincee (sperimentate nella guerra russo-nipponica del 1905); prevalenza della difesa sull’attacco come esemplificato dai furibondi assalti alla baionetta tramutati in carneficine; guadagni territoriali di poche centinaia di metri destinati a lasciare intatto il quadro bellico. Con i due schieramenti incapaci di sormontarsi si è iniziata la corsa al mare nel tentativo di aggirare il fianco scoperto dell’avversario. A fine 1914 una linea di trincee contrapposte si stendeva dalla frontiera franco-svizzera al Mare del Nord. I numeri dei caduti erano già da brividi. Gli scontri dell’estate e dell’autunno hanno lasciato sul campo 800 mila tedeschi (tra morti e feriti), oltre un milione di francesi (di cui 329 mila morti), la quasi totalità del primo corpo di spedizione britannico (circa 90 mila uomini). E il peggio doveva ancora palesarsi. Neppure l’inizio della grande mattanza ha smorzato il fervore nazionalistico dei più bei cervelli europei. In ottobre 93 professori dell’accademia tedesca hanno sottoscritto un «Appello al mondo civile» per confutare dettagliatamente le responsabilità della Germania, a cominciare dallo «stupro del Belgio». Tra i firmatari tante stelle di prima grandezza, ritenute ancor oggi decisive nei loro campi: il biologo Ernst Haeckel, il fisico Max Planck, lo psicologo Wilhelm Wundt, il papà dei raggi elettromagnetici Wilhelm Röntgen, il futuro premio Nobel per la chimica Fritz Haber, l’aggiustatore dei gas venefici, che saranno utilizzati a Ypres (St, 461). L’unica firma mancante è stata quella di Einstein. Perfino Thomas Mann non si è sottratto al clima d’entusiasmo. Il 7 agosto ha scritto al fratello Heinrich: «Il mio sentimento fondamentale è di enorme curiosità e, lo confesso, nutro la più profonda simpatia per questa odiata Germania, cos&ėgrave; gravida di enigmi e di destino». Poi sui Pensieri di guerra apparirà questo ricordo: «Guerra! Quale senso di purificazione, di liberazione, d’immane speranza ci pervase allora! Ecco, di questo parlavano i poeti, solo di questo. E quando poi si ebbero i primi risultati decisivi, quando s’issarono le bandiere, quando i mortaretti rintronarono annunciando la marcia trionfale del nostro esercito sino alle porte di Parigi, non ci sembrò di avvertire allora una sorta di delusione, di disinganno come se le cose andassero troppo lisce, fossero troppo facili, come se la debolezza del nemico ci privasse dei nostri sogni più belli?». In trincea è andato pure il diciannovenne Ernst Junger, uno dei giganti del pensiero novecentesco. Karl Schwarzschild, un’autorità dell’astrofisica moderna, direttore dell’osservatorio di Potsdam, è partito volontario per il fronte russo. Tra una pausa e l’altra ha spedito un saggio a Einstein, che l’ha presentato all’Accademia prussiana delle scienze. In seguito si è ammalato, l’hanno riportato in Germania, dove morirà nel 1916. Sul fronte avversario, nella battaglia di Gallipoli cadrà a soli 28 anni un altro pioniere della fisica moderna, l’inglese Henry Moseley. In Francia si sono espressi a favore della guerra André Gide, Marcel Proust, Anatole France, Paul Claudel, Emile Durkheim, Charles Péguy, lo storico «giacobino» Albert Mathiez. In Russia è stata lanciata la crociata contro la «barbarie teutonica»: hanno aderito anche irriducibili nemici dell’autocrazia zarista come Plechanov, Kropotkin, i poeti Blok, Esenin, Majakovskij. Ma qualcuno ha detto no alla patria: l’astrofisico Arthur Eddington si è rifiutato di imbracciare le armi per motivi religiosi, era un quacchero fervente. La permanenza a casa e il ruolo di segretario della Royal Astronomical Society gli permetteranno di leggere le riviste tedesche, ormai bandite. Sarà cos&ėgrave; il primo a conoscere il rivoluzionario lavoro di Einstein e suo tramite anche la scienza anglosassone apprenderà la teoria della relatività. Al fianco dei francesi si sono schierati sei nipoti di Garibaldi, ancora onorato Oltralpe per il contributo nella guerra del 1870. Peppino, Ricciotti jr, Sante, Bruno, Costante, Ezio sono sei degli otto figli maschi di Ricciotti sr e dell’inglese Costanza Hopcraft. La voglia di menar le mani li aveva già portati nel ’12 in Grecia e in precedenza Peppino era andato in Sud Africa a battersi, in onore della madre, contro i boeri. Nell’agosto del ’14 proprio Peppino ha formato a Parigi la Legione garibaldina, cui hanno aderito diversi italiani residenti in Francia e i veterani della campagna balcanica. Provenivano da esperienze e ideologie differenti: socialisti, mazziniani, repubblicani, massoni, sindacalisti, anticlericali uniti dal desiderio di combattere contro il nemico storico del Risorgimento. Inquadrati come 4° reggimento della Legione straniera, con il diritto di portare la camicia rossa, sono stati impiegati nelle Argonne. Dal 26 dicembre al 5 gennaio 1915 hanno affrontato cruenti scontri con i tedeschi: si sono portati bene, ma hanno registrato parecchie perdite, sono caduti pure Bruno (25 anni) e Costante (23). Il sacrificio dei due ragazzi ha avuto il potere di trasformare gli iniziali giudizi sui garibaldini: da avventurieri, da mercenari in cerca di un ingaggio sono assurti a simbolo dell’interventismo. La Domenica del Corriere ha costruito la copertina sull’assalto delle camicie rosse a Courte Chasse. L’ Illustrazione Italiana ha disegnato un giovane Garibaldi morente sotto gli alberi. Mussolini sul Popolo d’Italia e Luigi Barzini sul Corriere hanno sciolto la fantasia per dimostrare l’inevitabilità dell’alleanza con Francia e Gran Bretagna. I riflessi più vistosi dello stallo militare si sono riverberati sulla posizione dell’Italia: la nutrita colonia di triplicisti è rimasta choccata dall’incapacità tedesca di sfondare. Il leggendario piano Schlieffen - sfruttare le lungaggini della mobilitazione russa per costringere velocemente la Francia ad arrendersi prima di dedicarsi alle truppe zariste - si è rivelato un’illusione. Alla stasi autunnale sul fronte occidentale è seguita la ripresa dell’iniziativa della Russia a Est. L’affermazione della Germania non appariva più cos&ėgrave; scontata, anzi, andando sulla lunga durata, l’impero britannico offriva garanzie di maggior solidità. Come capiterà tra venticinque anni, nella nostra ansia di metterci dalla parte del più forte abbiamo puntato, nel male e nel bene, sulla Germania. Il cancelliere von Bethmann-Hollweg ha insistito con il suo omologo von Sturgkh affinché gli austriaci promettessero cospicui compensi all’Italia. Von Sturgkh ha motivato la renitenza del proprio governo con le nostre pretese, definite eccessive, e con l’intima persuasione che stessimo giocando al rialzo. Nella cerchia di Francesco Giuseppe non contavamo molti estimatori. Financo l’ungherese Tisza ha fatto pollice verso con un giudizio perentorio: «L’Italia è militarmente debole e codarda. Non dobbiamo farci trarre in inganno». Paradossalmente chi ha insistito per qualche concessione è stato von Hotzendorf: l’interesse superiore del conflitto l’ha persuaso ad accantonare il suo purissimo odio. Niente ha però scosso l’ostinazione del vecchio sovrano: da oltre sessant’anni sul trono, depositario di un’Europa cancellata dalla prima globalizzazione, non ci aveva perdonato di essere cresciuti e di esser divenuti una Nazione a detrimento dei suoi possedimenti e poco importava che quelle terre fossero italiane da millenni. Sudditi eravamo e sudditi saremmo dovuti restare insieme con gli altri popoli, ai quali Francesco Giuseppe si rivolgeva nelle loro lingue. L’Austria-Ungheria era già una piccola Europa Unita e, come accadrà dopo un secolo, l’imperatore paventava le scosse sismiche inflitte dai micro organismi regionali. Le cartoline dal fronte erano stampate in dieci lingue. Ruteni, cechi, dalmati e ungheresi venivano inquadrati negli stessi reggimenti, con cucine da campo separate per ebrei, cristiani e musulmani. Nei camposanti si accumulavano ricordi in tedesco, in ceco, in serbo, in ungherese; le une accanto alle altre, croci, stelle di Davide, mezzelune turche dei bosniaci. Nell’impero, secondo per estensione (680.000 kmq) soltanto a quello russo, l’etnia italiana era la più esigua delle undici ospitate (tedeschi, magiari, cechi, polacchi, ruteni, croati, rumeni, slovacchi, serbi, sloveni). Dei 53 milioni di abitanti (2.200.000 nella capitale Vienna, terza città più grande d’Europa) gl’italiani rappresentavano poco più del 2%, quasi per intero raccolti fra il Trentino, la Venezia Giulia e la Dalmazia. Non a caso le richieste iniziali avevano riguardato la pienezza dei diritti civili al pari delle altre componenti nazionali. Il gruppo d’intellettuali, da Scipio Slataper ai fratelli Stuparich, le cui tesi erano state ospitate dalla Voce di Giuseppe Prezzolini, si era adoperato affinché la loro comunità non fosse bistrattata da tedeschi e ungheresi. Avevano cozzato contro un muro d’indifferenza, spesso di ostilità. La casta militare, i vecchi dignitari di corte, i funzionari del ministero degli Esteri avevano respinto l’invito a copiare l’esempio del Canton Ticino con la minoranza italiana integrata a tal punto da considerarsi svizzera a tutti gli effetti. Le condizioni di vita sono precipitate con l’inasprirsi della crisi. Vienna si è mossa per emarginare gli italiani e niente ha fatto per evitare che si creasse un clima d’intolleranza con sloveni e croati. Per reazione l’irredentismo ha aumentato i proseliti, ma è rimasto una scelta d’elite, lontano dal sentire comune. Tuttavia i 117.000 richiamati di lingua italiana (55.000 trentini, 32.000 dell’area triestina, 30.000 friulani) sono stati spediti a combattere e morire sul fronte orientale onde evitare anche la più piccola tentazione di filarsela. Gl’irredentisti hanno battuto su questo tasto per suscitare compassione nel Belpaese. Le richieste d’aiuto hanno presto trasformato molti dei pacifisti in ferventi interventisti al fianco dell’Intesa, cioè Francia, Gran Bretagna e Russia. A metà ottobre è deceduto San Giuliano. Salandra l’ha sostituito con Sonnino un anziano esponente della Destra storica, che è stato capo del governo, ministro del Tesoro, ministro delle Finanze. I due hanno adottato la tattica del silenzio, si sono aperti unicamente con il re per dire che niente avevano da dire. Nel senso che avrebbero proseguito le trattative con entrambe le parti in attesa di scoprire chi fosse il probabile vincitore per balzare sul suo carro. Salandra e Sonnino hanno guardato da subito all’Intesa dovendo però rimontare radicate riserve. Nel novembre del '12 l’ambasciatore russo a Parigi, Aleksandr Izvol’skij, aveva scritto al suo ministro degli Esteri, Sergej Sazonov: «Nessuno crede che la Triplice Intesa o la Triplice Alleanza possa contare sulla lealtà dell’Italia, che nel caso di una guerra assumerà un atteggiamento di osservazione e poi si assocerà alla parte verso cui arride la vittoria». Sull’identica falsariga la nota del Consiglio superiore della difesa nazionale francese: «L’Italia rimarrà probabilmente neutrale, ma non esiterà a schierarsi dalla parte del possibile vincitore». Persino la buonanima di Schlieffen, nel promemoria del dicembre 1912, aveva raccomandato di non illudersi sul nostro impegno: «Al massimo l’Italia costringerà la Francia a lasciare due corpi d’armata e relative riserve ai confini alpini: questo è tutto il vantaggio che potremo verosimilmente trarre dall’alleanza con l’Italia in una guerra». In effetti le diverse ragioni del pacifismo hanno continuato a innervare il sentimento del Belpaese. A favore della guerra si sono di nuovo pronunciati i giovani universitari, gli artisti arrabbiati, e più ancora squattrinati, che componevano la platea adorante di Tommaso Marinetti: la minoranza più esigua possibile, travestita da avanguardia del progresso, interventista in odio al social-liberalismo di Giolitti pacifista. Le «parole in libertà» del cultore della velocità hanno esaltato gli animi assieme alle bandiere austriache bruciate in piazza. «La guerra sola igiene del mondo» pubblicato nella primavera del 1915 è assurto a slogan di coloro che hanno professato di esser disposti a tutto pur di pisciare in testa al vecchio mondo. «La Guerra - ha scritto Marinetti - è la sintesi culminante e perfetta del progresso (velocità aggressiva + semplificazione violenta degli sforzi verso il benessere). La Guerra è un’imposizione fulminea di coraggio, di energia e d’intelligenza a tutti. Scuola obbligatoria d’ambizione e d’eroismo, pienezza di vita e massima libertà nella dedizione alla patria». Non sono state soltanto «parole in libertà»: allo scoppio del conflitto il quarantenne Marinetti si arruolerà volontario, sarà ferito, meriterà due medaglie. Insieme con lui a smuovere le acque sono stati gli sperimentati campioni del radicalismo e del socialismo, in testa il sindacalista Filippo Corridoni protagonista della «settimana rossa»; a seguirlo Mussolini espulso dal partito socialista. Le motivazioni degli interventisti non avrebbero però infiammato le piazze senza l’eloquio e l’ascendente di D’Annunzio. Da anni residente in Francia, il suo seguito è stato ingigantito dalla sua assenza. Siano corsi o no i favoleggiati franchi del ministero degli Esteri transalpino, il vate ha consentito all’esigua minoranza favorevole alla guerra, naturalmente con l’Intesa, di schiacciare l’impacciata maggioranza neutralista priva di una voce cos&ėgrave; altisonante da contrapporre. Al suo fianco il Corriere della Sera elevato dal direttore Luigi Albertini a principale testata dello Stivale. Anche Guglielmo Marconi, fresco Nobel per la fisica nel 1909, non ha nascosto le simpatie per l’Intesa avendo una madre irlandese, figlia del famoso distillatore Jameson. Il pacifista più convinto è risultato Giolitti. Per contrastare il progressivo allontanamento di Salandra e di Sonnino dalle sue posizioni, ha svelato in Parlamento che sin dal ’13 egli aveva chiarito a von Sturgkh che se avesse aggredito la Serbia, non avrebbe goduto dell’appoggio italiano. L’assoluto neutralismo di Giolitti è condito dalla profonda disistima verso i nostri alti gradi militari maturata durante la guerra di Libia: «Centomila uomini e trenta generali, che non riescono a venire a capo di un tenente colonnello». Si riferiva a Enver Bey, il giovane ufficiale turco bravissimo nell’impegnarci in una sanguinosissima guerriglia e nel tenerci in scacco pure dopo il ritiro dei reparti ottomani. Salandra e Sonnino hanno fatto accusare Giolitti, dai giornali amici, di aver rivelato segreti di Stato: l’imputazione era risibile e nascondeva, viceversa, l’accentuato desiderio di distinguersi dal protettore politico per disinnescarne l’ennesimo ritorno. Entrambi erano espressione di un liberalismo ottocentesco nettamente contrario alle masse, abituato a far da solo fin dal Risorgimento e abilitato dal suo discusso successo. Magari Salandra e Sonnino hanno davvero creduto che sarebbe stato un conflitto limitato: una sorta di Libia a più largo respiro, ma dalle scadenze più brevi e che sarebbe caduto a fagiolo per liberarsi dell’incombenza delle masse - socialiste e cattoliche - ormai decisive con il suffragio universale. La vecchia concezione della guerra quale proseguimento della politica con altri mezzi. Non hanno previsto che l’ampiezza geografica e temporale del conflitto avrebbe obbligato i governanti a doversi accordare, per vincere, proprio con le aborrite masse. Mai come in quei mesi Giolitti è stato circondato da un consenso vastissimo. A lui hanno guardato i borghesi, i cattolici, i socialisti, i lavoratori dei campi: l’ottanta per cento della popolazione. Per imporne i diritti, Giolitti avrebbe dovuto far cadere il governo. Ammesso che ne avesse i voti, ha temuto di andare incontro a scelte non condivisibili. L’ultima speranza è stata racchiusa nelle compensazioni austriache. La generica richiesta del Trentino ha immediatamente ricevuto la sferzante risposta di Francesco Giuseppe: avrebbe preferito abdicare piuttosto che concederlo all’Italia. Negli strepiti e nelle contumelie degli interventisti è divenuto il Cecco Beppe dell’aneddotica irredentista. Ma l’imperatore non ha soltanto ceduto alle visceri, ha anche tenuto conto dell’effetto disgregatore che la cessione del Trentino avrebbe potuto esercitare sulle altre etnie dell’Austria-Ungheria. Un guadagno l’Italia l’ha incassato in autunno: la rinuncia del principe di Wied al trono d’Albania ha offerto il destro di un’occupazione per evitare il supposto caos. Il nostro ruolo di corteggiati speciali ha indotto al silenzio sia le Nazioni dell’Intesa sia gl’Imperi Centrali. Ha protestato il solo Cadorna preoccupato che gli sottraessero qualche divisione in vista del sempre più probabile intervento. Per scongiurarlo la Germania ha inviato a Roma in qualità di ambasciatore von Bulow nella speranza di sfruttarne le entrature garantite dalla suocera e dalla moglie, figlia di un principe italiano. E von Bulow ha avvertito Berlino e Vienna che sarebbe stato opportuno rinunciare al Trentino e alla riva destra dell’Isonzo con esclusione di Trieste, la città più ricca dell’Impero. Ma Francesco Giuseppe ha liquidato il ministro degli Esteri von Berchtold, latore della proposta. Nel marzo del ’15, per superare l’ostracismo di von Stürgkh, di Tisza e del ministro della casa imperiale Burian, la Germania si è detta disposta a cedere la Slesia all’Austria quale ricompensa del Trentino. Burian, promosso ministro degli Esteri, è stato allora incaricato di trattare con Sonnino. Ha aperto sul Trentino: nella sua infinita bontà Francesco Giuseppe manifestava disponibilità a privarsene, però di una parte, non tutto e dopo la fine della guerra, sempre per evitare un pericoloso precedente con gli altri popoli dell’impero. Noi abbiamo alzato di molto la posta. Burian avrebbe voluto mandarci al diavolo, tuttavia non poteva deludere le aspettative germaniche: ha tergiversato nella speranza che l’imminente offensiva austriaca nei Carpazi ristabilisse la prevalenza degli Imperi Centrali e ammorbidisse l’ex alleato. Salandra e Sonnino hanno incaricato l’ambasciatore a Londra, Imperiali, di aprire i negoziati con l’Intesa. L’Italia non ha manifestato fretta di concludere: desiderava essere sicura di puntare sul vincitore. Le sorti in bilico della guerra hanno spinto la controparte alla trattativa. La stasi sul fronte orientale ha ridotto il potere di veto dello Zar, fin l&ėgrave; il più accanito oppositore alle nostre pretese nell’area slava. Il 26 aprile del ’15 è stato firmato il protocollo del Patto di Londra. Vittorio Emanuele ha spedito un telegramma di compiacimento. Secondo il vigente statuto albertino, il monarca era legittimato a trattare alle spalle del Parlamento l’ingresso nel conflitto. Che, però, avrebbe dovuto essere autorizzato dalle Camere con il permesso al governo di stanziare le somme necessarie alle operazioni militari. L’Italia ha ottenuto il moltissimo richiesto: Trentino, Venezia Giulia, Dalmazia, Istria, Dodecaneso, Valona e l’entroterra albanese, colonie in Africa e in Asia Minore. Ma l’ha ottenuto nelle forme vaghe, che creeranno numerosi casi scottanti nel dopoguerra, il primo sarà la sorte di Fiume, per di più imponendo l’obbligo della segretezza, ossessione di Sonnino. Siamo in tal modo riusciti a indispettire la Serbia e a procrastinare l’intervento della Romania, che avrebbe potuto darci un sostanzioso contributo. Gli accordi hanno previsto l’ingresso in guerra dell’Italia entro un mese. La tappa intermedia è stata l’uscita dalla Triplice il 4 maggio. Il giorno seguente, anniversario della partenza dei Mille di Garibaldi da Quarto, D’Annunzio è rientrato in Italia per pronunciare dal molo ligure una sapientissima orazione in favore degli immancabili destini, che ci attendevamo sui campi di battaglia. Il discorso, anticipato dal Corriere, ha inferto una scossa alla Nazione. Il segreto sul Patto di Londra ha retto ancora, tuttavia si è intuito che la cronaca e forse la Storia si erano messe in cammino. Il partito pacifista ha tentato un estremo ribaltamento. Benedetto XV e il segretario di Stato, il cardinale Gasparri, hanno tessuto la trama di un’ambiziosissima conferenza della pace da convocare a Roma sotto la presidenza dello stesso pontefice. A muovere le due intelligenze più lucide della Chiesa sono stati i buoni rapporti con l’Austria, ma anche la preoccupazione che la guerra sprofondasse nelle difficoltà Stati di sicura fede cattolica a vantaggio di Stati considerati in mano alla massoneria. Ovviamente il progetto sarebbe andato a compimento soltanto se l’Italia avesse conservato la propria neutralità. Figlio di ebreo, protestante e massone, Sonnino ha subodorato la manovra del Vaticano e si è premunito di far inserire nel Patto di Londra la clausola di esclusione del papato da ogni futura conferenza di pace. Gasparri si è addirittura rivolto al cattolicissimo Cadorna per chiedergli di proclamarsi contrario all’intervento: o preferiva dare un dispiacere al Santo Padre pur di compiacere quei senzadio del governo? Cadorna contrario lo era a prescindere giudicando l’intervento prematuro per le condizioni dell’esercito, e ancor più si sentiva incardinato nella grande famiglia della Chiesa avendo una figlia suora, però anch’egli in quei giorni era stato attratto dal partecipare a una guerra già vinta e da terminare in poche settimane. Von Bulow ha seguito gli sviluppi della possibile conferenza con le informazioni passategli da Gasparri. Allorché ha percepito che mai sarebbe stata organizzata, ha avvisato von Bethmann: soltanto una calata di braghe dell’Austria avrebbe scongiurato l’intervento dell’Italia. Berlino ha ottenuto una parziale calata di braghe: Francesco Giuseppe ha acconsentito a dare il Trentino e la costa occidentale dell’Isonzo; Trieste sarebbe divenuta una libera città imperiale; l’Italia avrebbe dovuto pagare un indennizzo per i territori acquisiti e avrebbe dovuto impegnarsi a non pretendere compensazioni, se l’Austria-Ungheria, alla fine del conflitto, avesse acquisito nuovi spazi. Era molto meno di quanto avevamo strappato all’Intesa, ma nessuno, a parte Salandra, Sonnino e il re, lo sapeva. Per conferire maggiore spessore alla sua controffensiva, von Bulow si è rivolto a Giolitti. Il settantaduenne statista ha lasciato l’abituale tana di Dronero ed è sceso a Roma. Ha avuto tempestosi colloqui con Vittorio Emanuele e con Salandra. Ha fatto vacillare le loro certezze, ha indotto il monarca a dichiararsi pronto ad abdicare, il presidente del consiglio a presentare le dimissioni. L’esterrefatto Sonnino si è ritrovato isolato e additato quale capro espiatorio. Le offerte dell’Austria sono state pubblicate da La Stampa assieme ai bollettini della rotta russa in Galizia e delle batoste subite dai britannici nei Dardanelli, dove le insistenze del temperamentale ministro della Marina, Winston Churchill, avevano portato al rovinoso sbarco del corpo di spedizione australiano. Cos&ėgrave; anche l’Inghilterra, certa di potersela cavare con l’impiego della sola flotta, è stata obbligata all’impiego delle forze di terra: ne aveva poche, scarsamente addestrate e senza l’ausilio della leva obbligatoria. E’ sembrato configurarsi lo scenario migliore per Giolitti. Al contrario, i suoi piani sono stati scardinati dalle proteste delle piazze in mano agli interventisti. Il Paese ha attraversato giorni di profonda incertezza. Le dimissioni di Salandra hanno portato le Istituzioni sull’orlo del collasso. E’ fallito lo sciopero generale per la pace proclamato dal partito socialista. D’Annunzio, Mussolini e Corridoni hanno imperversato a Milano e a Roma in sostegno alla guerra. Il più acuminato e pittoresco è risultato al solito D’Annunzio: la sua inventiva ha ricoperto di sfottò e offese brucianti il Parlamento. E’ stato il primo guitto a delegittimarlo: in seguito sarebbero sopraggiunti i comici. Il re ha cercato un nuovo capo del governo pronto a disdire il Patto di Londra e ad approfondire il negoziato con Francesco Giuseppe. Giolitti ha rifiutato: non rientrava nelle sue corde governare contro la piazza. Anche gli altri, modesti, candidati - Carcano, Marcora, Boselli - si sono tirati indietro. Il Parlamento tifoso della neutralità assieme alla stragrande maggioranza del Paese non ha saputo individuare il personaggio all’altezza del compito. Esaurite le formalità, Vittorio Emanuele ha assunto su di sé la decisione finale respingendo le dimissioni di Salandra e riconsegnandogli il ruolo di premier, che significava il s&ėgrave; alla guerra. E da un secolo si discute se in fondo la volontà di Vittorio Emanuele non fosse stata da sempre quella di combattere al fianco di Francia e Gran Bretagna. Di sicuro non era quella di combattere al fianco del nemico storico della sua casata e al fianco di un Kaiser, con cui era stata antipatia a prima vista e che, per di più, non mancava di sfotterlo per la modesta altezza e la gracile corporatura. Quando Salandra ha domandato i pieni poteri - «che erano in realtà i poteri di dichiarare la guerra» (Montanelli) - i 300 deputati giolittiani hanno votato a favore. Il Parlamento si è arreso alla piazza, che a sua volta si era arresa alla soverchieria della minoranza urlante. Per tutta ricompensa Mussolini ha scritto: «Il Parlamento è il bubbone pestifero, che avvelena il sangue della Nazione. Occorre estirparlo». Il 23 maggio l’ambasciatore Avarna ha consegnato l’ultimatum a Vienna. La reazione di Francesco Giuseppe è stata inviperita. Ha invitato il «caro conte Sturgkh» a fare appendere sui muri di tutti i borghi il manifesto traboccante la viscerale avversione, che l’imperatore troppo a lungo aveva dovuto frenare. «Ai Miei Popoli. Il re d’Italia mi ha dichiarato la guerra. Una fellonia, quale la storia non conosce l’eguale venne perpetrata dal regno d’Italia verso i suoi due alleati. Dopo un’alleanza di più di trent’anni durante la quale essa poté aumentare il proprio possesso territoriale e assurgere a insperata prosperità, l’Italia ci abbandonò nell’ora del pericolo e passò a bandiere spiegate al campo dei nostri nemici. Noi non minacciammo l’Italia, non diminuimmo il di lei prestigio, non toccammo il suo onore e i suoi interessi. Noi adempimmo sempre fedelmente ai Nostri doveri, quali alleati e le fummo di scudo quando essa entrò in campo. Facemmo di più. Quando l’Italia rivolse i suoi cupidi sguardi oltre i Nostri confini, eravamo decisi nell’intento di conservare l’alleanza e la pace a gravi e dolorosi sacrifici, sacrifici questi, i quali particolarmente affliggevano il nostro cuore paterno, ma la cupidigia dell’Italia, la quale credeva di dover sfruttare il momento, era insaziabile. E cos&ėgrave; la sorte deve compirsi. Contro il possente nemico al nord la Mia armata fece vittoriosa difesa in una gigantesca lotta di dieci mesi, stretta in fedele fratellanza d’armi con gli eserciti del Mio Augusto Alleato. Il nuovo perfido nemico al sud non è per essa un nuovo avversario. Le grandi memorie di Novara, Mortara, Custoza e Lissa, che formano l’orgoglio della mia gioventù e lo spirito di Radetzky, dell’Arciduca Alberto e di Tegetthoff, il quale continua a vivere nella Mia armata di terra e di mare, danno sicuro affidamento che difenderemo vittoriosamente anche i confini meridionali della Monarchia. Io saluto le Mie truppe ferme nella lotta, abituate alla vittoria, confido in loro e nei loro duci. Confido nei miei popoli, al cui spirito di sacrificio vanno i miei più sentiti paterni ringraziamenti. All’Altissimo rivolgo la preghiera che Egli benedica le Nostre bandiere e prenda la Nostra giusta causa sotto la sua Custodia». Il giorno seguente, il 24, è giunta la prevista dichiarazione di guerra dell’Italia, frutto del «sacro egoismo», Salandra dixit. Le ostilità sono state aperte con l’Austria-Ungheria, non con la Germania in barba alle clausole del Patto. Abbiamo sperato d’inventare la «guerra a scartamento ridotto», forse memori di mai aver vinto una grande battaglia, di quelle che vanno poi onorate nella memoria di generazioni e generazioni. Vuoto che permane dopo ben due guerre mondiali. In fondo l’ultimo, epocale successo targato Italia, con generali italiani e soldati italiani, è quello colto da Publio Cornelio Scipione a Zama contro Annibale. Era il 202 avanti Cristo. Il primo successo è stato di natura economica: la confisca di villa d’Este a Tivoli. Le traversie della storia l’avevano consegnata in dote agli Asburgo, che l’avevano però fatta deperire assieme alle preziose collezioni artistiche. A metà Ottocento il cardinale Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst se n’era innamorato e l’aveva riportata agli antichi splendori. Uno dei suoi affezionati frequentatori era stato Franz Liszt. L’ultimo proprietario risultava l’erede al trono dell’Impero austro-ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando. Aveva proposto all’Italia di acquistare la villa per 2 milioni di lire, quasi 8 milioni di euro, un’enormità per l’epoca. Giolitti e San Giuliano si erano trovati in un cul de sac: non volevano sottostare alla richiesta, ai loro occhi una sorta di estorsione, ma non potevano irritare con un rifiuto il prossimo imperatore. L’omicidio di Francesco Ferdinando a Sarajevo è stato preso come una liberazione dalla «noiosa faccenda», comunicazione di San Giuliano a Salandra. La dichiarazione di guerra ha completato l’opera: villa requisita e 2 milioni risparmiati. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

