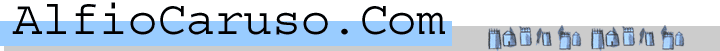
|
|
|
| - Primo capitolo -
acquista il libro on line torna all’archivio Si volta pagina
 In quei giorni di appiccicoso settembre pugliese Sergio Pivetta vede vacillare intorno a sé i capisaldi della giovinezza. Nelle camerate del battaglione allievi ufficiali a Gioia del Colle piú di un suo coetaneo ha proclamato ad alta voce che in odio a Mussolini non avrebbe sparato un colpo contro gli americani.
In quei giorni di appiccicoso settembre pugliese Sergio Pivetta vede vacillare intorno a sé i capisaldi della giovinezza. Nelle camerate del battaglione allievi ufficiali a Gioia del Colle piú di un suo coetaneo ha proclamato ad alta voce che in odio a Mussolini non avrebbe sparato un colpo contro gli americani.Ma se ci hanno spedito qui da Forlì per opporci agli Alleati quando sbarcheranno… Noi abbiamo il dovere di resistere. Non me ne importa niente. Mussolini è caduto, il fascismo è caduto, questa è una guerra fascista e io sto con gli americani. Loro però sono i nemici, sono gl’invasori. Pensateci voi che gridavate "Du-ce, du-ce, du-ce…" Oh se l’ha gridato Pivetta. E’ nato nel 1922 e gli slogan inneggianti a Mussolini ne hanno scandito infanzia e giovinezza. Figlio della lupa, balilla, avanguardista, giovane fascista: Sergio è cresciuto sotto quei faccioni sempre più gonfi e sempre più tronfi. Ha corso, ha giurato, ha saltato, ha declamato al cospetto di quegli occhi da invasato, che nelle gigantografie incattivivano l’aria da imbonitore di paese. Al punto che molti l’avevano scambiato per l’uomo del destino. E Sergio era stato uno dei molti, felice e fiero di esserlo. Un figlio perfetto della nuova era: ecco che cosa aveva provato la mattina in cui l’avevano accolto all’Accademia fascista di educazione fisica. Era sorta alla fine degli anni Venti dentro il complesso sportivo del Foro Italico, in mezzo a statue e marmi echeggianti la Roma imperiale. Una scuola di partito dove anziché l’ideologia si privilegiavano la prestanza, lo sprezzo del pericolo, il machismo. Per entrarvi bisognava superare selezioni durissime e mostrarsi fascisti tutto d’un pezzo. I prescelti si sentivano dei predestinati, avevano la sensazione di appartenere a un’élite, quella che avrebbe dovuto guidare la metamorfosi fisico-estetica della popolazione. Il tipo mediterraneo - culo basso, gambotte, busto atticciato - mal si confaceva alla gens romana chiamata a competere con la presunta razza ariana di Hitler. Bisognava, quindi, forgiare un popolo destinato a trasformarsi, almeno nei proclami, in otto milioni di baionette. L’esaltazione, il dogmatismo, la passione giovanile avevano fatto degli allievi dell’Accademia altrettanti innamorati della bella morte: il 10 giugno del ’40 erano partiti in massa per la guerra, tanti non ne avevano fatto ritorno, parecchi avevano meritato medaglie e menzioni. Ecco chi è stato e di che cosa si è nutrito Sergio Pivetta. La sua fede ha resistito anche alla deposizione di Mussolini e al disfacimento del fascismo. Il 26 luglio in poche ore ha visto polverizzarsi assieme ai vent’anni di regime la sua stessa esistenza. Ma nell’annuncio di Badoglio che la guerra continuava Sergio ha voluto scorgere la continuazione dei propri ideali. Il disorientamento è incominciato a Gioia del Colle. Sono allievi ufficiali, hanno un diploma, diversi una laurea, in teoria rappresentano il meglio della Nazione, invece ne incarnano l’inarrestabile disorientamento. Si macerano tra dubbi e rabbia. L’imminente arrivo degli anglo-americani in Puglia diventa l’ultima delle preoccupazioni. Prima degli Alleati giunge, invece, l’8 settembre. Il comunicato letto alla radio da Badoglio, lo squagliamento immediato del colonnello comandante, l’assenza di ordini, il caos delle volontà, il turbamento dei cuori: l’alternativa appare tra il morire e il sopravvivere in balia del caso. La mattina seguente dieci tedeschi puntano i mitra e disarmano il battaglione. Camerati che fate? Abbiamo combattuto assieme su tutti i fronti... La pensiamo come voi… Requisiti fucili e mitragliatrici, i tedeschi se ne vanno senza neppure degnarli di una risposta, di una spiegazione. Pivetta prova l’ultima e più cocente delle umiliazioni: come italiano, come fascista, come ammiratore dei tedeschi. Abbandonati e irrisi, gli allievi ufficiali di Gioia del Colle si tramutano in cavallette impazzite: chi prende la strada di casa verso il Nord, chi si aggira indeciso a tutto nelle strade del paese, chi si dirige a Bari nella speranza di trovare ufficiali informati, reparti ancora efficienti. Pivetta è confuso, cammina tra persiane accostate e porte sbarrate, il suo compagno di sventura si chiama Bruno Melioli. All’improvviso una bimbetta di nome Rosaria tende la mano: "Venite a casa mia". Da quell’inatteso riparo i due ragazzi odono esplodere i combattimenti. A Gioia del Colle sparano e s’ammazzano i tedeschi in ritirata e le avanguardie inglesi. Poi un grido si diffonde per vicoli e piazze: libertà, libertà, libertà… Significa anche linciaggio dei malcapitati, assalto ai magazzini dei viveri. Sergio e Bruno rimediano un sacco di farina con cui ringraziare dell’accoglienza i familiari di Rosaria. Pivetta è solo con la sua disperazione, si sente derubato di tutto ciò in cui ha creduto e confidato. Si aggrappa all’unico salvagente rimasto, la Patria. La Patria di suo padre e di suo nonno, la Patria dei racconti ascoltati da bambino, la Patria del tricolore, del risorgimento, delle trincee del ’15-’18. Decide che ovunque sia, la troverà. Per cercarla s’incammina verso Bari, si presenta a una caserma, declina generalità e matricola, dice di esser pronto. Pronto per che cosa? Per ciò che ci sarà da fare. Boia di un mondo ladro, faremo qualcosa… Nella camerata i letti si riempiono. Compaiono diversi compagni del corso, vengono ricostituiti i battaglioni, si cercano volontari per il fronte. Di voglia però ce n’è poca. Il fascista Pivetta prende a sfottere gli antifascisti, quelli che non avrebbero sparato un colpo contro gli americani. Io mi offro, voi che fate? Mi lasciate solo? Lasciate che a rappresentare voi antifascisti duri e puri sia uno che si è sgolato per anni a urlare: du-ce, du-ce, du-ce… Nella camerata si offrono tutti volontari. Sotto le tende di Mesaglie la notizia dell’armistizio la diffonde una telefonata dal comando di Bari. Anche qui languisce da maggio un battaglione di allievi ufficiali con il compito di difendere il vicino aeroporto di Grottaglie. Da settimane si colgono indizi crescenti del nostro cambio di fronte, eppure l’annuncio sprofonda molti nello sgomento. Il solo conforto è la speranza che venga comunque conclusa la guerra e si torni a casa. Felice Scotti a casa dovrebbe in ogni caso rientrare. Come tutti i militari abitanti a Milano ha ricevuto una licenza speciale - due settimane, viaggio compreso - in seguito ai tremendi bombardamenti abbattutisi in agosto sulla città con la distruzione di parecchie abitazioni. Quella di Scotti in via Ercole Ferrari è stata rasa al suolo, lui è in lista per partire la mattina seguente, ma nella notte viene spedito con la compagnia a presidiare la strada provinciale. E’ la terza fregatura per chi come Scotti a gennaio è stato arruolato volontario a sua insaputa. Appartiene alla classe più martoriata della generazione sfortunata, i ragazzi italiani nati fra il 1912 e il 1922 destinatari di una cartolina precetto, cui non si sono voluti o potuti opporre. Scotti è del marzo ’22, frequentava la facoltà di lingue nell’università veneziana di Ca’ Foscari. Ha interrotto gli studi e indossato il grigio-verde. La sua passione sono le montagne, sarebbe voluto andare fra gli alpini, "ma non ero né figlio né nipote di cardinali, di arcivescovi, di monsignori così anziché sulle Alpi mi ritrovai a Caserta". Al termine dei tre mesi del corso ecco la seconda fregatura: i gradi di caporal maggiore anziché di sergente. Dal punto di vista pratico non cambia alcunché: il ventunenne Felice Scotti sempre una squadra comanderà. Cambia molto in busta paga: il caporal maggiore figura quale graduato, mentre il sergente è considerato un sottufficiale. La vera fregatura l’ha però incassata il 25 luglio: assieme al duce è caduto il suo mito. Vi si fondevano Mussolini e il fascismo, i colli fatali e l’impero, gl’immancabili destini e la sicurezza d’incarnare il prototipo dell’italianità in camicia nera. Scotti pensava che abbattuto il regime l’avrebbero smesso con la guerra, nient’affatto. E’ rimasto nel soffocante accampamento pugliese in funzione anti paracadutista. Sono state settimane di precarietà, d’inquietudine e di sete, manco li avessero distaccati nel deserto. Ogni giorno un litro di acqua a testa: la maggior parte andava perduta per lavare la scatoletta usata quale contenitore per il rancio. Poi praticavano un forellino nel recipiente, lo poggiavano in alto e il filo di acqua serviva alla sommaria pulizia mattutina. Il resto veniva diviso con parsimonia lungo le ventiquattr’ore. Gola arsa, bocca impolverata, una voglia arretrata e incontenibile di cibo. Per colazione un liquido con il colore del caffè, talmente bollente da annichilire qualsiasi gusto. Il rancio era costituito da ditalini al pomodoro, brodo con fettina di carne invisibile, quando non introvabile, più piselli fermentati, ai quali nella tradizione orale veniva attribuita una enorme capacità nutritiva. La sera il piatto principale consisteva nel minestrone cotto in grandi fusti di benzina. Ne era garantito il preventivo lavaggio con acqua di mare, tuttavia mai incontrato un furiere che avesse provveduto di persona all’operazione. Prima della distribuzione il cuciniere impiegava una decina di minuti a togliere con il mestolo i due strati iniziali del minestrone: vi era sedimentato tutto ciò che aveva svolazzato nell’aria durante la cottura. Un’ombra di formaggio costituiva il secondo, il pane risultava immangiabile, resistevano le sempiterne gallette. Scatolette di carne due volte al mese. Insomma, nello stomaco restava un buco, che non era soltanto l’appetito dei vent’anni, era autentica fame. L’addestramento più vero l’aveva dunque rappresentato la caccia a meloni, fichi, uva, ceci. Autentiche razzie, tranne nei casi d’improvvisa comparsa dei contadini armati di doppietta, allora si trattava. E ora steso dentro il canale d’irrigazione, che funge da occasionale trincea ai bordi della strada provinciale, Scotti guarda transitare i reparti della Goering. Hanno l’ordine di non importunarli: assieme alla sua squadra si augura che anche i tedeschi abbiano lo stesso ordine o, quanto meno, abbiano fretta di sganciarsi. In caso contrario gli italiani dovrebbero fermare con i loro fuciletti, l’immortale modello ’91, quel bendidio di fucili Mauser, di mitragliatori, di mitragliatrici, di mortai, di bazooka. A Vilusi, sopra le Bocche di Cattaro, in Montenegro, il sottotenente Edoardo Vertua osserva gli ufficiali giungere con passi affrettati dentro l’edificio dal fastigio adorno di comignolo. Vi è allocato il comando del 3º reggimento. Sono alpini della Taurinense inviati in quella zona per fronteggiare l’insorgente guerriglia dei partigiani comunisti. La sera dell’8 settembre sul volto di ognuno si legge l’ansia di sapere. Sapere che cosa sarebbe accaduto e come ci si sarebbe comportati. Il colonnello Maggiorino Anfosso spiega che bisognerà guardarsi dai tedeschi, oramai diventati i nemici. Ragazzi non illudetevi: nei giorni scorsi hanno recitato da ipocriti, ora che le carte sono state scoperte dovremo misurarci con la loro tracotante ostilità. Vertua ascolta in silenzio accanto al telefono: ha il compito di diramare gli ordini. Un maggiore inviato con il suo battaglione in soccorso di una divisione chiede quali sono le regole d’ingaggio se i crucchi faranno il viso dell’arme. A mezzanotte Anfosso dice a Vertua di far saltare le quattro strade attorno a Vilusi. E’ stato stabilito di arroccarsi a caposaldo. Vertua ha ventidue anni da compiere e scarsissima esperienza militare: l’ordine lo lascia perplesso, però l’ha diramato l’ufficiale che ammira di più e non osa pensare che sia sbagliato. Appronta dunque il plotone, prendono gli esplosivi e si avviano verso il quadrivio. Vertua non spiega alle sue penne nere che è stato firmato l’armistizio, che le strade vanno minate per difendersi dai tedeschi. Teme che la situazione precipiti, che quei giovani che lo fissano dubbiosi gli dicano che non ci si può arroccare senz’acqua. A Vilusi, infatti, non esistono riserve. Ogni mattina arrivano le autobotti con la dotazione giornaliera: tre litri a testa da bere. Per lavarsi si usa l’acqua delle rogge e delle fosse. Ma senza strade, addio autobotti. E che cosa berremo? Le quattro grosse deflagrazioni svegliano il presidio, paradossalmente servono a far diffondere la notizia dell’armistizio. Non c’è gioia tra gli alpini. Nessuno esulta, tutti si chiedono che cosa sarà della Taurinense sparpagliata da Ragusa a Cattaro, da Herceg Novi a Plevlja, da Niksic a Prijepolje con difficoltà di comunicazione, con le radio che funzionano male, in un territorio dove i nemici abbondano. Ci sono quelli ufficiali, i partigiani di Tito che militano nell’Eplj (Esercito popolare di liberazione jugoslavo); ci sono quelli mascherati da alleati, gli ustascia di Ante Pavelic, fascisti così assetati di sangue da entrare spesso in rotta di collisione con il quieto vivere degli italiani; ci sono i nemici altalenanti, i cetnici del generale Mihajlovic, i primi nella primavera del ’41 a cominciare la resistenza nel nome del re Pietro, ma che poi hanno raggiunto un’intesa con gli ufficiali della Wermacht e soprattutto con quelli del regio esercito. Li unisce la comune fedeltà all’istituto monarchico. Proprio in Montenegro l’intesa si è trasformata in un’azione comune contro i comunisti e contro gli ustascia, che da mesi smaniano di vendicarsi. Adesso si aggiunge il nemico più temuto e più esecrato, il vecchio nemico dell’unità d’Italia: l’austro-tedesco. Non è una notte in cui si riesca a dormire. Vertua è angosciato per quanto non è stato fatto dopo il 25 luglio e per il salto nel vuoto che li attende. Suo padre non ha mai voluto prendere la tessera fascista, ma la famiglia della madre è più nera del sugo di seppia. Edoardo ha seguito il padre. La sua giovinezza è stata riempita dai romanzi inglesi e americani, all’università ha annusato le prime larvate forme di opposizione. I mesi di addestramento in montagna l’hanno esaltato. Assieme al coetaneo e concittadino Peppino Prisco si è fatto le ossa con un ufficiale che ha amato e stimato, il capitano Giuseppe Lamberti, l’ultimo comandante del leggendario battaglione Monte Cervino in Unione Sovietica. Lamberti è fra i moltissimi che nella primavera del ’43 non sono tornati. Dicono che sia prigioniero, ne raccontano però così tante su quelli rimasti nella steppa ghiacciata che vallo a sapere qual è la verità. Nel dormiveglia affannato torna in mente a Edoardo il drammatico colloquio col padre durante la licenza per esami trascorsa a Milano in primavera. Chissà se rivedrà più la Madonnina, chissà se rivedrà più i suoi. Da mesi si porta dentro una sottile angoscia ispessita dall’affermazione di Badoglio il 26 luglio: la guerra continua. Ma che significa? E contro chi continua? Vertua il nemico lo capta attorno a sé. Sono i tre gerarchi spediti al 3º reggimento all’inizio di agosto, con la giacca dell’immacolata divise zeppa di nastrini e di onorificenze conquistati dietro una scrivania. Sono gli ufficiali del Fenestrelle, il suo battaglione, che avevano sabotato la radio per impedire agli antifascisti di ascoltare i sermoni del colonnello Stevens da Londra. Sono i tanti fascisti che si annidano nella divisione come il maggiore Cosenza, comandante dell’Intra, come il maggiore Nasso, che al Fenestrelle ha sostituito il vecchio tenente colonnello Galliano caduto in primavera, come il più inviso di tutti, il tenente colonnello Armando Farinacci, il fratello di Roberto, l’odiato ras di Cremona. Che cosa faranno tutti questi? E che cosa farà il generale Vivalda, il comandante della Taurinense, che il mormorio della truppa chiama Fifalda? Vertua teme il peggio come lo ha temuto nei quaranta giorni precedenti dinanzi all’ottimismo di facciata. Sono venuti allo scoperto i rari aderenti a ’Giustizia e libertà’, quasi timorosi, però, di far opera di proselitismo. Si sono accontentati di riconoscersi Hanno suonato la grancassa i giornali che arrivavano a pacchi dall’Italia con sette giorni di ritardo. Ufficiali superiori sempre bravi nel tenersi accuratamente lontani da qualsiasi prima linea hanno spiegato come e perché sarebbe andata in ogni caso bene. A far intendere che si scivolava verso il peggio ha inopinatamente provveduto la propaganda inviando a Vilusi due film tristissimi. Un lenzuolo bianco stesso sotto le stelle, proiettore a petrolio, sedie e panchetti a centinaia per una spanciata di malinconia: ’Se non son matti, non li vogliamo’ con Gandusio, Ruggeri, Falconi; a seguire ’La maestrina’. Lo scuro delle immagini ha accentuato l’atmosfera tetra. Vertua rammenta ancora il passaggio dei bulgari pieni di presupponenza e di miseria, povere compagnie al guinzaglio dei germanici. Il comando della Wermacht li ha fatti sfilare sotto gli occhi degli italiani per dimostrare che avevano già la truppa con cui sostituirli. Albeggia, ma il sollievo del chiarore dura poco. Anfosso convoca Vertua: bisogna rimettere in sesto le strade appena divelte, tappare i buchi, ripristinare in una parola la viabilità. Vilusi è destinata a diventare il punto di ritrovo per le compagnie e i battaglioni della Taurinense, dell’Emilia, della Ferrara, della Venezia sfuggiti ai tedeschi. E poi? Poi si vedrà, ma è già chiaro che l’alternativa all’ex alleato non sono i cetnici, bensì i partigiani comunisti con i quali si è fatto a schioppettate fino a ieri. Le Bocche di Cattaro, il mare appaiono troppo lontani per pensare di raggiungerle e di salire sulle navi che sicuramente - ciascuno è pronto a giurarci - manderanno dall’Italia. Vertua corre con il suo plotone a ripianare gli sconquassi. Un lavoro massacrante, una fatica bestia, che non tolgono però dal cervello l’ansia per tutto ciò che s’ignora. Conclusa l’opera viene difatti comunicato che le disposizioni sono nuovamente cambiate: gli alpini lasciano Vilusi, cominciano a salire, puntano verso l’interno del Montenegro. Al Fenestrelle appartiene anche il sottotenente Luigi Morena, militare di carriera. Era ragioniere, iscritto al terzo anno di università in economia e commercio, quando nel 1938 ha partecipato al corso allievi ufficiali di Bassano del Grappa. Si è innamorato della divisa, addio a estimo e partita doppia. L’anno dopo è stato ammesso all’Accademia di Modena. Ha lasciato la Cuneense con i lucciconi agli occhi. Ignorava di aver probabilmente salvato la vita evitando di essere spedito in Urss con la divisione. La Cuneense sulla steppa ghiacciata ha conquistato l’etichetta di ’gloriosa’, ma quante lacrime, quanti addii (oltre 17 mila partiti, 1900 rientrati). Morena è stato assegnato alla Taurinense. Sono così arrivati i mesi di presidio al confine tra la Dalmazia e il Montenegro in quel fritto misto di popoli e di amministrazioni, dove ogni scusa sembrava buona per ammazzarsi. L’8 settembre Morena sta a Ledenice sotto Vilusi. Nella ridda di voci si dice che il Cattaro possa essere la zona d’incontro per i reparti del XIV corpo d’armata, che ha il comando a Pogdorica con il generale Roncaglia. Se le quattro divisioni (Taurinense, Emilia, Ferrara e Venezia) riuscissero a riunirsi non dovrebbe essere difficile contrastare i ’cacciatori’ della 118a divisione corazzata. Ma incominciano i mal di pancia, i pronunciamenti, i distinguo. Chi non vuol andare contro i tedeschi e chi pretende che non si stringano patti con gli jugoslavi, soprattutto con i titini. Sempre più sconcertato Morena assiste a una sarabanda di opinioni, di iniziative personali. Ciascuno si arrangia ed è la fine di tutto. Il 13 settembre il Fenestrelle e l’Exilles vengono caricati sulle autocarrette. Destinazione gli antichi forti di Gruda, dai quali si controlla l’accesso alle Bocche con l’aggiunta di un campo d’aviazione, dove molti sperano che possano atterrare gli aerei con i rinforzi. I forti sono però presidiati dai battaglioni germanici. Viene diffusa la notizia che Ragusa è caduta. Lo scoramento si trasforma in disperazione. A Ragusa stavano la divisione Marche e gli amici, i conoscenti del battaglione Pinerolo, anch’esso del 3º. La presa dell’antica colonia veneziana significa che i tedeschi potranno stringere da due lati il Cattaro. E’ l’ora dei voltafaccia, del si salvi chi può. L’attacco concentrico ai forti di Gruda si sminuzza in singoli episodi, perde efficacia. Con gli azzeccati colpi dei 47/32 dell’Exilles il tenente colonnello Farinacci favorisce la conquista di uno dei forti, poi, però, proclama a voce alta che non ci sta e passa con i tedeschi. Dal suo comando sopra Zelenica Anfosso annuncia di voler puntare verso i contrafforti della Bjela Gora: si unirà agli jugoslavi, cetnici o comunisti che siano, per continuare la lotta. A Morena non piace il cambio di campo, ma si fida di Anfosso. Nel subbuglio di quelle ore anch’egli cerca qualcosa cui aggrapparsi. Intuisce che quanto resta dell’Italia comincia dal non arrendersi al tedesco. Ha fatto un giuramento al re e non lo tradisce. Si va su irti sentieri di montagna sotto la minaccia costante degli Stukas tra ostacoli naturali e improvvise puntate dei locali: diventa persino problematico capire se si tratta di volgari rapinatori, di soldati di Mihajlovic o di appartenenti all’Eplj. Compaiono due autocarri, un maresciallo si sporge dal finestrino per urlare che il colonnello ha ordinato alla Taurinense di raggiungere il porto di Zelenica e d’imbarcarsi per l’Italia. Morena impiegherà anni prima di appurare che il colonnello dispensatore di quell’ordine non era Anfosso, ma Ciglieri, il capo di stato maggiore della divisione. Morena s’avvia convinto di eseguire un ordine del suo comandante. Il porto di Zelenica gli richiama alla mente le letture scolastiche, le dotte citazioni dei professori sui fiumi dove cominciava l’inferno, l’Acheronte, lo Stige. Qui, però, mancano persino i Caronti. Un’umanità ora dolente ora imbizzarrita preme per salire sul ’Diocleziano’, la carboniera che rappresenta l’unica mezzo per rientrare in Italia. Sono in gran parte fanti dell’Emilia, tra i fuggitivi figura anche il comandante della divisione, il generale Buttà. Si lascia alle spalle senza molti imbarazzi le compagnie impegnate a trattenere le avanguardie della 118a divisione corazzata. Morena si ritrova a bordo sospinto dalla fiumana. Non sa nuotare, il mare non l’attira, la traversata con l’incubo della Luftwaffe lo terrorizza. Perde il contatto con il plotone, cerca un ufficiale che gli chiarisca la situazione e gli consenta di recuperare i suoi alpini. Ma nessuno sa niente, nessuno si assume responsabilità. Tutti vogliono montare sull’imbarcazione. Il capitano fa mollare gli ormeggi per respingere l’assalto dei tanti sul molo che urlano di non abbandonarli. In quel caos di bestemmie e di singhiozzi, di preghiere e di maledizioni la carbonaia prende il largo. L’indomani sono a Bari. Nella notte fra l’8 e il 9 settembre Giampaolo Venanzetti è svegliato di soprassalto dal trambusto scoppiato nel vagone. Non si va più in Calabria a combattere gli Alleati… Abbiamo firmato l’armistizio… L’ha detto Badoglio alla radio… E’ finita la guerra… Ci rimandano a casa… Invece la tradotta con a bordo mezza divisione Legnano viene dirottata verso Brindisi. Venanzetti non si raccapezza, ma fiuta che il peggio non è passato, anzi deve arrivare. Lui e gli altri provengono da un’estate di dubbi e di apatia. Che la guerra fosse persa era diventata una certezza ogni giorno di più, però il dopo non s’intravedeva. Neppure il crollo di Mussolini e del fascismo ha all’apparenza influito su quel tirare avanti che ogni mattino individuava come traguardo la sera. Sono stati richiamati dalla Francia dopo due anni di dolce guarnigione sulla Costa Azzurra a presidiare i piccoli aeroporti del litorale. Venanzetti ha con sé la pistola mitragliatrice dono di un tedesco. Altri tempi. A Ventimiglia ha sperimentato che l’idillio con i camerati apparteneva ormai del passato: quelli della Wermacht li hanno bloccati per due giorni. Dopo si sono attendati a Casalecchio. Giampaolo ha fatto un salto a casa, a Milano. Dieci giorni in famiglia a rincuorare i genitori, che di figli sotto le armi ne hanno tre: Michele, il maggiore, con la ricostruita Folgore a Tirrenia, Pierluigi con la Nembo in Sardegna e infine lui, volontario universitario a vent’anni, nel ’41. Venanzetti si è mantenuto indifferente al fascismo e abbastanza refrattario alle pagliacciate del regime, ma in agosto ha avvertito che qualcosa d’improcrastinabile era sul punto di presentarsi. Si è accorto che suo padre Alberto è di colpo invecchiato, segnato dagli affanni per i tre figli in divisa. Lui Pierluigi e Michele hanno soltanto proseguito una tradizione di famiglia: il nonno con Garibaldi, il padre sedicenne all’avventura in Sud Africa, dove aveva imbracciato il fucile con i boeri contro gli inglesi. Rientrato, si era laureato nel 1915, appena nato Michele. Aveva poi fatto il diavolo a quattro per arruolarsi. Era stato accontentato giacché l’esercito aveva estremo bisogno di bravi ingegneri. Aveva così chiuso da maggiore del genio. Ma quella era stata la guerra dei sentimenti e degli ideali, la conclusione di un secolo di lotte, mentre questa al vecchio Venanzetti appariva sconclusionata e priva di nobiltà. Sono stati questi pensieri e questi ricordi a far compagnia a Giampaolo Venanzetti nella notte che è rischiarata in alba. Entrando nella stazione di Brindisi non ha dubbi di appartenenza. Lui starà con il re. Il sole non è del tutto declinato quando al campo di Capoterra, vicino alle saline in periferia di Cagliari, un forsennato si presenta urlando: "E’ finita la guerra, è finita la guerra." All’amico che si precipita ad abbracciarlo per festeggiare l’imminente ritorno a casa Alvaro Corradini risponde di mala grazia: "Non hai capito che per noi la guerra comincia ora?" e se ne va verso la tenda a preparare il materiale. Manca qualche minuto alle 18 dell’8 settembre e chissà attraverso quali vie la notizia dell’armistizio ha raggiunto quel paracadutista, che l’ha subito comunicata ai colleghi della Nembo, una divisione di fresco conio. Corradini vi milita fin dalla fondazione a dicembre presso il centro addestramento di Tarquinia. E’ stato chiamato, diciannovenne, in settembre. Ha lasciato la natia Domodossola con un’idea fissa in testa: diventare parà. Quattro mesi a Tarquinia ad imparare i rudimenti, da aprile a Viterbo a fare sul serio. La Nembo è l’unica grande unità ad avere in dotazione i fucili mitragliatori Beretta, da 30 e 40 colpi, anziché il vetusto fucile ’91. La divisione nasce con una leva di fuori di testa senza eguali: arriva persino un gruppo di bersaglieri, che ogni volta si lanciano con biciclette e motociclette. Dovrebbero costituire un reparto di assaltatori da scatenare alle spalle del nemico, ma per l’esercito italiano non esistono più offensive, è cominciato il triste conto alla rovescia in attesa dell’invasione anglo-americana. A fine primavera è ormai chiaro che l’obiettivo sarà la Sicilia, tuttavia anche la Sardegna è considerata a rischio ed è qui che dal 2 giugno si posiziona la Nembo con bici e moto a immalinconire nei depositi. Uno dei tre reggimenti, il 185º, viene spedito in Sicilia e indi schierato in Calabria. Gli altri due si adattano al tran tran di settimane e mesi senza sugo. Nella Roma badogliana ci si fida poco di questi paracadutisti: vengono considerati fascisti a tutto tondo, molti provengono dalla gioventù littoria, sono cresciuti con il mito del bel gesto e dell’insubordinazione. Dall’8 sera, però, tutto cambia. Corradini è stato un cadetto della Gioventù italiana littoria, per Mussolini e per il fascismo avrebbe dato un braccio, adesso assieme ai commilitoni del 183º si stringe attorno al colonnello Quaroni. Le sue parole sono chiare: se restiamo compatti, ci salveremo. Quaroni riceve con grande cortesia gli ufficiali tedeschi dei quali ventiquattr’ore prima è stato ospite a cena. Rifiuta ogni ipotesi di consegna delle armi, dimostra di non temere lo scontro armato, accetta di far passare le colonne germaniche. Il 9 Corradini con il Beretta in mano assiste alla sfilata dei battaglioni verso nord, verso l’imbarco per la Corsica. Nella casa paterna di Domodossola altri destini sono in compimento: Giacomino, il fratello più giovane, diciottenne, è pronto a unirsi ai partigiani, mentre Giordano, il più grande, andrà a Salò con la Guardia repubblicana. All’hotel Oriente di Bari soggiorna dall’inizio di settembre il sottotenente Luigi Poli. E’ in attesa d’imbarcarsi per il primo incarico: destinazione Montenegro, gruppo Aosta della Taurinense, 1º reggimento d’artiglieria alpina. Poli è un ventenne torinese la cui indifferenza al fascismo è mutata, durante il corso allievi ufficiali, in critico distacco. La qualcosa però non l’ha fermato dall’offrirsi in gennaio volontario per l’Unione Sovietica. Il disastro dell’inverno ’43 gli ha evitato di partire. In estate l’hanno assegnato alla Taurinense, ma il trasferimento da Venezia è stato annullato a causa dei sabotaggi alla ferrovia da parte dei partigiani jugoslavi. La tradotta li ha condotti fino a Bari: un viaggio doloroso attraverso un’Italia ferita e prostrata. Poli ha toccato una realtà della quale nessun bollettino ha mai parlato. A Bari si sarebbe dovuto imbarcare il 6, ma la presenza di sommergibili inglesi nel basso Adriatico ha fatto cancellare la traversata. La sera dell’8 assieme alle altre reclute della Taurinense ascolta nel salone dell’albergo l’annuncio radiofonico di Badoglio. In città si festeggia: è l’illusione della guerra finita. Bastano poche ore per cancellarla. Al mattino staffette e portaordini attraversano Bari alla ricerca di quanti indossano ancora la divisa: sono convocati al comando del generale Bellomo. E’ una sorta di appello disperato, cui non tutti rispondono. Il generale spiega che i tedeschi incombono, che stanno piazzando posti di blocco agli incroci e occupando il porto: forse vogliono soltanto andar via, forse intendono fortificarsi. In ogni caso, occorre liberarsene. Chi se la sente? A coloro che accettano, e Poli vi figura come vi figurano alcuni ex camicie nere, vengono distribuiti bombe a mano e qualche caricatore. L’atmosfera è da moto di piazza, ci si affida all’intraprendenza dei singoli, spesso ufficiali e soldati sono mescolati alla rinfusa, l’importante è far numero. Si va per spirito di gruppo, per attaccamento a quell’unica parola che nella mattina di sole possiede ancora un senso: Italia. I tedeschi vengono respinti, il porto liberato. Bari è pronta ad accogliere le avanguardie dell’8a armata di Montgomery. E il 10 accoglierebbe anche i vigliacchi d’altobordo - il re, Badoglio, generaloni, ministri - scappati da Roma e in navigazione sulla corvetta Baionetta, se misteriosamente non fosse comunicato da terra che la città è occupata dalle truppe germaniche. Gran parte dei militari viene trasferita a Lecce. Nel trambusto Poli è alleggerito del portafoglio. E senza soldi in quei giorni si rischia di non mangiare. Fra i militari in ascolto attorno alla radio dell’hotel Oriente il più giovane è un altro sottotenente torinese di artiglieria, Giorgio Donati, diciannove anni. Quando due settimane prima si è presentato al comandante del deposito di Alpignano per chiedere un permesso di ventiquattr’ore, l’anziano ufficiale l’ha squadrato ben bene. A cosa ti serve? Ad andare a casa… Perché? Li voglio salutare, parto per il Montenegro, 1º reggimento di artiglieria della Taurinense, gruppo Susa… E nel dirlo Donati si è quasi impettito, già fiero al solo pensare di esserci. Il comandante del deposito ha avuto un soprassalto: in quel ragazzino ha visto suo figlio e tutti i figli d’Italia mandati al macello in una guerra dove rimaneva soltanto d’attendere l’ufficializzazione della sconfitta. A Donati ha dato tre giorni di permesso. Sessantadue anni dopo il ricordo di quelle ore trascorse a casa, ultimi lampi di serenità prima che sopraggiungesse la tempesta, rimangono incancellabili per l’ex sottotenente divenuto generale di corpo d’armata. Assieme al ricordo la riconoscenza per lo sconosciuto ufficiale capace di farsi guidare dalla propria umanità nonostante i tempi. All’annuncio dell’armistizio Donati non si lascia contagiare dall’entusiasmo montante nella hall dell’albergo: sente che è soltanto cambiato il nemico. La guerra continua. Ed è una guerra in cui lui ha fatto di tutto per entrarvi. Nel ’40 ha saltato il secondo liceo al collegio militare di Roma per paura che tutto finisse lasciandolo fuori. E’ stato uno dei tanti a prendere sul serio la previsione di Mussolini sul Natale da trascorrere sotto l’albero nella nuova Europa asservita al nazi-fascismo. Per quanto figlio della sua epoca e della propaganda che la condizionava, Giorgio è stato più monarchico che fascista. Il padre era un carabiniere a cavallo, l’infanzia e la giovinezza sono state trascorse in caserme odorose di stalla. In quell’ambiente è cresciuta e maturata una forte fedeltà al re piuttosto che al duce. Al collegio militare ha sempre intonato ’Cunservet deus su re’, la canzone sarda che da secoli inneggia ai monarchi sabaudi. Nel settembre del ’41 Donati si è iscritto all’Accademia d’artiglieria di Torino già convinto di voler andare con gli alpini, benché papà spingesse per i carabinieri. Ma Giorgio ha ereditato dalla madre, originaria della val di Susa, una profonda passione per la montagna. Nel dicembre ’42 i pesanti bombardamenti sulla capitale sabauda hanno suggerito di trasferire corsi e allievi dell’Accademia a Lucca. Tra la primavera e l’estate del ’43 i neo sottotenenti hanno completato la loro istruzione al centro addestramento di Nettuno e sulle vette intorno a Cortina. Ormai appariva chiaro che la guerra fosse persa, ma per uno come Donati il dovere prima di tutto e con esso l’ubbidienza assoluta a Vittorio Emanuele. D’altronde che cosa ne può sapere un diciannovenne impastato di patria, bandiera, Risorgimento dei grossi sommovimenti sotterranei che hanno preparato lo sbarco alleato in Sicilia, la deposizione di Mussolini, il cambio di trincea? Se arriva dunque la disposizione di recarsi in Montenegro non si pensa ai rischi, all’inutilità dell’incarico; si pensa a obbedire, ci si eccita all’idea dell’avventura: un saluto a babbo, mamma e sorella prima di correre a Mestre per salire sulla tradotta diretta in Jugoslavia. Tranne scoprire che i binari non sono più garantiti. Giù fino a Bari per attraversare l’Adriatico. Ma le navi non escono dal porto per l’incombenza dei sottomarini nemici. Ci si trova di conseguenza a comandare un plotone misto che ogni mattina viene mandato a scavare buche anti atterraggio a sud della città. E permane insondabile se è la strategia a pretendere le buche o se sono le buche ad avere la funzione strategica di tenerli impegnati. La notte del 9 settembre non si dorme all’hotel Oriente. Al mattino è un rincorrersi di voci, sovrastate da un imperioso comando in dialetto piemontese: ’nduma fioi’. L’ha pronunciato un soldato semplice, eppure tutti, ufficiali e graduati, corrono ad armarsi. Donati preleva un fucile modello ’91 e sei caricatori. Via verso il porto senza distinzioni di grado. Lì pare che ci siano i tedeschi, da lì bisogna cominciare perché il re lo vuole. All’apparire di quella truppa senza comandanti, però decisa a far valere il numero, i guastatori germanici si allontanano. Vola qualche fucilata più d’esultanza che d’avvertimento. Nella Bari evacuata dalla Wermacht, Donati assapora il gusto della missione compiuta. Gli è piaciuta questa piccola azione di grande spessore ideata e condotta per puro orgoglio da militari di ogni rango. L’arrivo a Brindisi del re, dei generali e degli ammiragli lo tranquillizza sul futuro. Lo Stato e la monarchia esistono e persistono. A lui spetta servirli. Qualche mattina dopo partecipa al più singolare dei rapporto ufficiali: sulla spiaggia di Zollino il maresciallo e capo di governo Badoglio annuncia che l’Italia sarà rifatta schierandosi al fianco degli anglo-americani. Donati freme: ha la sua guerra d’indipendenza. Giovanni Corvino ha trascorso un’estate di furori e di tormenti. Ha dato per mesi la caccia ai partigiani sloveni nell’alto Isonzo, ha giocato con la morte nella speranza di cancellare i ricordi, ma la Russia, la valle della Kalitva sono una scheggia conficcata nel cuore. Dal mattatoio sovietico l’aveva tirato fuori una raffica di mitra dalle parti di Selenyi Jar, il quadrivio insanguinato, la tomba di migliaia di alpini della Julia, il culmine dell’orrore e anche dell’orgoglio dei pochi tornati. Lì il 28 dicembre del ’42 il ventenne Corvino, sottotenente del Val Cismon, 9º reggimento del colonnello Fausto Lavizzari, aveva rimediato una ferita all’omero sinistro. La disfatta dell’Armir nel mare bianco era prossima, ma le retrovie degli alpini ancora funzionavano, gli ospedali da campo anche e da Rossosch continuavano a partire i treni-ospedali. Corvino aveva avuto la fortuna di esser caricato su uno di essi. Dopo una sosta al famoso ospedale numero 8 di Karkov - in quei mesi vi passarono circa cinquantamila soldati italiani - era stato ricoverato a Senigallia. Corvino è guarito nelle settimane del mesto rientro dall’Urss dei pochi smunti e sconvolti sopravvissuti. Erano bastati diciassette convogli ferroviari quando appena nove mesi prima ne erano occorsi più di duecento per trasferire nella steppa le tre divisioni di penne nere. Anche Corvino partecipa alla triste cerimonia della ricerca dei troppi che risultano assenti. Pochi i morti sicuri, tantissimi i dispersi. Volti amici, volti conosciuti, compagni di scuola, colleghi di corso, fratelli di sventura per i quali si confida che siano prigionieri o in salvo con i tedeschi in qualche landa sperduta. E Corvino, volontario a poco più di diciotto anni, ha il torto di aver girato molte formazioni alpine: è stato al 7º, è stato alla scuola militare di Aosta, è stato all’Edolo, è stato al Val Cismon quando figurava nel 7º e vi è rimasto quando l’hanno spostato nel 9º. Di parecchi che mancano all’appello potrebbe raccontare un aneddoto, indicare una qualità. E’ la ferita che gli brucia dentro, che lo spinge a ripresentarsi dove ricostituiscono il Val Cismon, a insistere per esser inviato in prima linea. Ma nel maggio del ’43 l’estrema prima linea del nostro esercito è la lotta ai partigiani. Corvino va nella speranza, vana, che il rischio quotidiano possa curare il suo male interiore, la rabbia contro tutti e contro tutto. Ce l’ha con i tedeschi, dai quali si è sentito fregato in Unione Sovietica; ce l’ha con il regime, che li ha mandati allo sbaraglio senza armi, senza indumenti, senza carri armati; ce l’ha con l’Italia avvolta nel torpore e massacrata dai bombardamenti alleati. Il 25 luglio passa senza lasciare traccia. L’8a armata, cioè il vecchio Armir, si sta ricomponendo nel Triveneto, ma ogni giorno tocca assistere al transito delle divisioni della Wermacht dal Brennero. L’8 settembre squillano le trombe del giudizio universale pure per quanti si ritengono pronti a respingere gli attacchi da qualunque parte provengano, come sostenuto nell’ambiguo comunicato di Badoglio. Il Val Cismon sarebbe tra essi, ma può soltanto raggiungere Gorizia e impedire ai partigiani sloveni di minare il ponte. Con gli autocarri si va al centro di mobilitazione del battaglione a Feltre per consegnare le armi e il materiale recuperati. Il suggerimento è di sciogliersi. Il maggiore Oliva augura buona fortuna. Viene fatto sapere ai tedeschi che se proveranno a bloccare l’esodo saranno presi a fucilate. Sulla soglia della caserma Corvino abbraccia due amici per la pelle, il tenente Mario Tognato del Val Cismon e il tenente Giovanni Ballico del Vestone. Sono due dei pochi riemersi dall’inferno russo di gennaio, esibiscono cicatrici e decorazioni. Ballico ha combattuto anche a Nikolajewska, è stato insignito di due medaglie d’argento. I tre promettono che s’incontreranno dopo la guerra. Tognato va alla macchia. Ballico ritiene che il codice d’onore pretenda da lui un’estrema fedeltà all’Italia dell’Asse. Corvino non sa come comportarsi e dove dirigersi. Un generale e un sottotenente medico fanno opera di convincimento per conto dei tedeschi. Corvino cerca di dissuadere gli indecisi spiegando come i crucchi li hanno fregati in Russia e come sono pronti a fregarli di nuovo. Il dottor Salvatore Vergani, sanitario del Val Cismon, offre un rifugio nella sua casa di Montebelluna. Il viaggio è ardimentoso. Il Tagliamento viene guadato con un ufficiale più anziano, destinato a occupare un posto di rilievo nella Repubblica, il futuro ministro democristiano Luigi Gui. L’ennesimo proclama di Badoglio invita gli italiani ad aspettare tranquilli i liberatori che giungeranno in pochi mesi. Un esule appena rientrato incita ad accorciare i tempi unendosi alla bande partigiane. Sono quelle slovene contro le quali Corvino si è battuto fino a un mese prima: niente da fare, meglio tentare l’avventura di rivedere papà e mamma a Foggia. In borghese, su treni procedenti a singhiozzo con fermate e partenze dettate dall’aviazione anglo-americana, sotto controlli tedeschi sempre più assidui, Corvino a fine settembre scende alla stazione di Ancona. Al controllo dei documenti incappa in una retata. Lo ingabbiano assieme a tanti altri nella caserma Cialdini: la voce comune è che li deporteranno in Germania. Approfittando di una distrazione del corpo di guardia, Corvino evade, monta su un treno fino a Pescara. Da qui si muove a piedi, possibilmente di notte giacché i rastrellamenti della Wermacht battono palmo a palmo la regione. S’incrociano militari meridionali diretti a casa e militari continentali diretti al Sud per riprendere la guerra con l’esercito del re. Ci si unisce e ci si lascia a secondo delle circostanze e delle impuntature. Si superano fiumi e posti di blocco. Il 12 ottobre il balzo conclusivo consiste nel superare la linea del fronte tra Guglionesi e Montenero di Bisaccia. Mamma e papà Corvino ringraziano santi e madonne per il miracolo di un figlio restituito. Ma conclusi festeggiamenti, pranzi, bisbocce e giro del parentado, Giovanni decide che lui ha fatto un giuramento a Vittorio Emanuele III e soprattutto ai tanti amici dispersi in Unione Sovietica. Si presenta al distretto militare di San Severo: eccomi qua. Mi volete? La visione della Milano di agosto ha stretto il cuore di Eugenio Bedina. E’ un ragioniere ventiduenne che da quasi tre anni sta sotto le armi benché sia figlio unico di madre vedova. Ha avuto una licenza straordinaria perché l’appartamento materno in via San Giovanni sul Muro è stato lambito dalle fiamme durante i furiosi bombardamenti alleati. Il permesso scade all’alba del 9 settembre. Alle 16 dell’8 la stazione Centrale pullula di militari in partenza. Il treno per Bari è stracolmo. Bedina dondola in piedi di fronte a una bella ragazza con un neonato in braccio. Ogni quattro ore lo allatta: tira fuori dalla camicetta un seno turgido e Bedina non riesce a ignorarlo, ha anche sete per il gran caldo e quella mammella gli pare racchiudere ogni delizia. Sarà anche per questa visione che i mortaretti solcanti il cielo dalle parti di Bologna non l’incuriosiscono. Immagina che tra una pausa e l’altra delle incursioni aeree qualcuno in Italia abbia ancora voglia di festeggiare il santo patrono. I tre vagoni in coda al convoglio sono zeppi di fanti germanici diretti verso le postazioni della linea Gustav. Il controllore riferisce che sono tranquilli ed educati. Perdura il buio quando scendono sotto lo sguardo indifferente dei pochi svegli. Alle 6 nella stazione di Bari Bedina scopre che cos’è accaduto la sera prima, ripensa ai mortaretti. A Bitonto, sede del LI battaglione bersaglieri d’istruzione, il tenente colonnello Trapani lo accoglie sarcastico: bravo lo scemo, perché non sei rimasto a Milano? Se lo chiede anche il ragionier Eugenio. Ma a Milano che cosa avrebbe combinato? Lui ha smesso di esser fascista dal giorno della dichiarazione di guerra, tuttavia non può dirsi neppure antifascista. Elucubrazioni e rimpianti vengono interrotti da una telefonata concitata del generale Amato, comandante della 209a divisione costiera: servono rinforzi per strappare il porto di Bari ai tedeschi. I bersaglieri se la sentono? Tradotto in soldoni: da che parte stanno i bersaglieri del LI? Il tempo per rispondere è quello di una moneta che vola per aria. Testa o croce? Con il re o con Hitler? Trapani dà l’ordine di partenza immediata. L’ora necessaria, cioè, a caricare armi, munizioni e uomini. La 3a compagnia rinuncia alle moto, la 1a alle biciclette. Si va di fretta con tutto quello che c’è di reperibile a quattro ruote. Alle 17 il battaglione prende posizione attorno al porto. Le velleità germaniche sono state già piegate dall’intervento di altri militari italiani, ma dentro resistono trecento granatieri. Le voci più disparate li descrivono pronti a tutto, decisissimi a non mollare. Si odono rari colpi di fucile. La 2a compagnia viene designata per l’attacco. Bedina si torna a chiedere che cosa sarebbe stato di lui se fosse rimasto a Milano. Si arrendono, si arrendono… L’urlo precede la comparsa del drappo bianco nelle postazioni tedesche. I bersaglieri con il dito sul grilletto assistono alla sfilata degli ex camerati. La 2a compagnia li scorta fino alla stazione per caricarli sul treno diretto a Foggia, le altre due rastrellano il porto. Viene rinvenuto il cadavere di un sottufficiale. Il LI è di nuovo in guerra. Sergio Macciò è a passeggio con un ex compagno di classe allorché nel grande viale di Zara si diffonde la notizia che qualcuno alla radio ha annunciato la fine della guerra. E’ possibile? Ma sì che è possibile. E’ stato Badoglio in persona a dirlo. Sergio ne è stupito solo in parte. Si aspettava che accadesse qualcosa. Per lui il vero, traumatico choc è stata la deposizione di Mussolini. E non perché fosse più fascista degli altri, fascista lo è stato al pari degli altri avanguardisti di Zara, ma perché non avrebbe mai pensato che tra i golpisti del 25 luglio, cioè tra i firmatari dell’ordine del giorno Grandi, potesse rientrare sua eccellenza Giuseppe Bastianini, l’ex governatore della Dalmazia, fresco sottosegretario agli Esteri per espresso volere di Mussolini. Macciò aveva incontrato diverse volte Bastianini. Suo padre Serafino è un maggiore del presidio ed erano state innumerevoli le occasioni in cui aveva potuto ascoltare Bastianini manifestare nei confronti del duce dedizione e fiducia totali. Invece nella seduta del Gran Consiglio anche Bastianini, che pure non aveva diritto di voto, si è espresso contro il suo mentore. In quella fine di luglio il diciassettenne Sergio, che ha conseguito la licenza liceale in anticipo di due anni, ha cominciato a guardare con curiosità alle democrazie occidentali, agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna, ai demo-pluto-giudaico-massoni che sono sul punto di vincere la guerra. Forse non rappresentano quel peggio descritto dalla propaganda; forse sussistono convincenti elementi di forza nel loro sistema descritto come marcio: ecco i pensieri di Sergio. La sua estate è corsa su due binari. Da un lato la normale quotidianità, l’iscrizione alla facoltà di legge di Bologna, il concorso per l’accademia militare di Modena; dall’altro il sottile malessere interiore per la fine di un mondo che ha accompagnato la sua giovinezza, per le nubi che circondano l’immediato futuro, per la sensazione che niente e nessuno avrebbe potuto evitare il salto nel baratro. Dal centro di Zara Sergio corre a casa, chiede lumi al padre, che allarga sconsolato le braccia. Comincia l’attesa di indicazioni, di ordini che non arriveranno mai. Zara si scopre molto più lontana dall’Italia di quanto non dica la carta geografica. Diventa un rischio essere italiani dovendosi barcamenare fra i partigiani di Tito e le truppe tedesche. I soldati in grigioverde fanno il possibile per proteggere la popolazione. Avvengono scontri, si contano morti e tradimenti. Per settimane Zara vive sospesa in un limbo che è l’anticamera dell’inferno. Il maggiore Serafino Macciò rimane al suo posto fino all’arrivo degli alpini tedeschi il 28 ottobre, ventunesimo anniversario della marcia su Roma. Quella mattina Sergio e la mamma salgono sull’ultimo idrovolante in partenza per Trieste. Aghia è un minuscolo villaggio della Tessaglia che non compare nelle carte geografiche della Grecia a disposizione in Italia. Alessandro Silvestrini lo ha inutilmente cercato prima d’intraprendere il lungo viaggio in treno da Mestre. Ha vent’anni e i fremiti dell’età, della prima assegnazione per giunta in terra straniera. La sua passione per la carriera militare è stata figlia delle circostanze. Il padre sperava di farne un avvocato, ma a Codogno, dove la famiglia si era trasferita da Civitanova Marche, non esisteva il liceo classico così il quindicenne Alessandro ha optato per il collegio militare di Milano, cui è seguita l’Accademia di Modena. Nel luglio del ’43 con i freschi gradi di sottotenente è partito per quella che ai suoi occhi rappresenta la grande avventura, pur sentendo nell’animo che tutto stava per cambiare. Il viaggio in tradotta è stato lungo, travagliato, sotto l’incombenza degli agguati partigiani: Lubiana-Belgrado-Skopje-Salonicco-Larissa. L’approccio con il I battaglione del 313º reggimento, divisione Pinerolo, è stato brusco. Gli hanno subito chiesto notizie della patria lontana e lui ha risposto secco: il fascismo si trova a un passo dal crollo. Era il 22 luglio. L’hanno considerato un cacciaballe e sotto sotto un disfattista. Al pari dei coetanei Silvestrini è stato allevato nella mistica del regime, la sua adesione è però rimasta tiepida. Nel ’39 ha figurato fra i tanti allievi del collegio che non hanno applaudito una vibrante concione del federale di Milano e questi se ne è lamentato con il comandante. Il reggimento, come annunciava la sua numerazione cominciante con il 3, era un miscuglio di riservisti e di esuberi provenienti da altre armi, soprattutto dall’aviazione. Molti i trentenni, diversi quelli dalle ridotte attitudini fisiche, che alla visita di leva non sono stati scartati perché in tempo di guerra si raccatta tutto quello che c’è. Nel I battaglione gli ufficiali di carriera erano soltanto quattro, gli altri provenivano dalle arti e dai mestieri e ai medesimi sarebbero voluti ritornare il più presto possibile. Abbondavano i bergamaschi, in tal modo Silvestrini ha potuto riudire il dialetto di casa. Piccolo conforto in una situazione di generale degrado. Si è anche accorto che la sua era l’unica divisa a norma di regolamento, le altre apparivano lise e stinte. Quando, poi, venivano indossavate, cioè quasi mai. In quelle giornate di caldo asfissiante la tendenza era, infatti, di girare il meno vestiti possibile. E dopo due anni di guarnigione nessuno ci faceva più caso. Allo stesso modo nessuno badava agli zoccoli usati dalla truppa al posto degli scarponcelli ridotti oramai in condizioni miserrime. La motivazione ufficiale suggeriva di preservarli per i pattugliamenti e per le esercitazioni, ma con l’80-85 per cento di malarici di addestramento se ne compiva poco, molto poco. Il battaglione vive rinserrato nel caposaldo eretto attorno alle casupole e alle barracchette di legno usate quali dormitorio. Davanti e dietro è una distesa di mine. La prima volta che Silvestrini si è allontanato per una cavalcata è stata anche l’ultima. I veterani lo hanno sgridato: guai ad andarsene in giro da solo, le zone brulicano di partigiani. Gli italiani faticano a raccapezzarsi fra le tante sigle in circolazione, tuttavia hanno imparato sulla propria pelle che se l’appartenenza è incerta, certissima è la voglia di tagliare le gole ai nazi-fascisti. I più determinati sembrano i comunisti dell’Elas (Ellenikòs Laikòs Apelefterotikòs Stratòs, Esercito popolare greco di liberazione), i cui componenti sono chiamati ’andartes’, ai quali si contrappongono i repubblicani, però filo monarchici dell’Edes (Ethnikos Demokratikos Ellenikos Syndeymos, Unione nazionale democratica greca). Intorno a questi due schieramenti si agitano diverse formazioni non allineate, che interrompono i reciproci scannamenti solo per scannare gli occupanti stranieri. Eppure i rapporti con la popolazione sono formalmente buoni. Il dentista, che ha studiato e si è laureato in Italia, cura gratuitamente gli ufficiali. Con i contadini e con i pastori si è sviluppato un continuo commercio di prodotti agricoli e di bestie per il rancio dei soldati. Ma le difficoltà crescenti della guerra e la penuria degli approvvigionamenti fanno sì che a pranzo vengano serviti brodo e carne di pecora e a cena le frattaglie della pecora. All’inizio di settembre si sono sparse voci incontrollate di un rientro immediato in Italia. La voglia di un ritiro dal conflitto aleggia nell’aria, ma in che modo e quando? Nel pomeriggio dell’8 settembre i radiotelegrafisti del battaglione captano l’annuncio dell’armistizio diffuso a sorpresa dagli inglesi. Il capitano Bonaccorsi, che guida provvisoriamente il I, si mette in contatto con il comando di reggimento. Gli rispondono di prepararsi a cedere le armi pesanti ai tedeschi e tenere quelle individuali in vista di un reimbarco. Tuttavia Bonaccorsi rimane incerto: il tono di chi gli ha parlato non l’ha convinto. Il capitano convoca gli ufficiali, spiega le sue perplessità: teme che i tedeschi si siano già impadroniti dei comandi e tengano sotto minaccia gli addetti alle trasmissioni. Che fare? Serpeggia una maligna indecisione. A quanti sostengono di prendere le armi contro gli ex camerati si oppongono gli ufficiali dell’artiglieria timorosi della reazione germanica. Alla fine Bonaccorsi decide di far stendere grandi teli di comunicazione destinati all’eventuale ricognizione aerea. E’ una mossa ispirata: la cicogna germanica inviata a spiare le intenzioni del presidio comunica che il I battaglione non interporrà ostacoli. Il 12 giungono due ufficiali inviati da Infante, il comandante della Pinerolo. Il generale non si è fatto travolgere dagli eventi e ha subito deciso da che parte schierarsi. Lo manda a dire pure a Bonaccorsi raccomandando di prendere contatto con i partigiani, per quanto ignori se si tratti degli spietati comunisti dell’Elas, che negli ultimi sei mesi hanno inflitto dure perdite, o dei più addomesticabili filo monarchici dell’Edes, sostenuti dal governo britannico e presso i quali operano le missioni di Churchill. Bonaccorsi si rivolge al sindaco per avere un incontro con il responsabile della zona. Nello stupore collettivo si presenta il dentista, sulla cui amicizia più di uno avrebbe giurato. Bonaccorsi spiega che ha l’ordine di raggiungere i monti della Macedonia occidentale per unirsi ai partigiani, che sono quelli dell’Elas. Il dentista acconsente, però chiede subito di ricevere le armi e le munizioni, che gli italiani, afflitti dal problema dei malarici, non potranno trasportare. Il 15 incomincia l’estenuante marcia verso una nuova guerra. Silvestrini ha compreso che la Storia ha voltato pagina, che niente sarà più eguale a prima. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

