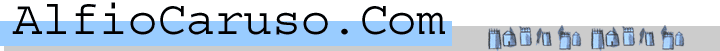
|
|
|
|
1
Chi muore, chi tradisce
 L’ultimo della Folgore a morire per El Alamein è stato nel 2006 Telino Zagati, 16ma compagnia, VI battaglione, 186º reggimento.
Aveva 85 anni. Nel 64mo anniversario della battaglia era andato insieme con il figlio Luigi a salutare i tanti amici rimasti nel deserto.
Lo faceva con regolarità dal 1984 indossando il basco rosso, serrando le mascelle per non cedere all’emozione, ancora ansioso di ritrovare
la propria buca, attorno alla quale aveva sepolto lo zainetto e le bombe a mano Balilla prima di cominciare il disperato ripiegamento alle
23 del 2 novembre 1942.
L’ultimo della Folgore a morire per El Alamein è stato nel 2006 Telino Zagati, 16ma compagnia, VI battaglione, 186º reggimento.
Aveva 85 anni. Nel 64mo anniversario della battaglia era andato insieme con il figlio Luigi a salutare i tanti amici rimasti nel deserto.
Lo faceva con regolarità dal 1984 indossando il basco rosso, serrando le mascelle per non cedere all’emozione, ancora ansioso di ritrovare
la propria buca, attorno alla quale aveva sepolto lo zainetto e le bombe a mano Balilla prima di cominciare il disperato ripiegamento alle
23 del 2 novembre 1942. Sfuggito ai carri armati britannici, sfuggito alla sete e alla fame di una ritirata senza meta, sfuggito agli anni della dura prigionia, Telino era atteso dal fato in un viale del Cairo a conclusione di una serata allegra: l’inciampo improvviso nello scavalcamento di uno spartitraffico, la caduta all’indietro, la testa colpita dalla ruota di un minibus procedente a velocità sostenuta e che continuava la corsa senza fermarsi a soccorrerlo. Dopo sono seguiti due mesi di straziante agonia in Italia, ma Telino è in pratica morto in quella capitale egiziana che costituiva lo sbocco dell’offensiva lanciata da Rommel nella primavera ’42. Quando la guerra, già segnata per le nazioni dell’Asse dall’ingresso degli Stati Uniti, aveva regalato l’ultima illusione con i panzer tedeschi all’assalto dalle pianure sovietiche alle distese egiziane e i soldati italiani arrancanti dietro alla ricerca di un veicolo che trasformasse le nostre divisioni autotrasportabili in trasportate sul serio. Invece il destino era già deciso. E per l’Italietta delle assai presunte otto milioni di baionette l’aveva fatto precipitare il suo buffo e sgangherato duce, l’aspirante borghesuccio di Predappio, che inseguiva la modernità, mentre viveva costantemente nel passato. Si atteggiava a comandante in capo dell’esercito, al contrario era rimasto il caporal maggiore del 1917 incapace di comprendere l’importanza delle portaerei, degli aerosiluranti, dei carri armati, degli immensi giacimenti di petrolio sotto lo scatolone di sabbia della Libia. Quanto, insomma, sarebbe servito per affrontare con un minimo di decenza l’agognato conflitto, che avrebbe dovuto sancire l’ingresso della Nazione fascista fra i Grandi della Terra. Così Mussolini aveva sospinto i concittadini, ancora inneggianti a lui, in una guerra alla quale eravamo del tutto impreparati. Con spicciola ferocia aveva detto che gli servivano un migliaio di morti per sedere al tavolo della pace. E’ stata la frase più abietta del Ventesimo Secolo, quella che nemmeno i campioni riconosciuti del male (Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot) ebbero mai lo stomaco di pronunciare. Purtroppo l’hanno scontata sulla propria pelle i ragazzi della generazione sfortunata, nati fra il 1909 e il 1922, chiamati a combattere una guerra per la quale non erano preparati. E il Paese lo era ancora meno dopo quattro anni di logoranti impegni bellici: dall’invasione dell’Etiopia al conflitto civile in Spagna. Con la presunzione degli stupidi Mussolini il 10 giugno del ’40 aveva predisposto il suo bluff sanguinario: era convinto che in autunno Inghilterra e Francia avrebbero accettato sia l’armistizio, sia il nuovo ordine dell’Europa sotto il tallone di Hitler con lui a far da paggetto ossequioso. Invece Churchill s’era incaponito e al popolo italiano toccò pagare il prezzo più amaro. Dopo i troppi anni trascorsi a battagliare per la conquista dell’Etiopia e per sostenere il golpe di Franco in Spagna, il nostro esercito nella tarda primavera del ’40 non ha riserve di alcun genere. E anche di quattrini a disposizione ce ne stanno pochi dopo i 50 miliardi di lire (circa 45 miliardi di euro) spesi fra il ’35 e il ’39 nelle due dissennate campagne. I generali sanno che fanteria e aviazione sono in fase di riorganizzazione, ma nessuno ha il fegato di gridarlo a voce alta, di conseguenza il duce può fingere di esserne all’oscuro. D’intatto resta la marina, tuttavia la gran parte degli ammiragli nutre sentimenti filo inglesi, spesso cementati dall’appartenenza alle logge massoniche d’obbedienza scozzese; nei confronti del tedesco provano un’avversione sincera, d’altronde molti hanno cominciato la carriera durante la prima guerra mondiale allorché il nemico erano l’Austria e la Germania. Dover affrontare l’Impero britannico per un verso atterrisce, domina pur sempre i mari da tre secoli, per l’altro verso viene considerato una sorta di tradimento nei confronti di un Paese amico fin dall’epopea risorgimentale. All’annuncio del conflitto le quotazioni di Mussolini, già assai in ribasso fra gli alti gradi del quartier generale di Santa Rosa, sulla via Cassia, per non averli dotati di portaerei, s’inabissano del tutto. Ma anziché tentare il rischio di un colpo di stato, gli ammiragli preferiscono mantenere i privilegi del ruolo e il piede su due tolde. Proprio l’insicurezza delle rotte verso Tripoli, Bengasi, Tobruk, dovute spesso alle soffiate che filtrano da Supermarina, costituirà uno dei motivi dello sfacelo in Africa. Il problema dei rifornimenti per le due armate in Libia e per quella in Etiopia si pone fin dall’inizio della guerra, tuttavia rimane irrisolto. La fulminea resa della Francia sposta per noi il fronte vero in Africa Settentrionale. Purtroppo non viene sfruttata la schiacciante superiorità numerica: alla 10a armata del generale Berti schierata al confine tra la Libia e l’Egitto si aggiunge la 5a di Gariboldi attestata in origine al confine con la Tunisia, colonia di Parigi. L’esercito britannico in Egitto - 40 mila inglesi, 8500 neozelandesi e rhodesiani, 15 mila indiani poco affidabili e 40 mila egiziani con il dente avvelenato nei confronti di Londra - pare destinato alla disfatta contro i 230 mila di Balbo. Non solo abbiamo il doppio degli uomini, ma vantiamo anche più cannoni (1800 contro 136) e persino, sulla carta, un numero superiore di aerei. Ecco spiegata l’insistenza con cui Mussolini pretende di affrontare il nemico, condotto da uno dei migliori generali dell’Impero, il conte Archibald Wavell. Balbo, governatore della Libia e comandante in capo, è conscio che a quelle latitudini non si può avanzare a piedi. Invano chiede autocarri: al posto dei 7 mila necessari, da Roma gli propongono di impiegare gli asinelli locali, la qualcosa significherebbe doversi anche occupare del loro sostentamento. Da Mussolini a Badoglio e giù per la catena di comando sono ancora convinti che in Africa ci sarà da combattere la vecchia guerra coloniale con tanto di quadrupedi e di spostamenti a piedi. Scopriremo a caro prezzo di dover affrontare una guerra meccanizzata, né più né meno come nel Vecchio Continente. Servono motori potenti per far avanzare i blindati, servono motori affidabili per consentire agli autocarri dei rifornimenti di assorbire i granelli di sabbia e i bruschi sbalzi termici (di giorno sopra i 50º gradi all’ombra, di notte un pelo sopra lo 0º). Il brillante suggerimento di ricorrere agli asinelli viene accantonato, mentre non sono accantonati gl’incitamenti di Mussolini a superare il maledetto ciglione di Sollum e a piantare il tricolore su un po’ di sassi di Giorgio VI. Al contrario, Balbo indugia impensierito dalle incursioni contro gl’isolati presidi italiani. Pur non avendo una grande esperienza di tattiche e strategie, non si fida delle apparenze e delle smargiassate. Deve la carriera all’aver formato le prime squadracce fasciste in Romagna e la fama alla doppia trasvolata dell’Atlantico. L’incarico in Libia è stato un espediente per allontanarlo da Roma, dove il suo successo internazionale procurava continui travasi di bile sia a Mussolini sia al clan Ciano. Di fronte al passo più importante, Balbo cerca nella prudenza l’antidoto alle deficienze dei propri reparti. A sparigliare le carte interviene il caso. Il trimotore S79 del governatore in atterraggio su Tobruk è scambiato per un apparecchio nemico e abbattuto dall’artiglieria dell’incrociatore San Giorgio. Al posto di Balbo viene nominato il maresciallo Rodolfo Graziani, costretto ad abbandonare l’Italia, ma non il cadreghino di capo di stato maggiore dell’esercito, dal quale continua la sua contrapposizione ventennale con Badoglio, capo di stato maggiore generale. Al pari del suo rivale, pure Graziani rappresenta uno dei falsi miti del fascismo. Nella Wermacht faticherebbero entrambi a comandare un battaglione; nell’impero di stracci di Vittorio Emanuele III hanno la responsabilità dell’intero apparato bellico. Graziani passa per un coraggioso, ma è stato infiacchito dall’attentato di Adis Abeba, nel quale ha rischiato di morire e per il quale ha scatenato una rappresaglia selvaggia. Del fegataccio sanguinario è sparito il sostantivo ed è avanzato l’aggettivo. Mussolini lo obbliga a muoversi con una serie di diktat. Wavell gli fa ala fino a Sid el Barrani, la cui conquista viene salutata da un bollettino di rara e ingiustificata presunzione: < Contemporaneamente in Etiopia si è mosso l’esercito del Vicerè Amedeo d’Aosta. Sulla carta risulta impressionante: 260 mila uomini, purtroppo i tre quarti sono indigeni attratti dal soldo e spesso dotati dell’antiquato fucile Vetter Vitali originariamente a un solo colpo, poi alimentato con pacchetti di quattro. Artiglieria e aviazione denunciano lo stesso livello d’inadeguatezza, i mezzi di trasporto sono inesistenti. La brillantezza degli ufficiali ha prodotto efficaci incursioni in Kenia, in Sudan, nella Somalia britannica sotto l’occhio disincantato di Churchill: dal numero 10 di Downing Street ha ordinato ai suoi 15 mila soldati di non ingaggiare battaglia e di affidarsi alle dimensioni sconfinate del territorio per mettersi in sicurezza. Neppure la conquista di Berbera, con la fuga via mare dei suoi difensori, vale a cambiare il quadro sostanziale. Riorganizzate le divisioni, i generali britannici potranno sfruttare le tante superiorità: armamento, rifornimenti, motivazioni, addestramento, logistica. Il primo ad accorgersene è Graziani. Choccato dalle batoste in Grecia, l’incazzoso Mussolini esige una rivalsa in Egitto. Ma a quel settore guarda pure Churchill per rivitalizzare il fronte interno molto scosso dalla battaglia aerea con cui la Raf prova nei cieli inglesi a scongiurare l’imminente invasione. Malgrado l’emergenza del momento, sono fornite a Wavell due divisioni australiane di stanza in Palestina. Si aggiungono alle tre divisioni miste, di cui una corazzata, ai 400 aerei, ai 50 carri armati pesanti da 30 tonnellate, ai 176 medi da 15, ai 200 carri leggeri e autoblindo. E’ sbocciata l’8a armata destinata a entrare nella storia del conflitto: per ora si chiama Western Desert Force, la guida il generale Richard O’ Connor. Purtroppo per noi ha già dimostrato di avere le idee chiare e d’intendersene. All’alba del 9 dicembre la 7a divisione corazzata (generale Creagh) e la 4a indiana (generale Beresford-Peirse) travolgono le linee italiane al di là delle speranze di Wavell e di Churchill. Ripresa Sidi el Barrani, incomincia una marcia trionfale sulla Balbia: cadono Bardia, Tobruk, Derna, Barce, Bengasi. Bastano poco più di 30 mila uomini, i famosi «topi del deserto» di O’ Connor, per sbaragliare i 145 mila di Berti. Il mondo assiste sbigottito. E’ la vittoria della preparazione e dell’esperienza contro la prosopopea e la mediocrità. Gli M11, tragiche scatole di sardine da 10 tonnellate protette da un velo di blindatura sono stati spazzati via. Non parliamo poi dei giocattolini tipo gli L 3, cioè blindati da 3 tonnellate, spesso armati soltanto di mitragliatrice. E la responsabilità di tale insufficienza va addebitata alla miopia di Mussolini e degli stati maggiori, fermi alla guerra statica delle trincee, incapaci di comprendere l’importanza della guerra di movimento affidata ai carri armati. E dire che un prototipo dei nostri mezzi corazzati, il Fiat 2000 ideato nel 1917, pesava 40 tonnellate, era armato con un obice da 65 e con sei mitragliatrici, aveva dieci uomini d’equipaggio. Quando a gennaio 1941 si presenta l’M13, con il suo cannone da 47 può battersela con i Crusader e i Valentine, per altro più pesanti, ma niente può contro il Matilda, l’MK II da 27 tonnellate, 80 centimetri di blindatura e un cannone da 40/67. Da vecchio artigliere Badoglio è convinto che la diffusione dei pezzi anticarro abbia reso obsoleto il carro armato. Nella primavera del 1940, alla chiusura del corso presso la scuola di guerra di Torino, si è vantato di aver fatto risparmiare allo Stato investimenti tanto cospicui quanto inutili opponendosi alla costruzione di carri di stazza superiore alle 20 tonnellate. Benché la guerra di Spagna abbia già dimostrato che a sbaragliare un’intera brigata di carri L basti un carro medio russo armato di cannone, l’uso dei blindati risulta indigesto al nostro stato maggiore. E’ un’impreparazione tecnica, cui se ne aggiunge una strategica: purtroppo per i tantissimi che dentro quelle bare andranno a morire, abbiamo comandanti formatisi nelle trincee della prima guerra mondiale e lì fermatisi. Le nostre accademie, dunque, prevedono un impiego frammentario dei reggimenti e dei battaglioni carri al seguito delle divisioni di fanteria, privi di qualsiasi autonomia tattica oltre che di un comando unificato. Ancor più inadeguato dei carri armati e dei cannoni si dimostra Graziani, ma non si tratta di una novità. Rintanato a Cirene, a 500 chilometri dal fronte, chiede a Mussolini il permesso di retrocedere fino a Tripoli per < Il 9 febbraio 1941 le avanguardie di Wavell toccano El Agheila, all’imbocco del golfo della Sirte. La 10a armata non esiste più: 5 mila morti, 130 mila prigionieri, 400 carri armati e 1200 cannoni catturati dal nemico. La scampano soltanto 7 mila soldati italiani e 1300 libici con 460 armi automatiche, 60 mortai, 13 mitragliatrici pesanti, 110 cannoni di piccolo calibro. Le perdite della Western Desert Force sono assai contenute: 500 morti, 1373 feriti, 58 dispersi. Eppure O’ Connor rimprovera a Wavell di aver fermato la travolgente cavalcata. Ai suoi occhi la fatica accumulata dai reparti in due mesi di avanzata è ampiamente compensata dalla scadente qualità del nemico. Graziani viene sostituito da Gariboldi e raggiunge nella pensione il rivale di sempre, Badoglio, che a causa della disfatta greca è stato sostituito da Cavallero. Il tracollo in Africa settentrionale evidenzia la scarsa qualità dell’aeronautica - non basta l’abnegazione dei piloti per supplire alle deficienze di velocità, di armamento, di maneggevolezza - e il modesto contributo della marina. Per quanto le coste italiane siano dirimpettaie di quelle libiche, risulta molto più facile a Churchill che a Mussolini rifornire il proprio esercito. Dopo la resa francese, l’Italia possiede la quarta flotta del mondo - alle spalle di Usa, Gran Bretagna, Giappone - e la prima del Mediterraneo. Schiera le due più imponenti navi da battaglia, la Littorio e la Vittorio Veneto, corazzate da oltre 40 mila tonnellate, trenta nodi di velocità e un armamento sontuoso in cui spiccano nove cannoni da 381 millimetri. E anche il contorno è di prim’ordine: 4 corazzate da 29 mila tonnellate e pezzi da 320 millimetri (Giulio Cesare, Cavour, Caio Duilio, Andrea Doria), 7 incrociatori pesanti da 10 mila tonnellate con cannoni da 203 millimetri, 12 incrociatori leggeri, 59 cacciatorpediniere, 70 torpediniere, 50 MAS (mezzi d’assalto subacquei e sopracquei: recita così la definizione per intero). Infine, il gioiello della corona: 115 sommergibili. Soltanto l’Urss ne possiede un numero maggiore, ma con uno spazio quadruplo da vigilare. Al di là della mancanza di portaerei e aerosiluranti, il difetto principale risiede nella scarsa affidabilità delle artiglierie, cui il capo di stato maggiore, Cavagnari, mai si è dedicato. Anzi, l’ha presentata quale ottima scusa per dissuadere Mussolini da colpi di testa. Al duce, invece, scappava dalla pelle di mandare al più presto la meglio gioventù a crepare per la propria gloria. Di conseguenza sarebbe stato opportuno studiare i campi di operazione, redigere piani, tenerli aggiornati. Fin dal 1938 appariva chiaro che l’Africa, soprattutto quella Orientale, avrebbe rappresentato uno scacchiere delicato con linee di collegamento assai precarie. Eppure erano molto più preoccupati all’ammiragliato di Londra che a Santa Rosa. Ancora nel maggio del ’40 ragionavano di ritirare la squadra navale da Alessandria a Gibilterra. Una tal scelta avrebbe comportato allungare a dismisura il rifornimento dell’esercito in Egitto e in Medio Oriente: dalla Manica fino al Capo di Buona Speranza, passando poi per la strettoia del Mar Rosso. Ma qui poteva scattare la trappola per topi: a Massua infatti stavano gli italiani. E nonostante Cavagnari si fosse guardato bene dall’infoltire la squadra, i 7 cacciatorpediniere, i 5 Mas, gli 8 sommergibili e le 23 squadriglie di bombardieri davano molto da pensare all’ammiraglio Pound, primo lord del mare. Immaginiamoci quali incubi avrebbe avuto la notte se appena appena Cavagnari avesse trasferito qualche posamine. Purtroppo a nessuno dei nostri intelligentoni con le stellette venne in mente di riempire di mine quella rotta comunque obbligata. Sette giorni dopo la dichiarazione di guerra, il 17 giugno, l’ammiraglio Cunningham, comandante di Alessandria, riceve una lettera da Pound. Gli comunica di prepararsi a sloggiare: a lui la scelta di quali navi avrebbero puntato direttamente su Gibilterra e di quali avrebbero circumnavigato l’Africa. La risposta di Cunningham gronda pessimismo e malumore. Si rende costo della ineluttabilità della decisione, però comporterà la perdita di Malta, di Cipro, della Palestina con il variegato pianeta musulmano pronto a esplodere. Sembra l’annuncio della disfatta. Viceversa il giorno seguente Cunningham trasmette un cifrato con il quale invita il governo a soprassedere: gli risulta che la flotta italiana non abbia alcuna voglia di combattere; inoltre ritiene di sapere dove siano posizionati i nostri 55 sommergibili nel Mediterraneo. Che strano: Cunningham conosce a puntino il numero degli scafi lanciati dall’ammiraglio Mario Farangola ad azzannare la perfida Albione. Eppure fino alla vigilia del conflitto i sottomarini da mandare in caccia erano 63, sono stati diminuiti la sera del 10 giugno. Cunningham come fa a esserne informato e soprattutto come fa a essere informato della loro dislocazione? A differenza della tattica adoperata dall’ammiraglio Doenitz con gli U-Boot tedeschi, a «branco di lupi», cioè concentrati in una zona dell’Atlantico per colpire il maggior numero possibile di battelli, Farangola usa i sottomarini quali "boe siluranti": l’uno distante dall’altro, immobile nel proprio quadratino con il compito di attaccare il naviglio e di sorvegliare il traffico. Il Mediterraneo risulta diviso in tre fasce: nella A ne sono stati posizionati 15, nella B 17, nella C, fra Pantelleria e l’Africa, 23. Il 27 giugno Cunningham lancia cinque cacciatorpediniere contro i sommergibili della fascia C. In teoria sono 23 punticini sparsi in mille miglia di mare, nella realtà la squadriglia britannica procede a colpo sicuro: in quarantott’ore ne affonda 4 e danneggia 3. Negli stessi giorni vengono spazzati via gli 8 sommergibili di Massaua, costretti anche a fare i conti con un nemico in più, il cloruro di metile, utilizzato quale refrigeratore. Nessuno si era accorto della sua tossicità e che bastava una minima fuga per avvelenare l’equipaggio. I marinai lo scoprono sulla propria pelle, mentre tentano di sottrarsi ai quattro cacciatorpediniere spediti da Cunningham ad Aden per sbarazzarsi della loro fastidiosa presenza. E anche in questo caso la precisione con cui sono localizzati fa dubitare che abbiamo influito soltanto fortuna e abilità. D’altronde Cunningham viene graziato persino nei suoi eccessi di sicurezza. Succede a Punta Stilo, il 9 luglio, allorché Supermarina ordina alla squadra dell’ammiraglio Campioni, in soverchiante superiorità numerica e di stazza, di ritirarsi dopo pochi minuti di cannoneggiamento. Così è persa la grande, irripetibile occasione d’infliggere alla Gran Bretagna una roboante sconfitta, dagli enormi riflessi anche psicologici, e di cancellarne per molto tempo la presenza nel Mediterraneo. Succede esattamente il contrario. Malgrado le mille difficoltà in Europa, malgrado i massicci preparativi di Hitler per sbarcare a Dover, Churchill comprende di poter vincere la partita in Africa, di poter mantenere Malta e di poter salvare i preziosissimi campi petroliferi in Iran e in Iraq. In un mese gl’inglesi sono passati dal più cupo pessimismo a un fondato ottimismo, al quale fa da contrappunto la crescente prudenza italiana. Su di essa influisce pure una certa furbizia tipicamente italiana, che altri, non a torto, definiscono codardia. Nonostante le rodomontate di Mussolini, l’idea di Cavagnari e dei principali collaboratori è tanto semplice quanto chiara: con il Terzo Reich a un passo dalla vittoria non merita di rischiare né un legno né un marinaio. Cavagnari addirittura stabilisce che, presupponendo la conquista di Malta un alto tributo di sangue - false notizie diffuse dal Servizio informazioni militare (Sim) del generale Giacomo Carboni parlano di 336 cannoni navali, di 200 pezzi contraerei, di 100 carri armati e di 10 mila uomini presenti nell’isola -, sarà sufficiente tenerla sotto pressione con bombardamenti aerei, agguati di sommergibili, incursioni notturne di Mas. Peccato che il progetto rimanga sulla carta. Da metà luglio del ’40 viene convenuto che la flotta italiana non scorterà più al gran completo i convogli di rifornimento diretti in Libia, malgrado i mercantili disponibili siano molto lenti. I più veloci li abbiamo persi a causa del ritardato avviso di rientro: è stato diramato soltanto il 5 giugno e 212 navi, le migliori, quelle di stazza maggiore e con più nodi in pancia, non sono riuscite a rientrare. Una, il Rodi, viene addirittura bloccata a Malta. Cavagnari giustifica la scelta di non fare uscire le squadre con le scarse riserve di carburante. Una colossale bugia: i dati ufficiali del ministero spiegano che abbiamo la stessa dotazione di Germania e di Gran Bretagna, anzi dal giugno ’41 i tedeschi ci forniranno ulteriori 45 mila tonnellate al mese. I piroscafi sono dunque costretti ad affrontare in solitudine o con la ridotta protezione di qualche cacciatorpediniere quello che non è più il mare nostrum. La salvezza dipenderà dal materiale trasportato e dal periodo: quando avranno a bordo benzina e carri armati, quando i rifornimenti risulterebbero vitali per l’armata italo-tedesca in Africa, quasi mai giungeranno a destinazione. Una coincidenza sconcertante giustificata nel dopoguerra con l’impiego da parte avversaria del radar e di Ultra, la macchina in grado di decrittare i messaggi cifrati germanici. Ma Carlo De Risio e Roberto Fabiani hanno dimostrato nello strepitoso saggio La flotta tradita che Ultra e il radar ebbero scarsa incidenza nei disastri delle nostre navi. Convogli e sommergibili pagarono, invece, il costante flusso d’informazioni riservate che da Supermarina raggiungeva con puntualità le orecchie del nemico. Lo ha chiaramente scritto il generale Cesare Amè, successore dal settembre ’40 di Carboni al Sim. Non a caso il suo impressionante memoriale costituisce la base del pamphlet di Fabiani e De Risio. Alla fine del 1940, dopo la tremenda incursione degli aerosiluranti di Cunningham nel porto di Taranto, le perdite suonano già impressionanti: una corazzata, un incrociatore, 8 cacciatorpediniere, 6 torpediniere, una cannoniera, 20 sommergibili, 50 mila tonnellate di mercantili. All’incasso un vecchio incrociatore, 3 cacciatorpediniere (2 saltati sulle mine), 9 sommergibili, 5 piroscafi. Da questi numeri discende l’abbandono dell’armata in Africa Orientale nel momento di maggior bisogno. A metà gennaio ’41, sotto l’infuriare della Raf, scatta dal Sudan e dal Kenia la duplice offensiva inglese. In quattro mesi i corpi d’armata di Frusci e De Simone, falcidiati dalle defezioni delle truppe indigene, sono disfatti. A nulla valgono gli eroismi del capitano Vicentini, che ai comandi di un vecchio Cr 42 s’alza in volo a contrastare da solo le soverchianti squadriglie inglesi; del tenente colonnello Guillet, che effettua la penultima carica di cavalleria della guerra (l’altra l’avrebbe effettuato il Savoia l’anno seguente in Russia); del generale Carmineo nella difesa di Cheren. Caduta il 6 aprile anche Adis Abeba, il duca d’Aosta si rinserra con 7 mila irriducibili, la metà dei quali ascari, sull’Amba Alagi. La sconsiderata avventura etiopica finisce lì dove non era cominciata a causa dell’agguato in cui nel 1895 era caduta la colonna Toselli. Il 17 maggio 1941 viene alzato il vessillo bianco. L’aitante duca, che in Italia ha lasciato schiere di cuori femminili infranti, morirà di tubercolosi a Nairobi il 3 marzo ’42. I rovesci africani inducono Hitler a intervenire: il 21 gennaio è caduta Tobruk dopo che gli australiani della 6a divisione (generale Mackay) hanno creato nella cinta fortificata le brecce attraverso le quali sono transitati i carri armati. Mussolini e lo Stato maggiore non hanno più argomenti per respingere l’offerta d’aiuto. La vecchia scusa - il deserto non si addice ai nipotini dei nibelunghi - è stata abbattuta dalle imprese dei «topi del deserto». L’Oberkommando di Berlino riserva all’operazione Girasole la 5a divisione leggera - per modo di dire: annovera un reggimento carri, 2 mila veicoli, 111 pezzi anticarro, 30 carri armati medi - e la 15ma corazzata con 200 panzer, disponibile però da maggio. Lo sbarco viene protetto dal Decimo corpo aereo installatosi in Sicilia nel dicembre ’40 per mettere sotto pressione Malta. Entrano in azione decine e decine di Stuka, lo Junker Ju 87, il famoso bombardiere in picchiata con ala a gabbiano rovesciato e la sirena (’tromba di Gerico’) nel carrello d’atterraggio: a causa del vento produce un sibilo acutissimo dagli effetti psicologici devastanti in quanti sono già atterriti dal vedersi piombare addosso il bestione. I marinai e le imbarcazioni di Cunningham vengono stravolti dalla novità. Abituati agli aerei italiani che sganciano da circa 3 mila metri, faticano a fronteggiare gli acrobati della Luftwaffe. Comandante dell’Afrika Korps, così viene denominato il corpo di spedizione germanico, è designato una nostra vecchia conoscenza, il generale Erwin Rommel. Da capitano era stato nel 1917 il protagonista dello sfondamento di Caporetto: alla testa di un battaglione di cacciatori da montagna aveva assaltato il monte Matajur e imprigionato 150 ufficiali e 9 mila soldati con il corredo di 80 cannoni. Da quell’episodio la carriera del piccolo ufficiale, freddo, autoritario, inviso agli altezzosi aristocratici prussiani, ha progredito anno dopo anno. Oltre alle qualità da stratega, le fortune di Rommel sono state accresciute dall’avversione degli junker. Agli occhi di Hitler si è trasformata in un attestato di affidabilità. Lo ha nominato responsabile della guardia personale e in seguito comandante della 7a Panzer, riempitasi di gloria nella vertiginosa campagna di Francia. Il suo credo è abbastanza semplice: se una mossa è rischiosa, significa che nasconde un’opportunità. Rommel aspira a mantenere in continuazione l’iniziativa: ogni sua azione è improntata all’attacco, alla sorpresa, alla continua ricerca della manovra giusta per circondare il nemico e finirlo. Le uniche tenerezze che gli si conoscono le riserva alla moglie e all’unico figlio. Il comando in Africa giunge a proposito per sfruttare in quelle distese infinite la decantata superiorità dei blindati germanici. A Berlino come a Roma immaginano di poter utilizzare al meglio le capacità offensive di Rommel, nessuno purtroppo ha messo in preventivo che il profeta della guerra-lampo ignora che cosa sia la difesa. Da subito Rommel deve misurarsi con l’invidia dei parigrado italiani, che attribuiscono alla fortuna metà dei suoi successi, e con le mille deficienze della nostra logistica. Della prima se ne fa beffe: formalmente l’ultima parola spetterebbe a Gariboldi e risalendo per li rami a Cavallero e Mussolini; nella pratica la tiene sempre per sé sapendo di godere della protezione del fuhrer. Tra l’altro conquista all’istante il favore dei sottoposto dividendo con essi i disagi e i pericoli della prima linea. A differenza dei colleghi italiani rintanati a centinaia di chilometri, Rommel spesso sopravanza, con la cicogna da ricognizione, perfino le avanguardie. Molto più complicato risulta per lui venire a capo del secondo ostacolo: la cronica deficienza dei nostri trasporti, alla quale si aggiunge, allorché i convogli giungono a destinazione, la limitata capienza recettiva di Tripoli e degli altri porti. Rommel, allora, propone d’invadere la Tunisia per dare un altro sbocco ai rifornimenti, ma Hitler non vuole complicare i rapporti con la Francia di Vichy. L’uomo che da trent’anni vive di armi e strategia è sinceramente strabiliato quando passa in rassegna il nostro equipaggiamento. Nel diario scrive: «L’antiareea è costituita da vecchissimi Skoda da 75 mm, ancora della guerra 1914-18; ho visto perfino mortai di bronzo antiquati, già dell’esercito austro-ungarico... Gli aerei sono logori e non vengono cambiati. I piloti italiani fanno miracoli. Gli apparecchi da ricognizione, mi dice Zecht, sono vecchi Caproni, inermi e lenti, micidiali per chi vola...Gli aerosiluranti sono empirici e rudimentali: l’unica cosa viva è il valore e il coraggio dei piloti; un nostro aviatore rifiuterebbe di decollare con quegli apparecchi che qui chiamano a ragione ’Totebahren’ (’Casse da Morto’)». Ma gli sconcerti non sono terminati: «I fucili italiani si chiamano modello 91, perché rimontano all’anno 1891; gli italiani non posseggono mitra, i carri armati da 6 tonnellate sono ridicoli. L’evacuazione della popolazione colonica italiana dalla Cirenaica è stato un errore. Ha ingorgato la Tripolitania, ha dato agli arabi il possesso della terra e dei poderi bellissimi, che lasceranno poi di mala voglia: di conseguenza rimarranno ostili all’Asse. Ritengo che Balbo non lo avrebbe permesso: egli non avrebbe fatto l’errore di Graziani di attaccare a fondo senza riserve, senza rifornimenti e, soprattutto, senza aerei sufficienti. Wawell lo ha battuto per l’aviazione». Non tutte le critiche di Rommel sono pertinenti - gran parte dei cannoni da 75, costruiti a Napoli su licenza dell’Ansaldo, funzionano bene; il mitra Mab 38 è una bell’arma; il 91 non è molto più anziano del Mauser 96 o dello stesso Lee Enfield - ma coglie nel segno allorché si rifà a una visione assai miope e soprattutto alla mancanza di coordinamento. Il vanto del 91 è l’estrema precisione, tuttavia è poco maneggevole, è lento, ha un potere d’arresto molto limitato. Ma il vero, grande problema, che peserà per l’intera durata del conflitto, risultano i calibri diversificati tra mitragliatrici e moschetti: le mitragliatrici Breda sono 8,8 , le Lewis aereonautiche sono 7,7, i mitragliatori Breda usano le munizioni del 91, però s’inceppano; sono inoltre diffuse mitragliatrici austriache, preda bellica del ’15-’18. Un vero manicomio per la logistica, un dramma per soldati impotenti davanti a munizioni e armi spesso non compatibili fra essi. Che differenza con gli altri: i tedeschi usano solo il 7.92 su Mauser, MG 34 e MG 42; gli inglesi il 7.7 per Lee Enfield, Bren e le Lewis; gli statunitensi, quando arriveranno dopo El Alamein, avranno fucili Garand semiautomatici, mitragliatori Bar e mitragliatrici leggere Browning tutti in calibro 7.62. Il 24 marzo 1941, dalla puntata esplorativa su El Agheila di un reparto misto, Rommel intuisce che le formazioni di Wavell peccano nei collegamenti interni. I comandi britannici si sentono al sicuro avendo appena debellato l’ultima resistenza in Cirenaica, il ridotto di Giarabub, sacro ai senussi per accogliere dentro la piccola moschea la tomba del fondatore della setta, Mohammed ben Alì es Senussi. Per mesi i 1300 uomini del maggiore Castagna hanno respinto diversi assalti pur essendo insaccati nel cuore dello schieramento avversario. In onore di Castagna e dei suoi ardimentosi la propaganda fascista ha composto una canzone, La sagra di Giarabub, con il famoso ritornello: Colonnello non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto. Purtroppo i soldati dell’oasi hanno ricevuto minime quantità dell’uno e dell’altro. Wavell, perciò, opina di avere tempo da dedicare all’altro scacchiere di sua competenza, la Grecia, dove la Wermacht è intervenuta per togliere nuovamente dagli impicci lo scomodo alleato italiano. La stessa intelligence ha garantito a Wavell che prima di metà aprile Rommel non sarà pronto a muoversi. Al contrario la futura volpe del deserto si butta a capofitto in avanti. Il fronte britannico si sbriciola in poche ore. Il 4 aprile è occupata Bengasi (è stato un insegnante torinese delle scuole cristiane, Achille Rambaldi, ad avvertire Rommel che gli inglesi avevano sgombrato), il 5 Barce. Nella stessa notte una pattuglia tedesca ingabbia i generali O’Connor e Neame, che hanno smarrito la strada per il fronte. O’Connor stava in licenza, è stato richiamato nella speranza di arginare l’onda germanica. La sua cattura simboleggia la frana della Western Desert Force. Il 7 aprile 300 bersaglieri del colonnello Montemurro espugnano el Mechili e fanno 1700 prigionieri, fra i quali alcuni generali. Le avanguardie dei granatieri si spingono fino al ciglione di Sollum, benché Tobruk, tenuta dalla 9a divisione australiana, risulti imprendibile. Churchill sollecita Wavell ad assumere l’iniziativa, gli fa giungere i nuovi carri Mark II, la Matilda nel gergo dei soldati, ma gli 88 germanici, nati in funzione antiaerea, ne distruggono a bizzeffe. L’Afrika Korps oramai s’affaccia sul suolo egiziano. Assieme alle due divisioni tedesche si è ben comportata l’Ariete del generale Ettore Baldassare, sulla carta una delle nostre poche divisioni motocorazzate, ma il cui armamento risulta risibile nel confronto con i camerati. Per la sua estrema mobilità assume il nome di ’divisione fantasma’. E’ in questi mesi che Rommel matura l’aspro giudizio sugli italiani («i soldati sono leoni, gli ufficiali salsicce, lo stato maggiore letame»). Però d’incomprensioni ne ha anche con i suoi: gl’imputano la mancata riconquista di Tobruk, mentre Churchill addebita a Wavell di aver fatto entrare il nemico in casa e lo sostituisce con sir Claude John Eyre Auchinleck, tipico prodotto delle accademie britanniche, già costretto l’anno prima ad abbandonare la Norvegia con il corpo di spedizione inglese. Il 21 giugno l’Operazione Barbarossa, cioè l’invasione dell’Unione Sovietica da parte del più imponente esercito mai allestito (3 milioni e 50 mila uomini), relega in secondo piano gli altri settori. Hitler ha fretta di recuperare i due mesi perduti per disbrigare la pratica greca. Un paio di divisioni destinate a Rommel sono deviate in Ucraina, dalla Sicilia viene trasferito anche il Decimo corpo aereo. E Mussolini, manco a dirlo, commette un altro clamoroso errore. Abbagliato dalla straordinaria progressione delle settimane iniziali, domanda con insistenza al fuhrer di condividere un po’ di gloria in Urss. La risposta è glaciale, ma esemplare: Hitler spiega di non aver bisogno di alcun sostegno, anzi invita il caro duce a occuparsi di una questione che forse sottovaluta: «L’aiuto decisivo lo potrete fornire nel rafforzare le vostre forze nell’Africa Settentrionale, nell’intensificare la guerra aerea e, dove sia possibile, quella dei sommergibili nel Mediterraneo.» L’attenzione di Hitler è costantemente rivolta ai pozzi petroliferi controllati dagli inglesi. Nei suoi intendimenti l’invasione dell’Unione Sovietica deve portare all’occupazione dell’Iran e dell’Iraq per tagliare in maniera definitiva gli approvvigionamenti di carburante a quel testone di Churchill e impedirgli di ricevere i rifornimenti spediti da Roosevelt nel Golfo Persico. Nella tenaglia immaginata da Hitler per soffocare il leone britannico il secondo braccio è costituito dall’Africa Korps: a esso spetterà l’occupazione dell’Egitto, della Palestina, della Giordania. Ma tali raccomandazioni risultano del tutto incomprensibili a Mussolini. Il suo assillo consiste nel tampinare le mosse del Terzo Reich per ritagliarsi un posto d’onore al tavolo della pace. Nel giugno del ’41 è probabilmente l’unico sul pianeta a ritenerla prossima, certo che le armate del compare assoggetteranno in pochi mesi l’orso comunista. Tanto insiste da ottenere d’inviare il Csir (Corpo di spedizione italiano in Russia): quattro divisioni con 61 mila soldati, 5500 automezzi, 148 pezzi d’artiglieria. Nella steppa risulteranno ininfluenti, in Africa settentrionale sposterebbero i rapporti di forze. Come li avrebbero spostati i corpi d’armata lanciati al buio verso la catastrofe greca. Ma per Mussolini l’Africa e il petrolio non contano, sennò si sarebbe curato già nel ’39 di ammassare truppe, di creare depositi lungo la costa libica per accorciare la catena dei rifornimenti, di ampliare al massimo i porti di Tripoli, di Bengasi, di Tobruk, di Badia, di Derna. Malauguratamente per i tanti mandati a morire dalla sua incompetenza, Mussolini non si accorge che diversi ammiragli fanno il doppio gioco. La marina, per la quale a metà degli Anni Trenta sono stati spesi 14 miliardi di lire (all’incirca 15 miliardi di euro), dovrebbe garantire il pieno possesso del Mediterraneo, viceversa lascia sempre più spazio agli azzardi di Cunningham. Scampato agli scontri di Punta Stilo e nel golfo della Sirte, che avrebbero potuto decimare la sua Mediterrean Fleet, questo degno erede di Nelson ha organizzato il devastante attacco (11 novembre ’40) al porto di Taranto - le nostre grandi corazzate si sono graziosamente offerte ai siluri degli Swordfish, aerei di legno e tela - e l’agguato di Capo Matapan (28-29 marzo ’41) con la perdita di tre incrociatori pesanti (Pola, Zara, Fiume), di due cacciatorpediniere (Alfieri e Carducci), di 3 mila marinai. In entrambe le occasioni hanno inciso i siluri, snobbati da Mussolini e da Cavagnari. A metà degli Anni Trenta, infatti, il generale Valle aveva messo a punto un siluro da sganciare sul bersaglio a 80 metri di altezza, una quota all’epoca notevolissima, che consentiva al pilota di rialzarsi in cielo, mentre gli altri, costretti a volare bassissimi, erano condannati a morte quasi sicura. Dopo la nostra rinuncia a proseguire nella produzione, Gran Bretagna, Svezia e Germania avevano cercato in ogni modo di carpirne i segreti. Con la stipula del patto d’acciaio fra Berlino e Roma, la Luftwaffe aveva ordinato 300 esemplari alla Whitehead di Fiume. Neppure tale commessa era bastata a ridestare l’interesse dei vertici militari, sui quali pesava la contrarietà dell’aeronautica a mettere gli aerosiluranti sotto il comando della marina. Per giustificare la disfatta di Capo Matapan, originata da un’incursione di aerosiluranti contro il Vittorio Veneto e il Pola e dalle conseguenti scelte dell’ammiraglio Angelo Jachino, è stata diffusa la voce che le navi inglesi abbiano potuto affondare quel bendiddio grazie al radar. Non è vero. A Capo Matapan il radar - nella primavera del ’41 uno strumento assai grezzo, capace di segnalare una presenza senza distinguerla - non ha inciso. In ogni caso anche per il radar avremmo dovuto recitare il mea culpa. Già nel 1931 Ugo Tiberio, ingegnere dell’Istituto Militare Superiore di Trasmissioni, aveva sperimentato il ’radiotelemetro’, il papà del radar. Procedendo nello scetticismo generale gli era stato assegnato un contributo di 20 mila lire: Tiberio aveva approntato un prototipo con portata utile tra i 7 e i 12 mila metri. Al tempo tedeschi e inglesi stavano indietro di parecchi chilometri. Purtroppo nessuno aveva dato credito all’invenzione di Tiberio. L’“EC3bis”, questo il nome, era stato mestamente riposto nello scantinato dell’Istituto Elettronico per le Comunicazioni all’Accademia navale di Livorno. Nella notte da tregenda di Capo Matapan gli ufficiali di Sua Maestà britannica se la sono cavata con i binocoli, con i telemetri, con l’attitudine a combattere anche senza luce, con l’orgoglio della tradizione. Noi italiani ci siamo prestati a essere massacrati. Jachino ha mandato l’intera squadra a soccorrere il Pola persuaso che al buio il nemico non avrebbe ingaggiato battaglia. L’ammiraglio Cattaneo ha tenuto i cacciatorpediniere di poppa agli incrociatori, anziché in posizione di scorta. I cannoni avevano le bocche otturate dai tappi metallici, secondo l’antiquato regolamento. A Mussolini, che ha appena sostituito Cavagnari con Riccardi, non è rimasto che imprecare. Neppure dopo l’infausto accadimento è stato sfiorato dal sospetto che forse dall’altra parte sono regolarmente informati sulle rotte dei convogli tanto è vero che taluni comandanti usano la precauzione di non rivelarle e casualmente non incontrano siluri e granate durante la navigazione. Il più grande successo italiano, l’incursione dei "maiali" di De La Penne nel porto di Alessandria (18 dicembre ’41), avrà come premessa l’assoluta segretezza con la quale il principe Junio Valerio Borghese, comandante del sommergibile Scirè, trasporterà i tre “siluri a lenta corsa” e gli eroici sommozzatori. Nell’estate del ’41 l’Afrika Korps riceve gli approvvigionamenti con il contagocce. Tra aprile e agosto sono distrutti diversi cacciatorpediniere di scorta e circa venti piroscafi, tra cui due transatlantici, l’Esperia e il Conte Rosso, con a bordo quasi tremila volontari universitari, e un imponente piroscafo tedesco, il Preussen, stipato con 664 soldati, 6 mila tonnellate di munizioni, mille di carburante, mille di viveri, 320 blindati, cento granate da 1800 chili e alcune batterie di cannoni da 210 necessarie per sfondare la cinta difensiva di Tobruk. In tre occasioni le aggressioni ai convogli avvengono a poche miglia dai porti della Libia, cioè a casa nostra, dove la sorveglianza dovrebbe dissuadere navi e sottomarini britannici persino dall’affacciarsi. Viceversa, constatano che Supermarina non ha predisposto alcun tipo di sorveglianza. Per di più le nostre imbarcazioni hanno conservato l’abitudine dei tempi di pace di ricorrere nelle ore del buio alle segnalazioni luminose, grazioso regalo per i sottomarini, come è successo al Conte Rosso. A metà settembre Rommel ordina una puntata esplorativa verso il cuore dello schieramento rivale. I panzer avanzano per miglia e miglia senza incontrare segni di una presenza ostile. Del famoso deposito allestito da Auchinleck per la riconquista della Cirenaica non si scorge traccia. Rommel ne desume di avere ancora un buon vantaggio e di potersi dedicare all’attacco definitivo contro Tobruk. Bastico, sostituto di Gariboldi, appare dubbioso, ma gli difettano la personalità e la valentia per opporsi. Non è un gran militare, ha trascorsi abbastanza anonimi: le sue fortune si legano all’adesione al fascismo e alla protezione di Mussolini. Ha guidato il corpo di spedizione italiano nella guerra civile in Spagna, il suo vice è stato Gambara, grande amico di Ciano. Il premio per Bastico è stato il laticlavio di senatore del regno. In seguito, a sessantacinque anni suonati, Mussolini gli ha offerto questo po’ po’ di palcoscenico. La scelta di Gambara quale capo di stato maggiore, fa mormorare di mafia spagnola. La data prevista per l’attacco a Tobruk è il 20 novembre. Dieci giorni prima, però, l’imponente trasporto Duisburg viene macellato in circostanze misteriose nel Canale di Sicilia. Si tratta di quattro piroscafi, due italiani, due tedeschi, e di tre petroliere: a bordo 389 carri armati e mezzi motorizzati, 17.281 tonnellate di carburante, 1.579 di munizioni, 13.957 di materiali vari. Forse il rifornimento più massiccio fin lì effettuato: deve servire non soltanto per Tobruk, ma pure per il resto della campagna. La scorta è imponente: 2 incrociatori pesanti, Trento e Trieste, e 10 cacciatorpediniere al comando dell’ammiraglio Bruno Brivonesi. Un simile spiegamento è stato giustificato con la presenza a Malta della Forza K: a onta della pomposa etichetta, si tratta di due incrociatori leggeri e di due cacciatorpediniere. Allo scoppio del conflitto anche quest’isola era considerata indifendibile dal governo di Londra, tant’è vero che avevano evacuato gran parte del personale. A differenza delle false informazioni propalate da Carboni, l’armamento di Malta consisteva in 20 cannoni, in 24 pezzi contraerei e in 3 vetusti caccia tipo Gladiator, chiamati dai maltesi Fede, Speranza e Carità. Nelle previsioni altrui, l’ingresso in guerra dell’Italia avrebbe coinciso con la cancellazione dell’avamposto avversario. Ma Cavagnari non aveva preparato alcun piano d’invasione e Badoglio si era dimenticato di chiederglielo. A fine giugno ’40 il capitano di vascello Toyo Mitunobu, addetto navale giapponese, aveva osservato: «L’Italia doveva essere pronta a conquistare Malta e la Tunisia, che sono i punti chiave per il controllo del Mediterraneo. Giudicando dalla propaganda interna italiana, io pensavo che ciò sarebbe avvenuto subito dopo l’intervento. Ma l’11, 12, 13, 14 giugno le operazioni per la conquista di Malta e della Tunisia non erano ancora cominciate. Ciò era per me del tutto incomprensibile.» A comprenderlo in fretta erano stati Churchill e Cunningham, i quali avevano provveduto a rinsaldare Malta dotandola di navi, aerei, sommergibili: la Forza K, per l’appunto, assottigliatasi, però, nel tempo. Tuttavia, la sua semplice presenza, in quel novembre ’41, inquieta profondamente Cavallero e lo stato maggiore italiano. Ecco, dunque, spiegato l’impiego della possente squadra d’accompagnamento: guai se il trasporto Duisburg non raggiungesse Rommel. Malgrado la superiorità numerica e di armamento, il Trento e il Trieste posseggono cannoni da 203 contro i pezzi da 152 degl’inglesi, il convoglio di Brivonesi tenta di evitare ogni contatto. Zigzaga fino a notte fonda prima di virare verso sud, in direzione di Bengasi. Dalla rada della Valletta la Forza K, guidata dal capitano di vascello Agnew, esce all’imbrunire del 9 novembre sfuggendo alla sorveglianza dei cinque sommergibili piazzati da Farangola proprio per segnalarne i movimenti. Stranamente Agnew conosce l’esatta posizione degli italiani. Incurante della netta inferiorità scaglia le quattro imbarcazioni all’attacco. Il comportamento remissivo di Brivonesi, attento soprattutto a salvare la pelle, diventa la premessa del disastro. Vanno a picco 3 cacciatorpediniere, i 4 piroscafi, le 3 petroliere. Rommel se la dovrà cavare con il poco che ha in magazzino. Auchinleck si regola di conseguenza. Il 18 novembre dice a Cunningham, il vincitore del duca d’Aosta in Etiopia, di scattare in avanti. E’ l’operazione Crusader. Con l’arrivo del XXX corpo la Western Desert Force è divenuta l’8a armata. Conta sulla straripante prevalenza dei mezzi corazzati, 700 contro 250, con l’esordio dei nuovissimi Crusader muniti di cannone da 40 millimetri . A Bir el Gobi li bloccano le giovani camicie nere, i bersaglieri e i carristi dell’Ariete, comandati adesso dal generale Mario Balotta: vengono sacrificati parecchi M13, ma va peggio alla 22a brigata corazzata inglese, che fra distrutti e danneggiati ce ne rimette una sessantina. La fama dell’Ariete vola. Rommel teme di finire intrappolato fra le avanguardie nemiche e Tobruk: si sgancia al pelo e ne approfitta per sottrarre al generale Gambara il comando del corpo d’armata motorizzato. L’aeroporto di Sidi Rezegh diviene l’epicentro di fitti combattimenti. Cunningham s’impaurisce: la sua proposta di fortificarsi nelle posizioni raggiunte gli costa il posto. Auchinleck nomina il proprio vice, Ritchie e in pratica assume il comando dell’armata. I 75 mila dell’8a vengono rispediti all’assalto. L’Afrika Korps è obbligata a ritirarsi fino ad Agedabia. E qui avviene uno dei tanti episodi di ordinario eroismo, dai quali è costellata la nostra guerra da poveri. Il 14 dicembre ai 400 carabinieri paracadutisti del maggiore Edoardo Alessi viene ordinato di attestarsi a Eluet el Asel, un bivio pochi chilometri a sud di Berta, e resistervi a oltranza fino al passaggio di tutti i reparti italo-tedeschi. All’alba del 19 avviene il contatto con il nemico: una pattuglia esplorante britannica è inviata a saggiare la reazione dei difensori. Ne segue un violento bombardamento di artiglieria. Non è che l’inizio: rapidamente sopraggiungono i reparti corazzati contro i quali i carabinieri possono opporre soltanto 6 cannoni controcarro da 47/32, bombe a mano e tanto coraggio. Dopo una giornata di duri combattimenti, a sera giunge l’ordine di sganciarsi. Il grosso del battaglione si avvia verso Agedabia e si congiunge a una robusta colonna di veicoli bloccata dagli inglesi a Lamluda. Il maggiore Alessi riesce ad eliminare il caposaldo consentendo ai reparti di defluire. I tre plotoni (40 uomini guidati dai tenenti Mollo, Solito e Grippo) rimasti a Eluet el Asel per proteggere la ritirata dei commilitoni si battono per giorni. Sopravvivono soltanto 23 carabinieri. Unitisi ad altri soldati isolati durante i combattimenti si rifugeranno nei villaggi arabi lungo la via Balbia, dove svolgeranno funzioni informative e azioni di guerriglia oltre a proteggere i coloni italiani ormai in balia dei predoni arabi ed esposti alle violenze delle truppe britanniche. La lunga attesa durerà fino al 6 febbraio ’42 quando una efficace controffensiva dell’Afrika Korps riconquisterà l’area. A fine ’41 Tobruk viene liberata dall’assedio e Bengasi rioccupata dalle scatenate formazioni di Ritchie. Rommel scarica ogni responsabilità su Bastico e sull’incapacità degli italiani di combattere insieme ai tedeschi, cioè di obbedirgli ciecamente. Nei confronti del suo teorico superiore nutre una profonda disistima: lo considera difficile, autocratico, violento. Lo chiama ’Bombastico’, dice in pubblico che è una merda e in tale edulcorato giudizio accomuna pure Gambara. Non stupisce perciò che davanti alle richieste di Bastico, di Gambara, di Cavallero di non abbandonare la Cirenaica, Rommel reagisca da primadonna stizzosa: minaccia di portare le sue divisioni in Tunisia, se non gli daranno ascolto. Rommel sostiene di non potersi comportare diversamente per l’imperizia dei camerati nel garantire i rifornimenti promessi. E non ha torto. Novembre è stato un mese funesto: dodici mercantili affondati, con essi il 43 per cento del carico e addirittura il 92 per cento del carburante. Stavolta Ultra ha davvero reso preziosi servizi a Londra per decrittare i messaggi inviati da Supermarina con approdi e percorsi delle navi. Una volta di più si è salvato chi ha privilegiato il silenzio radio. Ma se i panzer non hanno benzina per muoversi e le munizioni ai soldati sono contingentate, anche l’esercito multinazionale, che ormai si batte sotto l’Union Jack (si sono aggiunti pure polacchi e gollisti), ha esaurito la spinta iniziale e consumato gran parte delle riserve. L’«abituale passeggiata annuale in Cirenaica», sfottò britannico, viene fermata nel gennaio ’42 alle viste di El Agheila. Auchinleck paventa che una zampata di Rommel colga le unità troppo distanti dai depositi dell’intendenza. Tra morti, prigionieri, feriti l’avanzata è costata circa 17 mila uomini ai britannici e 38 mila alle forze dell’Asse. Nel Mediterraneo comincia a pesare l’irruzione dell’areonautica e dei sottomarini tedeschi. La 2a flotta agli ordini di Kesselring è ritornata in Sicilia con un apparato ancor più imponente: 52 squadriglie di bombardieri in quota e in picchiata, i caccia pesanti Messerschmitt 110 in grado di sorvolare l’acqua in lungo e in largo, decine di ricognitori. Spesso attaccano in coordinazione con i 23 U Boot entrati dallo Stretto di Gibilterra. Per Cunningham sono da subito dolori. Perde portaerei, corazzate, incrociatori. In un mese i ’branchi di lupi’ di Doenitz affondano più naviglio dei 115 sommergibili italiani nei diciotto mesi di guerra. La Royal Fleet si rinserra ad Alessandria e a Gibilterra. Tuttavia nel porto egiziano avviene il magnifico colpo dei ’maiali’ di de La Penne e il giorno seguente, 19 dicembre, anche la coraggiosa Forza K di Malta, cresciuta a 3 incrociatori e 4 cacciatorpediniere, incontra il proprio destino: uscita all’abituale ricerca di prede, incappa in un campo di mine finalmente posato dagli italiani. Insomma il ’42 s’inizia con il Mediterraneo tornato ’mare seminostrum’. Il conquistato predominio produce una singolare decisione: adesso che le acque sono state messo in sicurezza i convogli verranno inviati in Libia con la protezione di un paio di squadre navali. Ma contro chi? A Cunningham sono a malapena rimasti gli occhi per piangere. La Valletta e Alessandria assomigliano a un cimitero di scafi contorti e di comignoli anneriti. Eppure il 3 gennaio la flotta italiana quasi al completo e diverse formazioni di caccia scortano sei mercantili diretti a Tripoli con 144 carri armati, 520 automezzi, mille soldati, numerosi cannoni contraerei, pezzi d’artiglieria, bidoni di carburante, munizioni. Sono i rifornimenti attesi da Rommel per riprendere l’iniziativa nel solito scetticismo dello stato maggiore italiano. A parte Cavallero, che cerca di ragionarci, i nostri generali lo detestano dal profondo del cuore e sono ripagati con eguali sentimenti. Per dare una mano al suo stratega, Hitler trasforma l’Afrika Korps in Panzerarmee Afrika e Rommel ne viene nominato il comandante superiore. I contrasti esplodono puntualmente a fine gennaio. Ad accendere la miccia è il consueto blitz di una robusta formazione di blindati tedeschi inviati a saggiare i riflessi del nemico. Bengasi cade meglio di un frutto maturo. Bastico e Gambara propongono la solita pausa di riflessione, Mussolini e Cavallero se ne fanno portavoce, Rommel finge di non sentire, fa rispondere di essere troppo impegnato sulla linea del fuoco per concedersi il lusso di una riunione sotto la tenda. Avanza fino a inquadrare nel binocolo le fortificazioni di Tobruk. Lui continua a preferire gli avamposti alle retrovie e trova risibile che da quanti ci sguazzano, rincantucciati lontano dal pericolo, giungano inviti alla prudenza. Oggi grazie al memoriale di Amè sappiamo che dietro la fortunata iniziativa germanica si cela lo spionaggio italiano. A fine novembre ’41 due agenti della sezione Prelevamenti del Sim, diretta dal maggiore dei carabinieri Manfredi Talamo, hanno procurato le chiavi della cassaforte in dotazione allo sbadato colonnello dell’aeronautica statunitense Norman Fiske, addetto militare all’ambasciata di via Veneto. Alla vigilia di Pearl Harbour gli uomini di Talamo si sono introdotti nella palazzina, attuale sede del consolato, hanno aperto la cassaforte e fotografato l’oggetto del desiderio: il «Black code» in uso alle forze armate Usa. Forse è stata la migliore operazione del Sim di Amè durante la guerra. L’hanno conclusa appena in tempo, prima che la scriteriata dichiarazione di guerra dell’Italia all’America comportasse la chiusura dell’ambasciata. Talamo, purtroppo, pagherà la sua bravura e la fedeltà al re. Arrestato nel marzo del ’44 quale componente del fronte militare clandestino di Roma, guidato dal colonnello Montezemolo, il suo nome verrà inserito nell’elenco dei 335 ostaggi da fucilare alle Fosse Ardeatine in rappresaglia dell’attentato di via Rasella. Si tratterà della bieca vendetta del maggiore Kappler, responsabile del servizio di sicurezza tedesco. Ha con Talamo un conto aperto dal ’42 quando un’altra sua incursione, stavolta all’ambasciata svizzera, ha scoperto il doppio gioco a favore degli inglesi di Kurt Saurer, addetto culturale presso la rappresentanza diplomatica di Berlino. Kappler avrebbe desiderato che la faccenda rimanesse coperta e di sua competenza, Talamo invece ha tirato dritto. A Washington ripongono una tale fiducia nell’impenetrabilità del «Black code» da trasmettere in chiaro, sicuri che nessun sarebbe riuscito a penetrare quel codice composto da migliaia di tabelle con rimandi infiniti tali da rendere l’Enigma tedesco un cruciverba della domenica. E infatti i genietti raccolti dal Secret Intelligence Service a Bletchley Park l’avevano brillantemente risolto. Gli Stati Uniti hanno conservato il «Black code» pure con l’ingresso in guerra (7 dicembre ’41). Tra gli utilizzatori figura anche il colonnello Frank Bonner Fellers, ufficiale di collegamento al Cairo con il comando britannico in Medio Oriente. I suoi rapporti serali, contenenti il dettagliato riassunto dei guai, delle imprese, degli schieramenti, delle scorte e del morale dell’8a armata, planano dopo due ore sulla scrivania di Amè. Da qui una copia viene inoltrata a Cavallero, che non la degna di uno sguardo, l’altra va a Kesselring, che la divora e la gira all’istante a Rommel. La sua inattesa offensiva del 21 gennaio è nata dall’ultimo rapporto di Bonner Fellers: il colonnello ha svelato ai superiori che l’avanzata inglese è costata moltissime Matilde, che la fanteria è sfinita, che le linee di rifornimento si sono troppo allungate, che gli aerei faticano a proteggerle. Tutto esatto, tutto riscontrato sul campo: i reggimenti australiani e neozelandesi hanno ceduto di schianto; sono stati neutralizzati 377 carri armati, 200 cannoni, 1200 veicoli. L’arrendevolezza dei reparti, gli 800 tank persi dal nemico inducono Rommel a disegnare un piano molto ambizioso: annientare le postazioni a difesa di Tobruk, dove si sono rinchiusi 33 mila soldati, per poi espugnarla e puntare di nuovo verso Sollum. Abbisogna però di rinforzi e di rifornimenti continui. Si ripropone il problema della sicurezza del Mediterraneo. E già: le navi di Cunningham non vi si avventurano, però aerosiluranti e sommergibili hanno ripreso a colpire con chirurgica precisione. Nemmeno agissero dentro un fazzoletto anziché in una vastità sconfinata di mare. Cavallero chiede ad Amè di risolvere il problema dei troppi mercantili persi, dei troppi sottomarini trasformati da cacciatori in prede. Non sarà poi così arduo individuare le spie inglesi, che a suo dire pullulano nei porti. Ad Amè e alla sua squadra di specialisti, tutti ufficiali dei carabinieri, basta muoversi con discrezione per concludere in due settimane che a Londra, a Gibilterra, ad Alessandria le notizie arrivano da fonti di altissimo livello, la più importante delle quali staziona nel quartier generale di Santa Rosa. I collaboratori di Amè appurano che sessantasette alti ufficiali sono sposati con donne straniere, quindi facilmente avvicinabili: tre importanti ammiragli - Mario Farangola, alla guida dei sommergibili, Vittorio Tur, titolare d’incarichi molto delicati, e Bruno Brivonesi, il comandante del convoglio distrutto in novembre nel Canale di Sicilia - hanno mogli inglesi e lo stesso accade con un capitano di vascello, con tre capitani di fregata, con cinque tenenti di vascello. L’indagine del Sim accerta che l’ammiraglio Wilhelm Canaris, capo del servizio informazioni della Wermacht (coinvolto nell’attentato del ’44 a Hitler e impiccato nell’aprile ’45), ha per amante una contessa greca di casa in tante case romane. La signora predilige talmente viaggiare da compiere un giro alquanto tortuoso - da Lisbona a Londra e ritorno - per raggiungere l’ammiraglio negli appuntamenti che si danno in mezza Europa. L’origine e le ascendenze patrizie rendono l’affascinante contessa assidua del più famoso salotto della Capitale, quello di Marc’Antonio Colonna, assistente al soglio pontificio e leader riconosciuto dell’aristocrazia romana. E qui cediamo la parola ai ricordi di Indro Montanelli: «Una volta la settimana d’Arcy Osborne e Myron Taylor, l’uno ambasciatore della Gran Bretagna presso la Santa Sede, l’altro rappresentante personale di Roosevelt, che avrebbero avuto bisogno di un permesso speciale per uscire dalle mura leonine, ma giravano indisturbati per tutta Roma, erano gli ospiti d’onore dai Colonna. Si cominciava con i pettegolezzi su Ciano e sulle sue conquiste femminili al circolo del golf, si passava alle questioni militari, si finiva con l’elenco di chi era a favore dei tedeschi e di chi li avversava. I due volponi, ufficialmente nemici, ma in realtà tenuti nella bambagia, avevano così la possibilità di conoscere vicende, nomi, intenzioni, che in teoria dovevano essere circondati dalla massima discrezione. Volendo, e credo che lo vollero più di una volta, erano nella condizione d’intuire chi faceva al caso loro e chi no. La stessa moglie di Colonna (Helen Sursok, Nda) apparteneva a una famiglia di sangue misto con addentellati in Medio Oriente e in Inghilterra. I parenti della signora Colonna erano proprietari dei docks nel porto di Alessandria, la tana della flotta di Giorgio VI nel Mediterraneo. Dubito che da quel salotto e da quegli incontri sia mai giunta una notizia al Sim del generale Amè, mentre ritengo che ne siano uscite tante dirette a Washington e a Londra.» In questo clima, in cui viene consentito ai rappresentanti delle due principali Potenze nemiche di far vita sociale, non sorprende quanto affermato dal capitano Ellis M. Zacharias, vice comandante del Naval Intelligence statunitense, nella sua autobiografia, Secret Missions: le imboscate dei primi mesi di guerra contro i sommergibili italiani nel Mediterraneo e nel Mar Rosso e i successivi affondamenti d’incrociatori e mercantili erano dovuti alle soffiate provenienti da Roma e dall’Ufficio Informazioni. L’ammiraglio Angelo Jachino, comandante della squadra nella drammatica notte di Capo Matapan, ha scritto: «Anche a Roma le notizie filtravano con grande facilità e durante il mio comando ebbi più volte l’occasione di segnalare l’avvenuta diffusione di un’informazione quasi certamente trapelata per opera, sia pure involontaria, di elementi del ministero. Supermarina e l’Ufficio Informazioni non hanno mai voluto ammettere che la loro organizzazione fosse difettosa per quanto riguardava la riservatezza e tendevano ad attribuire la colpa a elementi periferici.» E in tale spensierata e sconsiderata gestione delle proprie attività la mitica Supermarina quali provvedimenti assume? Nel maggio del ’41 hanno affidato la guida del controspionaggio all’ammiraglio Franco Maugeri. Come primo atto amministrativo ha dato un nome alla sezione: Servizio informazioni segretissime. Paradossalmente lo stesso acronimo del servizio segreto britannico, Sis (Secret intelligence service). Quindi ha ottenuto di partecipare alle riunioni giornaliere di vertice, quelle in cui si varano le missioni più segrete, si stabiliscono date e rotte delle navi in partenza. Al termine del conflitto, poco prima di essere nominato capo di stato maggiore, l’ammiraglio Maugeri riceverà la Legion of Merit «per la condotta eccezionalmente meritoria nell’esecuzione di altissimi servigi resi al Governo degli Stati Uniti come capo dello spionaggio navale italiano». Per gli stessi «altissimi servigi» l’ammiraglio sarebbe dovuto finire sotto inchiesta in Italia. E infatti un magistrato ordinario vedrà in quella motivazione la prova del tradimento, ma un magistrato militare archivierà riconducendo la prestazione degli «altissimi servigi» all’epoca della cobelligeranza. Maugeri ha sempre affermato di essersi comportato secondo coscienza. Ha vergato un libro di memorie in lingua inglese (From the Ashes of Disgrace), destinato al pubblico dei vincitori. Probabilmente non si aspettava che ampi stralci venissero tradotti in italiano. Ne derivò una polemica violentissima. Maugeri infatti scriveva: «L’Italia era piena d’inglesi e di italiani amici e simpatizzanti della Gran Bretagna, soprattutto tra l’aristocrazia. Io dubito che esistessero molte spie inglesi in Italia: essi non ne avevano davvero bisogno. L’Ammiragliato britannico aveva abbondanti amici fra i nostri ammiragli anziani e nello stesso ministero della Marina. Sospetto che gl’inglesi fossero in grado di ottenere informazioni direttamente alla fonte. In questo caso non c’era bisogno di spendere denari e sforzi per avere un esercito di agenti scorazzanti per i fronti a mare di Napoli, Genova, Taranto, La Spezia.» A fronte di un’analisi così lucida il Sis di Maugeri mai riuscì a identificare un amico dell’ammiragliato inglese o a scoprire la filiera che favoriva il passaggio delle informazioni, a causa delle quali migliaia e migliaia di marinai italiani facevano la fine dei topi nel Mediterraneo. Da parte del Sis non fu offerta alcuna collaborazioni al Sim, anzi si cercò di sbarrare il passo a ogni iniziativa dei cugini. Ma il motivo vero di tanta insipienza o incapacità va forse cercato in un altro passo dell’autobiografia dell’ammiraglio: «L’inverno del ’42-’43 trovò molti di noi, che speravano in un’Italia libera, di fronte a questa dura, amara, dolorosa verità: non ci saremmo mai potuti liberare delle nostre catene, se l’Asse fosse stato vittorioso.» E poco più avanti il concetto viene meglio specificato: «Più uno amava il suo Paese, più doveva pregare per la sua sconfitta nel campo di battaglia... Finire la guerra, non importa come, a qualsiasi costo.» Tutto giusto, tutto condivisibile, tranne quell’irrilevante dettaglio: i ragazzi italiani mandati a morire sugli incrociatori, sui mercantili, nei sommergibili affinché l’Asse non vincesse e la guerra fosse conclusa a «qualsiasi costo». Forse non è un caso che nella versione italiana dell’autobiografia, pubblicata nel 1980 con il pudico titolo Ricordi di un marinaio, i passi più controversi siano stati attenuati o cancellati. Nel 1952 uno straordinario saggio di Antonio Trizzino (Navi e poltrone) squarciò il velo delle ambiguità. Trizzino era stato un ufficiale di aviazione, aveva provato la rabbia e il dispetto di tante missioni andate a male. Parlò apertamente dei sospetti, fece nomi e cognomi: l’ammiraglio Franco Maugeri, l’ammiraglio Priamo Leonardi (comandante della piazzaforte di Siracusa e Augusta il 9 luglio ’43 lanciò il < Il comportamento della marina italiana irrita i tedeschi allorché Malta diventa il problema principale. A sottolinearlo è indirettamente Rommel con il suo insistere sull’assoluta necessità di aver garantiti i rifornimenti in vista della nuova offensiva. Lo spalleggia Cavallero pronto a giocarsi la poltrona su una mossa da lui ritenuta fondamentale per gli sviluppi sul teatro africano: le sorti della Libia, chiarisce il capo di stato maggiore generale, dipendono da Malta. Finalmente qualcuno se n’è accorto. Non a caso Ugo Cavallero è il miglior generale in circolazione o se volete il meno peggio. Prono a Mussolini alla pari di Badoglio e di Graziani, ma con le idee ben chiare. Nato a Casale Monferrato nel 1880, laureato in matematica al Politecnico di Torino, a soli trentotto anni ha ricevuto i gradi di generale quale ricompensa per il brillante piano sfociato nello sfondamento di Vittorio Veneto, che ha posto fine alla prima guerra mondiale. A quarant’anni ha lasciato l’esercito per assumere l’incarico di direttore generale della Pirelli. Poi è stato un crescendo di riconoscimenti: deputato, sottosegretario alla Guerra, senatore, presidente dell’Ansaldo. E’ intelligente, ambizioso, abile tessitore di relazioni, ovviamente legatissimo al regime, che nel ’37 l’ha richiamato in servizio per affidargli l’Africa Orientale, dove i suoi predecessori, Badoglio e Graziani, non avevano lasciato un buon ricordo. Nemico acerrimo di Badoglio, l’ha scalzato da un anno e mezzo. La conquista di Malta potrebbe essere il fiore all’occhiello. Anche Kesselring appoggia il suo atteggiamento risoluto, pur meravigliandosi che per diciotto mesi lo stato maggiore italiano non abbia risolto la pratica. Ma esercito, aeronautica e marina si sono palleggiati la soluzione, ciascuno convinto che spettasse agli altri due intervenire. In tal modo non si è provveduto neppure alla precauzione più elementare: chiudere la strettoia naturale esistente fra Pantelleria e le coste algerine. Sarebbe bastato piazzare un’adeguata copertura di mine, una manciata di sottomarini e un po’ di incrociatori pesanti per impedire all’Inghilterra di approvvigionare l’isola e di installarvi quella Forza K che per mesi ha costituito una spina molesta. Così, ciò che nel giugno ’40 rappresentava una banale influenza - ancora nel ’39 il comitato dei capi di stato maggiore britannico aveva sentenziato: «Nulla può esser fatto per difendere Malta» - è stato trasformato dalla nostra insipienza in una polmonite complicata da debellare. Per riuscirci Cavallero annuncia di voler assumere la guida delle operazioni. Kesselring lo sostiene avviando da marzo una forsennata campagna di distruzione. Gli suggerisce anche di spostare in Sardegna e a Pantelleria i Macchi 202, i Fiat Cr42, i Savoia Marchetti 79, per avere una forza di pronto intervento in grado d’intercettare alla bisogna i convogli; di coordinare gli attacchi con le navi; di predisporre agguati notturni con i mas. Cunnigham prova a inviare da Alessandria quattro piroscafi protetti da un velo d’incrociatori leggeri e di cacciatorpediniere affidati all’ammiraglio Philip Vian. Per contrastarli prendono il largo la Littorio, tre incrociatori (due pesanti), dieci cacciatorpediniere. La squadra viene ancora affidata a Jachino. Nonostante la straripante supremazia delle nostre navi, la seconda battaglia della Sirte si conclude con un sostanziale pareggio, che suona scorno per Supermarina. La mattina seguente tocca agli Stukas distruggere i piroscafi inglesi. Stukas e Messerschmitt non concedono requie ai difensori di Malta. Li affiancano i Macchi, il nostro aereo più bello, un caccia pari ai rivali, ma che produciamo in quantità limitata per le note penurie di materie prime. I bombardamenti polverizzano le piste e i ricoveri degli Spitfire, smantellano le batterie contraeree, affondano persino tre sommergibili. La popolazione offre una prova mirabile di attaccamento a quella che non è nemmeno la madre patria. In silenzio soffre le distruzioni, le morti, il pericolo continuo, le draconiane limitazioni del razionamento. Il 20 aprile Churchill si fa prestare da Roosevelt la portaerei Wasp per lanciare 46 Spitfire verso l’isola. Tre giorni dopo ne avanzano 6. A fine aprile su Malta sono state sganciate 6557 tonnellate di bombe. Churchill annuncia che la situazione è insostenibile; tutto ciò che galleggia ripara ad Alessandria. I convogli italiani ormai navigano in scioltezza. Rommel riceve 300 carri armati tedeschi, 250 italiani, scorte rilevanti di cibo, di granate, di munizioni, di veicoli, di carburante. Mai si è visto tanto ben di dio sui moli della Libia. Viene immediatamente approntato il piano Aida per l’invasione dell’Egitto. In contemporanea si definisce l’invasione di Malta. L’operazione è ribattezzata C3-Hercules, sintesi del piano italiano Esigenza C3 e di quello tedesco Hercules. Kesselring spinge per accelerare i tempi: finché gli aerei si occupano di Malta non possono sorreggere l’imminente avanzata di Rommel. La Wermacht aggrega la 7a divisione paracadutisti del generale Student (7 mila uomini, 500 aerei da trasporto, 200 alianti) alla forza da sbarco approntata da Cavallero, a un passo dal personale trionfo. In teoria niente è stato lasciato al caso: 100 mila soldati, 1600 mezzi motorizzati, 400 cannoni, 270 mortai, 600 manichini da lanciare dagli aerei per confondere i difensori. Lo stesso stratagemma che nel ’44 sarà impiegato dagli Alleati nelle prime ore dello sbarco in Normandia. I parà della Folgore hanno compiuto lanci su Cefalonia, la cui morfologia è stata definita identica a quella di Malta. Per superare l’ostacolo delle alte scogliere viene previsto l’impiego d’imbarcazioni munite di scale mobili sottratte ai vigili del fuoco. Soltanto la flotta sembra esentata da questo sforzo: ufficialmente nessuno le ha chiesto di presentarsi davanti a Malta e bombardarla per favorire lo sbarco. A comandare l’operazione viene scelto l’ammiraglio Vittorio Tur, il cui fratello Enrico Paolo, transfuga in Francia da vent’anni, fa giungere a Londra puntuali informazioni sulla nostra marina. Enrico Paolo Tur ha già comunicato la consistenza del corpo di sbarco, il suo addestramento sulla costa toscana, i nomi in codice assegnati agli obiettivi, stranamente desunti da località cipriote, Famagosta, Larnaka, Limassol, Pafos. Contro l’invasione non congiura soltanto la rete degli ammiragli, ma anche qualche generale di spicco come Carboni. L’ex responsabile del Sim guida una delle divisioni d’assalto, la Friuli. In questa veste si adopera con Ciano, con il Re, con Umberto per convincerli che l’impresa è destinata a inevitabile fallimento. A bloccare tutto interviene il vertice del 30 aprile al castello di Klessheim, nei pressi di Salisburgo. Nel vantare i propri successi sul fronte orientale Hitler domanda a Mussolini un’armata per l’Urss, dove sarà spostata pure la 2a flotta aerea. Il Csir, a malapena accettato l’estate precedente, è oramai giudicato insufficiente. Mussolini inizialmente strologa di mandare venti divisioni da formare con i 150 mila operai richiesti dal Terzo Reich in aggiunta ai 200 mila già al lavoro in Germania. Alla fine il duce si limiterà a pescare nel serbatoio di divisioni disponibile nella Penisola, ma anche questa scelta peserà e non poco sulle sorti dell’Africa Settentrionale. Durante la riunione Hitler si fa portavoce anche delle esigenze di Rommel: reso euforico dai rifornimenti ricevuti, il comandante della Panzerarmee Africa scalpita per muoversi. L’obiettivo è costituito dalla linea Sollum-Halfaya con incorporata liberazione di Tobruk. Per arrivarci a Rommel serve anche il massimo appoggio aereo. Ne ha bisogno per contrastare la Western Desert Air Force (WDAF) del vice maresciallo dell’aria Arthur Coningham, detto ’Mary’ a causa dell’origine neozelandese. Il suo nerbo è costituito da un aereo fornito dagli Stati Uniti, il Curtiss P40, limitato come caccia, ma devastante negli attacchi al suolo. Occorrono dunque i caccia e i bombardieri fin lì scagliati contro Malta. Al duce e a Cavallero viene lasciata la libertà di acconsentire. Il primo lo fa con aria di sufficienza, il secondo aderisce con atteggiamento servile, già dimentico di aver impegnato il proprio onore di militare sulla conquista di Malta prima di qualsiasi iniziativa in Libia. Per addolcire la pillola Kesselring gli assicura che appena le unità di Rommel si saranno assestate sul confine egiziano, tutti gli aerei tedeschi saranno adoperati per piegare Malta. Viene anche indicata una data precisa, il 20 giugno. E una volta occupata l’isola, i panzer germanici avranno la totale libertà di puntare verso il Cairo, il Canale di Suez, il petrolio mediorientale. |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

