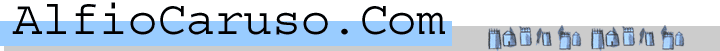
|
|
|
| - Primo capitolo -
acquista il libro on line torna all’archivio
Se la memoria ha un senso La foto sulla parete del salotto
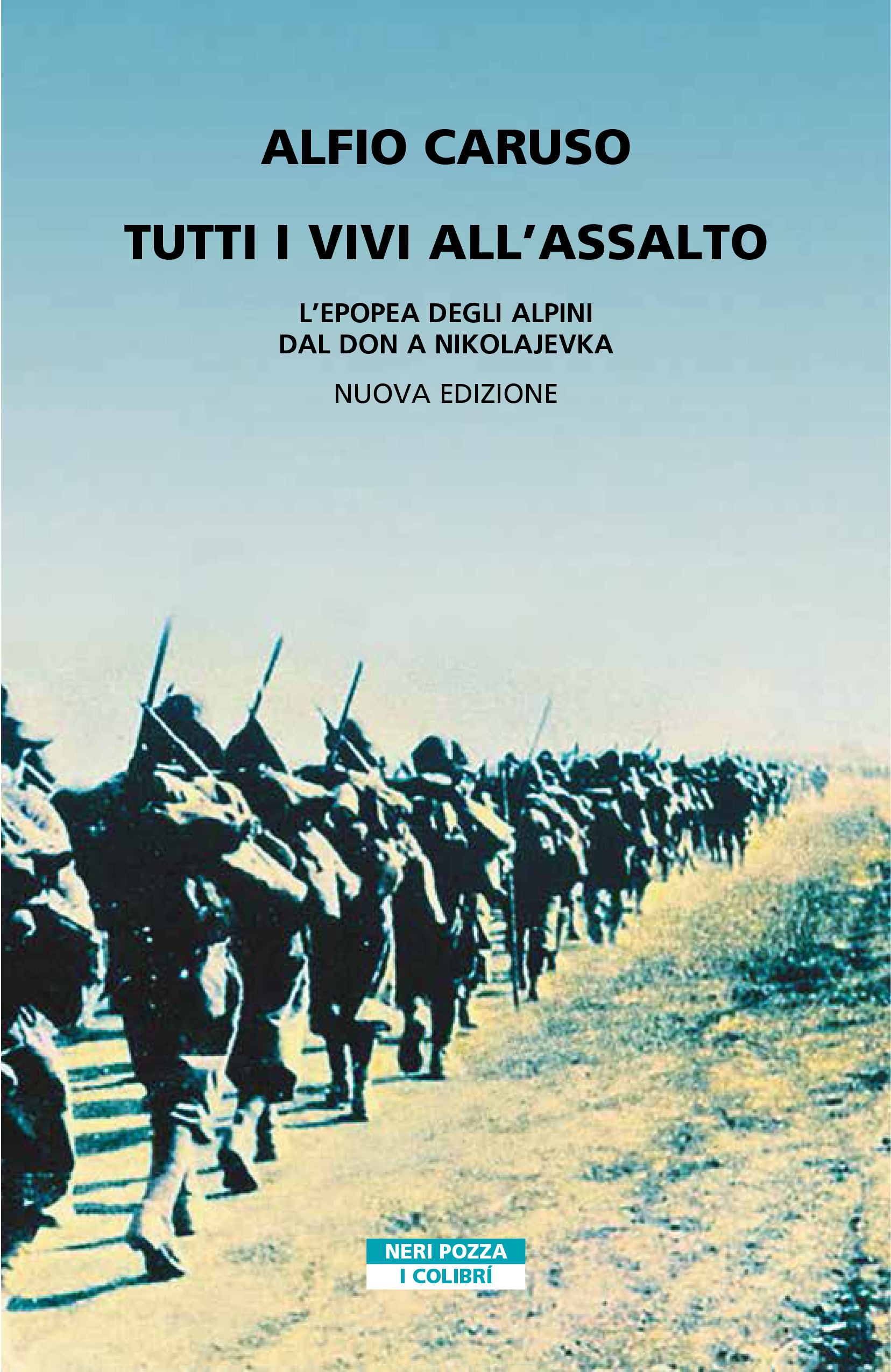 Tutte le volte che s’andava in casa della nonna, Pippo
sorrideva appena dalla parete del salotto. Era una foto del 1942: Pippo indossava
la divisa da capitano medico, aveva la posa impacciata di un introverso desideroso
di apparire disinvolto. La foto celebrava la fresca promozione, sarebbe servita
per l’album delle memorie, magari lui e Maria l’avrebbero osservata con affetto
e ironia il giorno delle nozze d’argento, nel 1968, a ricordo della passata
giovinezza. Stampigliate sul retro la foto presentava le referenze dell’autore:
’studio d’arte’ e prima del nome un ’cav.’ svolazzante. Finché
non si scioglieva nel suo caldo sorriso, Pippo era d’aspetto severo. Un po’
la timidezza, un po’ la preoccupazione di chi ha capito che la vita è
una prova dietro l’altra. Pippo vi era cresciuto in mezzo, orgoglioso di
averle fin lì superate. Era l’unico maschio venuto dopo due femmine
(Pippa e Sasai) e prima di un’altra (Angelina). Papà era un impiegato
del porto, la mamma discendeva da nobili lombi, ma nella discesa s’erano
perse le sostanze ed era rimasta l’ambizione del figlio laureato. Pippo c’era
riuscito giusto in tempo per finire nei gorghi della guerra cominciando nel
’39 con il servizio di leva. Nella foto in cornice Pippo ha poco
meno di trent’anni, il bel volto attraversato da uno sguardo malinconico,
la massa di capelli scuri e riccioluti adattati alla moda militare. Per oltre
mezzo secolo Pippo ha sempre avuto poco meno di trent’anni. Splendente di
giovinezza è rimasto su quella parete a veder morire i genitori e
invecchiare le sorelle. Ha assistito all’incrociarsi di cento destini, ha
ascoltato mille volte la consueta domanda di quanti per la prima volta mettevano
piede nel salotto di nonna Pippa: "Chi è?", un dito, un cenno del
capo a indicarlo. "E’ Pippo...Mio fratello...Non è tornato dalla
Russia..." Il capitano Giuseppe La Greca, Pippo dalla nascita, in Russia
non sarebbe dovuto andare. All’inizio del ’41 l’avevano spedito sul fronte
greco-albanese presso la ’Julia’, 3° reggimento d’artiglieria, gruppo
Conegliano. Era rientrato l’anno seguente con la malaria. Ma la malattia
pareva un dettaglio trascurabile con tutti quegli alpini mortigli intorno
per le polmoniti, per il gelo, per le infezioni, ogni tanto anche per le
pallottole dei greci. L’importante era che fosse tornato salvo e quasi sano.
Pippo aveva ringraziato Dio. La mamma e le sorelle la Madonna, alla quale
si erano espressamente rivolte ogni sera durante il rosario recitato intorno
al braciere con la carbonella. Nella tarda primavera del ’42 Pippo,
seppur convalescente, era preso dai preparativi del matrimonio con Maria.
La data era stata fissata per l’inizio del ’43, il giorno preciso ancora
da stabilire. Pippo e Maria stavano insieme da troppo tempo perché
la guerra potesse costituire un freno al loro amore. Anzi l’aveva accelerato.
Pippo non era più il poetico fidanzato, che nel ’39 da Firenze aveva
inviato a Maria una sua foto con questo breve messaggio: "Mentre sogno il
mio bene leggendo ciò che le sue adorabili dita hanno voluto imprimere".
E si vede lui, in perfetta tenuta, cinturone al fianco, bustina sulla testa,
seduto in terra con una lettera tra le mani. La guerra aveva cancellato
qualsiasi slancio. Al fronte Pippo aveva sentito a ogni passo il brutto alito
della morte sul collo. Gli era venuta voglia di avere qualcosa di suo; ciò
che ogni uomo avverte, sbagliando, come la proprietà più intangibile:
un figlio. Poi era arrivata la comunicazione dal comando: si parte per la
Russia. La Russia? In casa La Greca era l’altro mondo, molto più lontano
e angosciante dell’America, dove qualcuno della famiglia era andato. Ma in
America c’erano tanti cristiani, c’erano le chiese, c’erano pure gli italiani
e soprattutto c’erano i siciliani. In Russia c’erano i comunisti, c’erano
la neve e il ghiaccio, non c’erano più chiese, non c’erano italiani
e meno che mai siciliani. L’invocazione della mamma, del papà,
delle sorelle era stata unanime. Pippo non andare... Pippo é
pericoloso... Pippo sei già stato in Grecia... Pippo pensa a
noi... Pippo pensa a Maria... Anche Maria gli aveva chiesto sottovoce
se era proprio necessario che partisse e in questo caso che ne sarebbe stato
del loro matrimonio. " Ma per gennaio siamo a casa", l’aveva rassicurata
Pippo, che era il primo a non crederci. Pippo avrebbe potuto giocare la
carta della malaria, ma la religione del dovere in cui era stato allevato
gliela vietava. E più forte di questa fedeltà a se stesso s’imponeva
la fedeltà agli alpini. Non l’aveva chiesto lui di essere assegnato
alle penne nere, vi era stato inviato da Zara. Si trovava in Dalmazia, aggregato
alla fanteria, allorché le forti perdite subite nello scriteriato
assalto alla Grecia avevano imposto di mandare quanti più medici possibili
in prima linea. Pippo era pratico di mare e di montagna: la riviera dei Ciclopi
amata e goduta per nove mesi l’anno, l’Etna ammirata e rispettosamente sfidata
con gli sci e in estenuanti escursioni a piedi. A differenza degli altri
catanesi, che dell’enorme vulcano sono orgogliosi a parole, ma indifferenti
nell’intimo, Pippo lo avvertiva come un contrafforte della propria natura:
per lui lapilli, cenere e lava s’impastavano con i muscoli e con il sangue
di ognuno nato e cresciuto ai piedi dell’Etna. Una razza atipica di montanari
- ma esiste qualche categoria umana, di cui i siciliani non costituiscano
la variante eccentrica? - destinati per regio decreto a servire tra gli alpini.
Pippo ne aveva trovati alcuni, fierissimi di esserci, nei tre reggimenti
della ’Julia’, l’8°, il 9° più il 3°, quello di artiglieria,
il suo. In una settimana Pippo era precipitato dalla tranquilla attività
di guarnigione a Zara, dove le malattie veneree erano le insidie più
comuni, in un girone infernale di corpi trapanati, di membra sbrindellate,
di ragazzi spirati chiedendo il favore di stringere una mano. Al fronte i
sentimenti si erano cementati. La ’Julia’ era diventata madre e padre, ogni
alpino un fratello. Le sofferenze, i dolori, lo smarrimento, le angosce del
mattatoio greco-albanese si erano impressi sulla pelle e quelli che Pippo
non aveva visti e vissuti in prima persona, c’era sempre qualcuno pronto
a raccontarli. Ogni nome portava una pena. Il ponte di Dragotti preso e perso,
ripreso e riperso: dieci morti per ogni metro in avanti o indietro. Il ponte
di Perati, che aveva ispirato la canzone più triste e più bella
di tutta la guerra. Il Golico, la montagna feroce, con le pendici puntellate
di povere croci, spesso solo un cognome senza neppure la data: niente di
più per "la meglio gioventù che va sottoterra". La linea del
Mali: la ’Julia’ vi si era aggrappata con le unghie, non aveva mollato un
millimetro, una resistenza disperata come disperata era stata la volontà
di riportare a valle i morti per seppellirli. E poi: i plotoni, le compagnie
sbarcate a Durazzo senza fucili, con l’ordine di prendere quelli dei morti;
la leggenda, sussurrata, dell’alpino della ’Tridentina’ che aveva tentato
di uccidere il re; Mussolini in visita al fronte impegnato a spingere la
macchinona bloccata dal fango... Pippo aveva imparato che le penne
sul cappello calabrese - penne d’oca, di gallina, di tacchino, di ogni uccello
che capiti a tiro e quasi mai la penna di aquila richiesta dal protocollo
- restano impettite e gagliarde solo all’inizio, dopo qualche giorno s’ammosciano,
si rinsecchiscono, si piegano, ma non si spezzano al pari dei proprietari.
Li avvinceva e li univa un fortissimo senso di appartenenza: un corpo speciale
a misura di Alpi e Dolomiti. Alpino il nonno, alpino il padre, alpino il
figlio prossimo venturo. Ogni compagnia una valle, ogni plotone un dialetto.
Il nome stesso dei battaglioni, Tolmezzo, Gemona, Cividale, Vicenza, L’Aquila,
Val Cismon, e dei gruppi di artiglieria, Conegliano, Udine, Val Piave, richiamava
per molti l’uscio di casa, i sapori del paese. Fratelli, cugini, cognati
sparpagliati nei reparti, a darsi la voce l’un con l’altro, a tenere i fili
di conoscenze antiche, a ricordare le ragnatele familiari che legavano un
morto all’altro, a valutare i ’cittadini’, cioè quelli giunti da Milano
e da Catania, da Parma e da Bologna. Esami lunghi e silenziosi. Pippo
c’era abituato agli esami, eppure la sera in cui gli avevano regalato il
cappello con una lunghissima e lucente penna di gallo aveva gioito più
che alla laurea. In quei mesi di comunanza Pippo aveva compreso che il cappello
è la metà dell’alpino. L’aveva visto usare quale riparo dalla
pioggia, dalla neve, perfino dal sole quando la bella stagione conciliava
un sonnellino all’aperto. L’aveva visto trasformarsi in una comoda coppa
per raccogliere l’acqua dalle sorgenti e in una perfetta zuppiera per la
pastasciutta e la minestra. Lo stesso cappello che al momento propizio era
divenuto il contenitore di uova, di frutta, di pennuti, di bottiglie, di
scatolette sgraffignati qua e là per placare una fame implacabile.
Al termine di quella sera in cui era stato ammesso tra le penne nere ("Sul
cappello che noi portiamo/ c’è una lunga penna nera/ che a noi serve
da bandiera/ su pei monti a guerreggia"), gli avevano detto che dopo la guerra
il cappello gli sarebbe servito per misurare la crescita di suo figlio, che
all’inizio il ’bocia’ ne sarebbe stato sommerso, ma anno dopo anno l’avrebbe
portato sempre meglio finché non avrebbe avuto il suo. Perché,
naturalmente, il figlio di Giuseppe - così lo chiamavano gli artiglieri
del Conegliano - sarebbe stato un alpino. Già lo aspettavano. Insomma
dalla Grecia, assieme alla malaria, Pippo aveva riportato il mal di ’Julia’.
Gli era toccato leggere sui giornali sia l’affondamento della nave Galilea,
con ottocento ragazzi del Gemona scomparsi in mare, sia la cerimonia di Udine
per la consegna della medaglia d’oro all’8° reggimento, al 9° e al
3°, il suo. Lacrime, commozione, ricompense strameritate e pagate con
migliaia di cadaveri, tuttavia sullo sfondo era rimasta a galleggiare la
sensazione che quelle medaglie fossero soprattutto una spinta in più
per la nuova campagna. Pippo aveva sentito parlare della Russia da Gildo,
l’attendente, mesi prima. Allora gli era parso uno di quegli annunci sensazionali,
che corrono da una postazione all’altra prima di perdersi in una densa vaghezza.
Gli alpini in Russia? Per male che vada, aveva commentato Gildo, dovranno
riportarci in Italia e toglierci da questa merdaccia. Li avevano tolti
dalla merdaccia e li mandavano in Russia. Continuavano a chiamarla alla
vecchia maniera degli zar, Unione Sovietica era una definizione troppo recente
e per di più puzzava di comunismo, di ebraismo, di modernismo
Pippo all’inizio dell’estate ebbe due attacchi di malaria. Violentissimi
e brevissimi. In famiglia tirarono un sospiro di sollievo: vedi che stai
male? Dove vuoi andare in queste condizioni? Nel dormiveglia del febbrone
a Pippo rivenne in mente il brusco congedo del tenente colonnello Rossotto,
il comandante del Conegliano: "Capitano, mi raccomando: non tirate in ballo
la malaria per restarvene a casa mentre il reggimento torna in prima linea
ad assolvere la propria missione." Fosse stato per Rossotto, Pippo avrebbe
marcato visita. Ma come tradire se stesso? Come lasciare soli i suoi alpini,
a cominciare da Gildo così giovane e devoto, che al suo cuore raffigurava
il fratellino che non aveva avuto e il figlio che non aveva ancora? Appena
fu in grado di reggersi sulle gambe, si presentò al distretto, declinò
nome, grado, reparto, annunciò di voler raggiungere la ’Julia’ sotto
la propria responsabilità. Un sottufficiale con aria complice gli
chiese se voleva che lo stipendio gli fosse pagato per intero in Russia o
se preferiva, vista la cifra, che una parte gli venisse versata in Italia.
"Che cifra?", chiese Pippo. "Con l’indennità di missione, signor
capitano, sono più di quattromila lire al mese... Niente male, non
è vero?" Niente male, no. Pippo non aveva mai visto quei soldi
tutti insieme e avrebbe scommesso che non li aveva mai visti nemmeno suo
padre. Pensò a Maria, al matrimonio, alla possibilità di avere
da parte un po’ di risparmi per le prime spese; pensò ai genitori,
ai sacrifici affrontati per farlo studiare. Disse che gli bastava ricevere
in Russia lo stipendio mentre l’indennità di missione, tremila lire,
sarebbe venuta a ritirarla suo padre. Forse fu l’idea dei prossimi guadagni
che l’indusse a investire la paga di un mese nell’acquisto di bende, chinino,
sulfamidici, tintura di iodio. Comprò in farmacia tutto quello che
gli era mancato in Grecia. Ne riempì una valigia. Salì sul
treno per il Continente ad agosto. Al momento degli abbracci in casa, cui
sarebbero seguiti quelli sotto la pensilina e dentro lo scompartimento, la
mamma gli aveva dato un crocefisso con la raccomandazione di metterlo sopra
la brandina: avrebbe provveduto Lui a proteggerlo dalla malaria. Ai genitori,
alle sorelle, a Maria, ai nipoti che lo guardavano con orgoglio misto a invidia
(va a vincere la guerra...) la malaria sembrava molto più preoccupante
dei sovietici e del loro mitra con il caricatore a tamburo, del quale erano
già trapelati racconti da brivido. L’accompagnarono alla stazione.
Pippo s’affacciò dal finestrino per salutare, promise che avrebbero
trascorso il Natale insieme. Sparì assieme al treno dietro la curva,
che sembra far sprofondare il binario in mare. La prima lettera di Pippo
ha la data del 24 agosto, é indirizzata al padre. Pippo accenna al
dovere da compiere, alle attese della Patria: per lui dovere e Patria coincidono
nell’obbedienza. In qualche riga sventola a mo’ di bandiera l’italianità,
sulle frasi aleggia un velo di rassegnazione. L’unica consolazione è
la presenza degli alpini, l’essere in mezzo a quelli che egli giudica i migliori
soldati del mondo, nonostante gli abbiano rifilato un tiro mancino: a Udine
hanno svuotato la valigia dei medicinali e l’hanno riempita di bottiglie
di grappe avvolte nella bambagia. In tal modo la scorta di liquori ha evitato
controlli e sequestri. Il disappunto di Pippo si è perso nella baldoria
di cento brindisi, nessuno ha preso sul serio le sue rimostranze. Nell’accogliente
estate sovietica, la guerra appare lontana: chi può immaginare che
da lì a qualche mese il materiale abbandonato a Udine sarà
amaramente rimpianto? L’Unione Sovietica sembra a Pippo un Paese a
pezzi, ai confini dell’Europa e della civiltà. Rimane colpito dalla
povertà dei contadini, dagli abiti sudici e logori. Fa il paragone
con le regioni della Germania attraversate durante il lunghissimo viaggio,
fa il paragone con la determinazione dei tedeschi, soprattutto delle donne:
gli sembrano proiettati all’unisono verso la vittoria. Scrive che i comandi
hanno suggerito agli ufficiali di spiegare alla truppa che tanta indigenza
è colpa degli ebrei, che adesso grazie ai soldati dell’Asse la popolazione
sovietica si è potuta ribellare agli "avidi giudei" e avviarsi verso
l’era della rinascita. Anziché sul Caucaso, la Julia e le altre
due divisioni alpine, Tridentina e Cuneense, sono inviate sulla linea del
Don. Gli alpini in pianura sono un controsenso, ma il nostro Stato Maggiore
è ben lieto di accogliere la richiesta dell’Oberkommando di Berlino.
Pippo, però, di questo non parla: gli preme rassicurare madre, padre,
sorelle sulle sue ottime condizioni di salute, sul morale più che
buono, sull’assenza di pericoli. A volte nella stessa busta infila messaggi
per ogni componente della famiglia, cognati e nipoti compresi: si preoccupa
per i bombardamenti in Italia, è in ansia per la sorella minore, Angelina,
trasferitasi dopo il matrimonio a Milano. Invia a lei una parte della stipendio
e pacchi di generi alimentari acquistati allo spaccio. Da casa insistono
con le raccomandazioni, gli chiedono di curarsi, di non fare l’eroe, lui
replica spiegando che la guerra per ora l’hanno ascoltata nelle parole dei
bollettini: "...mamma carissima, che cosa vuoi che mi succeda? Gildo ha provveduto
a collocare il tuo crocefisso sopra il comodino accanto al letto: ho più
angeli custodi io che il mio generale...". Nell’autunno la corrispondenza
s’infittisce. Pippo scherza sulla neve ("quella dell’Etna è più
bella"), sul buio incombente, sui preparativi per affrontare il freddo. Accenna
a un’imminente offensiva, rievoca l’eccitazione di molti per un discorso
di Mussolini trasmesso dalla radio. Chiede continuamente notizie di tutti,
cerca di ricostituire a migliaia di chilometri l’ambiente e il calore della
famiglia. Si lamenta se non gli rispondono con sollecitudine, invita a usare
la posta aerea, che in sette-dieci giorni viene recapitata. E’ un profluvio
di lettere, intervallate da qualche cartolina speciale in dotazione alle
Forze Armate. Recano stampigliati gl’incitamenti del principe ereditario
Umberto e di Mussolini. Umberto è monocorde, buono per tutti gli usi:
"Temprate le vostre forze, perfezionate il vostro sapere, alimentate la fede".
Mussolini è più vario, a cavallo tra passato e futuro, con
un occhio alla Storia. "Affermo solennemente, e senza tema di essere smentito
né oggi né mai, che la responsabilità della guerra ricade
esclusivamente sulla Gran Bretagna". Oppure: "L’avvenire è nostro,
è nelle nostre mani sicure, poiché sarà il prodotto
del nostro coraggio e della nostra inesauribile volontà di vita e
di vittoria". Ma la vittoria si allontana. A metà dicembre ’42
la 1a armata Guardie e la 6a armata con robusto sostegno di blindati sfondano
nel settore tenuto dalle divisioni ’Ravenna’, ’Cosseria’, ’Pasubio’. E’ l’operazione
’Piccolo Saturno’, seguito dell’operazione ’Urano’ con cui i soldati di
Stalin un mese prima hanno stretto d’assedio la 6a armata tedesca a Stalingrado.
Per mettere un argine e proteggere la precipitosa ritirata delle sei divisioni
di fanteria (nello sfaldamento sono state coinvolte anche la ’Celere’, la
’Sforzesca’ e la ’Torino’) il generale Gariboldi, comandante dell’Armir (Armata
italiana in Russia), ordina alla ’Julia’ di correre in aiuto. In quarantott’ore
gli alpini lasciano la postazione a nord dello schieramento, comprendente
anche la ’Tridentina’ e la ’Cuneense’, e si precipitano nell’ansa del Don
tra Nowo Kalitwa e Krinitschnaja. Con l’apporto di sparuti contingenti germanici
la ’Julia’ è una sorta di frangiflutti in un Oceano in tempesta. L’offensiva
sovietica è in pieno sviluppo: a destra della divisione per duecento
chilometri, fino a Stalingrado, resistono pochissimi reparti italiani, rumeni
e ungheresi. La ’Julia’ diviene da subito l’ostacolo da eliminare per prendere
alle spalle la ’Cuneense’, la ’Tridentina’, la raccogliticcia divisione territoriale
’Vicenza’, subentratale nell’antica posizione. Dal 20 dicembre la lotta
s’inasprisce. Gli attacchi delle divisioni sovietiche, composte da quindici
battaglioni, mentre quelli italiani sono stati ridotti a sei da una geniale
trovata di Mussolini, continuano senza soste. Li appoggiano un gran numero
di carri armati - gli enormi ed agili T34, i mastodontici KV1 e 2 - innumerevoli
squadriglie caccia (ai Mig 3 si affiancano i nuovissimi Lavochkin La-5) e
parecchi esemplari di un bombardiere che appare imperforabile, l’Ilyushin
Il-2. Gli alpini s’inchiodano al terreno nel senso che scavano le buche e
vi rimangono dentro giorno e notte, con i piedi congelati, le mani rattrappite,
i denti bloccati dal freddo. I comandi dei tre reggimenti della ’Julia’ ignorano
che cosa avviene ai loro fianchi, ci si arrangia a vista. I tedeschi faticano
a tenere le posizioni, le penne nere sono spesso chiamate a metterci una
pezza. La temperatura scende a -30°, i magazzini con le nuove divise
vengono bruciati per non farli cadere in mano russa. Non esistono baracche,
tanto meno ricoveri, gli unici sono le buche scavate per combattere. La dotazione
è di una coperta a testa, qualche fortunato ne ha un paio. Alcuni
anfratti sono trasformati in tane: ci si accuccia nelle pause tra un combattimento
e l’altro ed è un gran sollievo passare dai -30° dell’esterno
ai -20° di questi improvvisati rifugi. Si dorme a turno, abbracciati,
mai più di un quarto d’ora per evitare la morte da assideramento.
Si vive in compagnia di topi e pidocchi, il rancio è un blocco di
ghiaccio: le razioni sono ricavate usando le accette. A ognuno viene consegnata
una porzione congelata di minestrone con la pasta, di pane, di formaggio,
di vino. Gli alpini succhiano e leccano come se si trattasse di un gelato,
un ghiacciolo, che sciogliendosi in bocca ha comunque perso l’originario
sapore. Mettono in bocca anche le penne per far tornare liquido l’inchiostro
e poter scrivere. Pippo nelle lettere non accenna all’improvviso trasferimento,
alle prove micidiali, che ogni giorno la ’Julia’ deve affrontare. I riferimenti
sono vaghi: campeggia un enorme affetto per gli alpini, un distaccato rispetto
nei confronti dei sovietici, chiamati sempre avversari, mai nemici. Pippo
scrive di meno, condensa in una facciata ciò che prima occupava diversi
fogli. E’ assorbito ventiquattr’ore su ventiquattro dall’assistenza a feriti
e congelati. Con il comando del gruppo Conegliano si è stabilito nel
villaggio di Golubaja Krinitza, lui e gli altri giocano con la morte a tutte
le ore. Ma nulla traspare dai fogli di carta velina, vergati con una grafia
allungata. Soltanto il 25 dicembre si lascia un po’ andare. "Caro Papà,
Il Natale di quest’anno è trascorso diversamente dagli altri in
una vera e propria atmosfera di guerra, il che ha con più nostalgia
riportato i nostri cuori verso i propri cari. La mia salute é ottima
e vi prego tutti di stare tranquilli perché sono certo di uscirne
sano e felice di vittoria. A questi magnifici e unici soldati d’Italia deve
andare ancora una volta l’imperituro ricordo da parte degli italiani. Si
sono battuti eroicamente, con un coraggio che mai ha avuto pari. Di qui certamente
non passeranno poiché gli animi sono tesi solamente alla conquista
di una vittoria completa. Come state tu e mamma? E tutti? Vi penso con amore
e devoto affetto. State tranquilli. Scriverò il più possibile.
Stamane abbiamo ascoltato in gruppo la messa. Da sei giorni non ho nuove
di voi tutti. Pensatemi e con la vostra fede pregate per i soldati d’Italia.
Bacio tutti. Tu e mamma beneditemi
Pippo" Nei giorni seguenti Pippo continua a inviare
brevi messaggi. E’ inquieto per la mancanza di lettere dei familiari, teme
che sia accaduta qualche disgrazia. Ripete sempre di stare benissimo, di
non correre rischi, qua e là afferma che la resistenza è ferrea,
che gli altri non la spunteranno. Il 29 dicembre il bollettino di guerra
dell’Alto comando tedesco cita "il superbo comportamento della Julia sul
fronte del medio Don". In Italia è una doccia gelata per quanti hanno
un parente nella divisione: si comincia a intuire che in Russia la situazione
volge al peggio. Il 31 dicembre Pippo scrive alla sorella Angelina: accenna
al comunicato della Wermacht, parla del magnifico comportamento di due alpini
siciliani, s’informa sul marito e sul bimbo che Angelina ha avuto da pochi
mesi. Con i genitori è più esplicito. "Carissimi è
l’ultimo giorno dell’anno, proprio quando ci si riuniva negli anni scorsi
per augurarci quanto di meglio poteva il nostro cuore. Oggi mi trovo lontano
e contentissimo egualmente di difendere la mia bella Patria. Avrete appreso
dal comunicato tedesco la menzione fatta alla Julia, che ancora una volta
non smentisce il valore, che in terra di Grecia tanti esaltarono con l’offerta
della propria vita. Ieri, cioè all’indomani della meritevole menzione,
i magnifici soldati veneti sono stati chiamati a un maggiore sacrificio.
In una lotta dura hanno offerto un quadro superbo di valore, che mai potrò
dimenticare. Hanno affrontato con deciso coraggio l’avversario assai più
numeroso e inferocito e a nulla badando gli hanno procurato perdite immense.
Noi per fortuna abbiamo avuto il minimo di perdite. Ieri, in una giornata
di fulgido eroismo, due siciliani si sono fatti onore. Un capitano, di cui
già vi ho parlato, figlio del professor D’Amico dello Spedalieri (uno
dei due licei classici di Catania, nda), e un sergente messinese, Pietro
Pitrillo, che ha immolato la sua giovane vita in uno slancio inarrestabile
di valore. Abbiamo giurato di vendicare i nostri morti e li vendicheremo.
Sono felice di appartenere a questa eroica divisione e spero di non allontanarmi
da essa se non alla fine della guerra. La mia salute è ottima e spero
che sia sempre così. State tutti tranquilli poiché eviterò
ogni pericolo per quanto consente il mio dovere. Vi penso sempre con tanto
tanto affetto, in specie in questi giorni di festa, che per noi debbono essere
precursori di un anno vittorioso. Scrivo sempre quanto più spesso.
Bacio voi, miei adorati genitori, con infinito affetto. A Pippa, Sasai e
nipoti, baci e abbracci cari. A cognati, parenti e amici, saluti cari. A
tutti auguri. Baci. Pensatemi e beneditemi
Pippo" Sul Don hanno brindato all’anno nuovo
con il cognac, l’unico liquido che non solidifica, facendo attenzione a non
poggiare le labbra sui gavettini per non lasciarci brandelli di pelle, come
succede quando si toccano con le mani nude i cannoni e le mitragliatrici.
Fra Natale e l’Epifania i congelati della Juve sono 6mila, meno del dieci
per cento accetta di farsi ricoverare. Il 3 gennaio viene distribuita ai
combattenti la posta. Pippo immediatamente risponde. Mezza paginetta per
il padre, mezza per la madre. E’ felicissimo che la famiglia al completo
abbia abbandonato Catania e si sia trasferita a Mascalucia, un paesino alle
falde dell’Etna. Dice che sapendoli al sicuro, lontano da eventuali bombardamenti,
si è tolto un peso dal cuore. Per il resto, salute ottima, pericoli
zero, alpini straordinari, massima fiducia sulle sorti della guerra, speranza
di essere all’altezza del proprio compito. L’ultima lettera ai genitori
è del 5: un fogliettino di fortuna, vergato con una scrittura malferma.
Pippo da giorni ha febbre alta, tosse, tuttavia rifiuta di abbandonare la
prima linea. Continua a soccorrere i suoi alpini e a stare peggio. Forse
suo padre e sua madre sospettano qualcosa, ma le sue bugie sono granitiche.
"Carissimi, come sempre scrivo quanto più spesso. La mia salute
è ottima. Spero che anche per voi tutti sia così. Qui procede
tutto bene e speriamo di poter stroncare completamente al più presto
ogni velleità dell’avversario, il quale osa tutto. Il morale è
altissimo. Dunque siate tranquilli. Vi penso e vi bacio tutti con immenso
affetto. Pippo". L’ultima lettera giunta in Italia ha la data dell’8 gennaio.
La destinataria è Angelina. "Ogni giorno o quasi ti scrivo e così
spero non ti manchino mie nuove. Comprendo come in questi momenti ti siano
tanto necessari i miei scritti. La mia salute è ottima. E tu ? E Angelo
(il marito, nda) e Salvo (il figlioletto, nda)? Si è rimesso il piccolo?
Sei tornata in paese? Come te la passi? Ti manca qualcosa? Hai avuto il pacco
e il vaglia? Tutte domande cui spero vorrai rispondere. Qui procede bene
ogni cosa e teniamo fortemente duro. Ormai anche l’avversario avrà
perduto ogni speranza sulla riuscita del suo attacco invernale. Il morale
è altissimo e gli alpini si battono audacemente. Quando cesserà
tutto ciò? Non certo prima di aver assestato un buon colpo all’avversario
e auguriamoci che possa essere ben presto. Ti prego di baciarmi tanto affettuosamente
Salvo. Un abbraccio ad Angelo. Pippo". Il 17 gennaio la ’Julia’, la ’Cuneense’,
la ’Tridentina’, la ’Vicenza’ si ritirano dalla linea del Don: s’avventurano
nel gelo per sfuggire all’accerchiamento delle divisioni corazzate sovietiche.
A mezzogiorno del 22 Pippo è a Nowo Georgiewskij. Le sue condizioni
sono critiche, si regge a fatica. Nei giorni precedenti ha partecipato ai
combattimenti con cui l’8° reggimento e il gruppo Conegliano hanno cercato
di farsi strada. Il fuoco dei cannoni, l’imperversare dei carri nemici li
hanno respinti. Pippo è andato all’assalto con baionetta e bombe a
mano. Adesso è sfinito, ha accanto Gildo, il caporale Maggioli, il
sottotenente veterinario Carlo Dodi, amico carissimo dai giorni della Grecia.
Cercano un riparo dal violento fuoco dei carri armati e delle mitragliatrici.
Il villaggio è squassato dalle esplosioni, vedono i soldati sovietici
balzar giù dagli autocarri, che li conducono quasi sulla linea del
fuoco, vengono informati che il colonnello Cimolino, comandante dell’8°,
ha deciso la resa per evitare un inutile massacro. Alcuni come il tenente
colonnello Rossotto riescono a svignarsela su slitte trainati da cavalli.
Pippo e gli altri intorno a lui si lanciano in un vallone (’balka’ in russo).
Sono individuati. Raffiche di mitra feriscono Maggioli al polso, Gildo è
colpito in pieno petto, stramazza sulla neve. Pippo si butta su di lui, lo
copre con il corpo, gli solleva il capo, lo chiama, prova a rianimarlo. Gildo
è morto. Urlando Pippo estrae la pistola, la punta alla tempia. Dodi
gli si lancia di sopra, lo disarma. Sono ormai circondati, si arrendono.
Marciano per tre giorni fino a Rossosch, il primo campo di raccolta dei
prigionieri italiani. Pippo è divorato dalla febbre, ma non cessa
un istante di sorreggere e confortare i compagni, Dodi coadiuva come può.
Non hanno medicine, disinfettante, bende: devono cavarsela con la neve, con
quel niente che c’è di disponibile, che può venir fuori dalle
tasche, da qualche zaino non requisito. Spesso si tratta di guardare i moribondi
morire, di chiudere gli occhi ai defunti. I sovietici non prestano il minimo
aiuto, non soccorrono chi cade, cercano la minima scusa per sparare. A Rossosch
Pippo, che è rimasto in testa alla colonna, viene enucleato assieme
agli ufficiali del comando. Dodi non lo vede più. In autunno al campo
di prigionia 74 il tenente Preli del gruppo Val Piave, proveniente da Tambov,
consegna a Dodi il portafoglio di Pippo, il testamento con le indicazioni
dei libretti di risparmio, alcune lettere dei genitori. Durante una perquisizione
le sentinelle sequestrano ogni cosa. E’ quasi certo che Pippo sia morto
nel marzo del ’43 a Tambov, uno dei campi di concentramento più lugubri,
teatro di atroci sofferenze e di migliaia di decessi, dove i vivi per avere
un posto a sedere dovevano attendere che qualcuno crepasse. La testimonianza
indiretta di Preli, che da lui aveva ricevuto portafoglio, testamento, lettere,
è la più attendibile. Pippo fu stroncato da un attacco di tifo
petecchiale. Fino alle ultime ore aveva cercato di occuparsi degli altri
ammalati. Nel timore del contagio, erano stati rinchiusi in un recinto. Non
tutti i giorni buttavano loro del pane semi congelato, quasi marcio. Dall’autunno
del ’45 la famiglia avvia le ricerche per avere notizie di Pippo. Sono mesi
di grande speranza. I sopravvissuti, quanti rientrano dalla prigionia in
Urss invitano a confidare, dicono che migliaia di soldati, dei quali sono
state perse le tracce, sono vivi. Uno di questi ex reclusi afferma di aver
visto Pippo nel marzo ’45 vicino Mosca. La fiducia di papà Salvatore
e di mamma Graziella è scossa nel ’47 da una lettera di Dodi al parroco
di Mascalucia. Appena tornato dalla prigionia, l’amico del cuore di Pippo
("vi confesso che sono partito per la Russia per stare di nuovo con lui"),
parla per la prima volta della sua morte, spiega il particolare del portafoglio,
del testamento, delle lettere ricevuti da Preli e sottratti dai carcerieri.
"...Il testamento era scritto fin dalla campagna in Jugoslavia e portava
due date, quella di Argos e quella del fronte russo. Io letteralmente non
lo ricordo: parla degli affetti suoi, che dovevano essere tutta la sua vita,
come i miei per me. Parla dei suoi vecchietti, chiede perdono se qualche
volta ha dovuto arrecare loro qualche dispiacere (io credo che non ne abbia
mai dato perché Giuseppe lo conoscevo molto bene intimamente). Per
Maria (credo che la fidanzata si chiami così), dice: il mio amore
imperituro oltre la morte. Queste sono le testuali parole da lui scritte.
Egli parla delle sorelle e finisce dicendo che se dovesse cadere, non gli
dispiace di aver dato la vita per l’Italia...". Fino al 1950 i genitori
e un cognato, il marito di Pippa, non si arrendono. Battono ogni strada,
inseguono qualunque indizio possa confortare la sopravvivenza di Pippo. Tra
le tante indicazioni suggerite per sapere qualcosa, spunta il nome di un
giovane sottotenente medico del Conegliano, il dottor Giulio Bedeschi, il
futuro autore del toccante ’Centomila gavette di ghiaccio’ (duraturo best
seller sull’odissea degli alpini in Grecia e in Russia). Il protagonista
di questa cronaca camuffata da romanzo é un capitano d’artiglieria
di Catania, Ugo Reitani, che nella realtà è il capitano Ugo
D’Amico, comandante della 13ma batteria del Conegliano, il figlio del professore
del liceo Spedalieri lodato da Pippo nella lettera del 31 dicembre. Nel
1954 rincasano dall’Unione Sovietica gli ultimi prigionieri italiani. I La
Greca cedono all’evidenza. Non tutti, però, credono alla morte di
Pippo. Nel 1955 le Poste rispondono che per riscuotere i libretti accesi
dal dottor La Greca serve che il medesimo si presenti allo sportello o che
firmi di suo pugno la delega a un fiduciario. Nel 1956 l’Esercito, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, chiede il pagamento (lire tremila)
della coperta assegnata in Jugoslavia al capitano medico Giuseppe La Greca
e da questi non restituita. La sola a non rassegnarsi è mamma
Graziella. Morrà novantenne ripetendo che un giorno avrebbero bussato
alla porta, lei sarebbe andata ad aprire... "Pippo..."
Tutte le volte che s’andava in casa della nonna, Pippo
sorrideva appena dalla parete del salotto. Era una foto del 1942: Pippo indossava
la divisa da capitano medico, aveva la posa impacciata di un introverso desideroso
di apparire disinvolto. La foto celebrava la fresca promozione, sarebbe servita
per l’album delle memorie, magari lui e Maria l’avrebbero osservata con affetto
e ironia il giorno delle nozze d’argento, nel 1968, a ricordo della passata
giovinezza. Stampigliate sul retro la foto presentava le referenze dell’autore:
’studio d’arte’ e prima del nome un ’cav.’ svolazzante. Finché
non si scioglieva nel suo caldo sorriso, Pippo era d’aspetto severo. Un po’
la timidezza, un po’ la preoccupazione di chi ha capito che la vita è
una prova dietro l’altra. Pippo vi era cresciuto in mezzo, orgoglioso di
averle fin lì superate. Era l’unico maschio venuto dopo due femmine
(Pippa e Sasai) e prima di un’altra (Angelina). Papà era un impiegato
del porto, la mamma discendeva da nobili lombi, ma nella discesa s’erano
perse le sostanze ed era rimasta l’ambizione del figlio laureato. Pippo c’era
riuscito giusto in tempo per finire nei gorghi della guerra cominciando nel
’39 con il servizio di leva. Nella foto in cornice Pippo ha poco
meno di trent’anni, il bel volto attraversato da uno sguardo malinconico,
la massa di capelli scuri e riccioluti adattati alla moda militare. Per oltre
mezzo secolo Pippo ha sempre avuto poco meno di trent’anni. Splendente di
giovinezza è rimasto su quella parete a veder morire i genitori e
invecchiare le sorelle. Ha assistito all’incrociarsi di cento destini, ha
ascoltato mille volte la consueta domanda di quanti per la prima volta mettevano
piede nel salotto di nonna Pippa: "Chi è?", un dito, un cenno del
capo a indicarlo. "E’ Pippo...Mio fratello...Non è tornato dalla
Russia..." Il capitano Giuseppe La Greca, Pippo dalla nascita, in Russia
non sarebbe dovuto andare. All’inizio del ’41 l’avevano spedito sul fronte
greco-albanese presso la ’Julia’, 3° reggimento d’artiglieria, gruppo
Conegliano. Era rientrato l’anno seguente con la malaria. Ma la malattia
pareva un dettaglio trascurabile con tutti quegli alpini mortigli intorno
per le polmoniti, per il gelo, per le infezioni, ogni tanto anche per le
pallottole dei greci. L’importante era che fosse tornato salvo e quasi sano.
Pippo aveva ringraziato Dio. La mamma e le sorelle la Madonna, alla quale
si erano espressamente rivolte ogni sera durante il rosario recitato intorno
al braciere con la carbonella. Nella tarda primavera del ’42 Pippo,
seppur convalescente, era preso dai preparativi del matrimonio con Maria.
La data era stata fissata per l’inizio del ’43, il giorno preciso ancora
da stabilire. Pippo e Maria stavano insieme da troppo tempo perché
la guerra potesse costituire un freno al loro amore. Anzi l’aveva accelerato.
Pippo non era più il poetico fidanzato, che nel ’39 da Firenze aveva
inviato a Maria una sua foto con questo breve messaggio: "Mentre sogno il
mio bene leggendo ciò che le sue adorabili dita hanno voluto imprimere".
E si vede lui, in perfetta tenuta, cinturone al fianco, bustina sulla testa,
seduto in terra con una lettera tra le mani. La guerra aveva cancellato
qualsiasi slancio. Al fronte Pippo aveva sentito a ogni passo il brutto alito
della morte sul collo. Gli era venuta voglia di avere qualcosa di suo; ciò
che ogni uomo avverte, sbagliando, come la proprietà più intangibile:
un figlio. Poi era arrivata la comunicazione dal comando: si parte per la
Russia. La Russia? In casa La Greca era l’altro mondo, molto più lontano
e angosciante dell’America, dove qualcuno della famiglia era andato. Ma in
America c’erano tanti cristiani, c’erano le chiese, c’erano pure gli italiani
e soprattutto c’erano i siciliani. In Russia c’erano i comunisti, c’erano
la neve e il ghiaccio, non c’erano più chiese, non c’erano italiani
e meno che mai siciliani. L’invocazione della mamma, del papà,
delle sorelle era stata unanime. Pippo non andare... Pippo é
pericoloso... Pippo sei già stato in Grecia... Pippo pensa a
noi... Pippo pensa a Maria... Anche Maria gli aveva chiesto sottovoce
se era proprio necessario che partisse e in questo caso che ne sarebbe stato
del loro matrimonio. " Ma per gennaio siamo a casa", l’aveva rassicurata
Pippo, che era il primo a non crederci. Pippo avrebbe potuto giocare la
carta della malaria, ma la religione del dovere in cui era stato allevato
gliela vietava. E più forte di questa fedeltà a se stesso s’imponeva
la fedeltà agli alpini. Non l’aveva chiesto lui di essere assegnato
alle penne nere, vi era stato inviato da Zara. Si trovava in Dalmazia, aggregato
alla fanteria, allorché le forti perdite subite nello scriteriato
assalto alla Grecia avevano imposto di mandare quanti più medici possibili
in prima linea. Pippo era pratico di mare e di montagna: la riviera dei Ciclopi
amata e goduta per nove mesi l’anno, l’Etna ammirata e rispettosamente sfidata
con gli sci e in estenuanti escursioni a piedi. A differenza degli altri
catanesi, che dell’enorme vulcano sono orgogliosi a parole, ma indifferenti
nell’intimo, Pippo lo avvertiva come un contrafforte della propria natura:
per lui lapilli, cenere e lava s’impastavano con i muscoli e con il sangue
di ognuno nato e cresciuto ai piedi dell’Etna. Una razza atipica di montanari
- ma esiste qualche categoria umana, di cui i siciliani non costituiscano
la variante eccentrica? - destinati per regio decreto a servire tra gli alpini.
Pippo ne aveva trovati alcuni, fierissimi di esserci, nei tre reggimenti
della ’Julia’, l’8°, il 9° più il 3°, quello di artiglieria,
il suo. In una settimana Pippo era precipitato dalla tranquilla attività
di guarnigione a Zara, dove le malattie veneree erano le insidie più
comuni, in un girone infernale di corpi trapanati, di membra sbrindellate,
di ragazzi spirati chiedendo il favore di stringere una mano. Al fronte i
sentimenti si erano cementati. La ’Julia’ era diventata madre e padre, ogni
alpino un fratello. Le sofferenze, i dolori, lo smarrimento, le angosce del
mattatoio greco-albanese si erano impressi sulla pelle e quelli che Pippo
non aveva visti e vissuti in prima persona, c’era sempre qualcuno pronto
a raccontarli. Ogni nome portava una pena. Il ponte di Dragotti preso e perso,
ripreso e riperso: dieci morti per ogni metro in avanti o indietro. Il ponte
di Perati, che aveva ispirato la canzone più triste e più bella
di tutta la guerra. Il Golico, la montagna feroce, con le pendici puntellate
di povere croci, spesso solo un cognome senza neppure la data: niente di
più per "la meglio gioventù che va sottoterra". La linea del
Mali: la ’Julia’ vi si era aggrappata con le unghie, non aveva mollato un
millimetro, una resistenza disperata come disperata era stata la volontà
di riportare a valle i morti per seppellirli. E poi: i plotoni, le compagnie
sbarcate a Durazzo senza fucili, con l’ordine di prendere quelli dei morti;
la leggenda, sussurrata, dell’alpino della ’Tridentina’ che aveva tentato
di uccidere il re; Mussolini in visita al fronte impegnato a spingere la
macchinona bloccata dal fango... Pippo aveva imparato che le penne
sul cappello calabrese - penne d’oca, di gallina, di tacchino, di ogni uccello
che capiti a tiro e quasi mai la penna di aquila richiesta dal protocollo
- restano impettite e gagliarde solo all’inizio, dopo qualche giorno s’ammosciano,
si rinsecchiscono, si piegano, ma non si spezzano al pari dei proprietari.
Li avvinceva e li univa un fortissimo senso di appartenenza: un corpo speciale
a misura di Alpi e Dolomiti. Alpino il nonno, alpino il padre, alpino il
figlio prossimo venturo. Ogni compagnia una valle, ogni plotone un dialetto.
Il nome stesso dei battaglioni, Tolmezzo, Gemona, Cividale, Vicenza, L’Aquila,
Val Cismon, e dei gruppi di artiglieria, Conegliano, Udine, Val Piave, richiamava
per molti l’uscio di casa, i sapori del paese. Fratelli, cugini, cognati
sparpagliati nei reparti, a darsi la voce l’un con l’altro, a tenere i fili
di conoscenze antiche, a ricordare le ragnatele familiari che legavano un
morto all’altro, a valutare i ’cittadini’, cioè quelli giunti da Milano
e da Catania, da Parma e da Bologna. Esami lunghi e silenziosi. Pippo
c’era abituato agli esami, eppure la sera in cui gli avevano regalato il
cappello con una lunghissima e lucente penna di gallo aveva gioito più
che alla laurea. In quei mesi di comunanza Pippo aveva compreso che il cappello
è la metà dell’alpino. L’aveva visto usare quale riparo dalla
pioggia, dalla neve, perfino dal sole quando la bella stagione conciliava
un sonnellino all’aperto. L’aveva visto trasformarsi in una comoda coppa
per raccogliere l’acqua dalle sorgenti e in una perfetta zuppiera per la
pastasciutta e la minestra. Lo stesso cappello che al momento propizio era
divenuto il contenitore di uova, di frutta, di pennuti, di bottiglie, di
scatolette sgraffignati qua e là per placare una fame implacabile.
Al termine di quella sera in cui era stato ammesso tra le penne nere ("Sul
cappello che noi portiamo/ c’è una lunga penna nera/ che a noi serve
da bandiera/ su pei monti a guerreggia"), gli avevano detto che dopo la guerra
il cappello gli sarebbe servito per misurare la crescita di suo figlio, che
all’inizio il ’bocia’ ne sarebbe stato sommerso, ma anno dopo anno l’avrebbe
portato sempre meglio finché non avrebbe avuto il suo. Perché,
naturalmente, il figlio di Giuseppe - così lo chiamavano gli artiglieri
del Conegliano - sarebbe stato un alpino. Già lo aspettavano. Insomma
dalla Grecia, assieme alla malaria, Pippo aveva riportato il mal di ’Julia’.
Gli era toccato leggere sui giornali sia l’affondamento della nave Galilea,
con ottocento ragazzi del Gemona scomparsi in mare, sia la cerimonia di Udine
per la consegna della medaglia d’oro all’8° reggimento, al 9° e al
3°, il suo. Lacrime, commozione, ricompense strameritate e pagate con
migliaia di cadaveri, tuttavia sullo sfondo era rimasta a galleggiare la
sensazione che quelle medaglie fossero soprattutto una spinta in più
per la nuova campagna. Pippo aveva sentito parlare della Russia da Gildo,
l’attendente, mesi prima. Allora gli era parso uno di quegli annunci sensazionali,
che corrono da una postazione all’altra prima di perdersi in una densa vaghezza.
Gli alpini in Russia? Per male che vada, aveva commentato Gildo, dovranno
riportarci in Italia e toglierci da questa merdaccia. Li avevano tolti
dalla merdaccia e li mandavano in Russia. Continuavano a chiamarla alla
vecchia maniera degli zar, Unione Sovietica era una definizione troppo recente
e per di più puzzava di comunismo, di ebraismo, di modernismo
Pippo all’inizio dell’estate ebbe due attacchi di malaria. Violentissimi
e brevissimi. In famiglia tirarono un sospiro di sollievo: vedi che stai
male? Dove vuoi andare in queste condizioni? Nel dormiveglia del febbrone
a Pippo rivenne in mente il brusco congedo del tenente colonnello Rossotto,
il comandante del Conegliano: "Capitano, mi raccomando: non tirate in ballo
la malaria per restarvene a casa mentre il reggimento torna in prima linea
ad assolvere la propria missione." Fosse stato per Rossotto, Pippo avrebbe
marcato visita. Ma come tradire se stesso? Come lasciare soli i suoi alpini,
a cominciare da Gildo così giovane e devoto, che al suo cuore raffigurava
il fratellino che non aveva avuto e il figlio che non aveva ancora? Appena
fu in grado di reggersi sulle gambe, si presentò al distretto, declinò
nome, grado, reparto, annunciò di voler raggiungere la ’Julia’ sotto
la propria responsabilità. Un sottufficiale con aria complice gli
chiese se voleva che lo stipendio gli fosse pagato per intero in Russia o
se preferiva, vista la cifra, che una parte gli venisse versata in Italia.
"Che cifra?", chiese Pippo. "Con l’indennità di missione, signor
capitano, sono più di quattromila lire al mese... Niente male, non
è vero?" Niente male, no. Pippo non aveva mai visto quei soldi
tutti insieme e avrebbe scommesso che non li aveva mai visti nemmeno suo
padre. Pensò a Maria, al matrimonio, alla possibilità di avere
da parte un po’ di risparmi per le prime spese; pensò ai genitori,
ai sacrifici affrontati per farlo studiare. Disse che gli bastava ricevere
in Russia lo stipendio mentre l’indennità di missione, tremila lire,
sarebbe venuta a ritirarla suo padre. Forse fu l’idea dei prossimi guadagni
che l’indusse a investire la paga di un mese nell’acquisto di bende, chinino,
sulfamidici, tintura di iodio. Comprò in farmacia tutto quello che
gli era mancato in Grecia. Ne riempì una valigia. Salì sul
treno per il Continente ad agosto. Al momento degli abbracci in casa, cui
sarebbero seguiti quelli sotto la pensilina e dentro lo scompartimento, la
mamma gli aveva dato un crocefisso con la raccomandazione di metterlo sopra
la brandina: avrebbe provveduto Lui a proteggerlo dalla malaria. Ai genitori,
alle sorelle, a Maria, ai nipoti che lo guardavano con orgoglio misto a invidia
(va a vincere la guerra...) la malaria sembrava molto più preoccupante
dei sovietici e del loro mitra con il caricatore a tamburo, del quale erano
già trapelati racconti da brivido. L’accompagnarono alla stazione.
Pippo s’affacciò dal finestrino per salutare, promise che avrebbero
trascorso il Natale insieme. Sparì assieme al treno dietro la curva,
che sembra far sprofondare il binario in mare. La prima lettera di Pippo
ha la data del 24 agosto, é indirizzata al padre. Pippo accenna al
dovere da compiere, alle attese della Patria: per lui dovere e Patria coincidono
nell’obbedienza. In qualche riga sventola a mo’ di bandiera l’italianità,
sulle frasi aleggia un velo di rassegnazione. L’unica consolazione è
la presenza degli alpini, l’essere in mezzo a quelli che egli giudica i migliori
soldati del mondo, nonostante gli abbiano rifilato un tiro mancino: a Udine
hanno svuotato la valigia dei medicinali e l’hanno riempita di bottiglie
di grappe avvolte nella bambagia. In tal modo la scorta di liquori ha evitato
controlli e sequestri. Il disappunto di Pippo si è perso nella baldoria
di cento brindisi, nessuno ha preso sul serio le sue rimostranze. Nell’accogliente
estate sovietica, la guerra appare lontana: chi può immaginare che
da lì a qualche mese il materiale abbandonato a Udine sarà
amaramente rimpianto? L’Unione Sovietica sembra a Pippo un Paese a
pezzi, ai confini dell’Europa e della civiltà. Rimane colpito dalla
povertà dei contadini, dagli abiti sudici e logori. Fa il paragone
con le regioni della Germania attraversate durante il lunghissimo viaggio,
fa il paragone con la determinazione dei tedeschi, soprattutto delle donne:
gli sembrano proiettati all’unisono verso la vittoria. Scrive che i comandi
hanno suggerito agli ufficiali di spiegare alla truppa che tanta indigenza
è colpa degli ebrei, che adesso grazie ai soldati dell’Asse la popolazione
sovietica si è potuta ribellare agli "avidi giudei" e avviarsi verso
l’era della rinascita. Anziché sul Caucaso, la Julia e le altre
due divisioni alpine, Tridentina e Cuneense, sono inviate sulla linea del
Don. Gli alpini in pianura sono un controsenso, ma il nostro Stato Maggiore
è ben lieto di accogliere la richiesta dell’Oberkommando di Berlino.
Pippo, però, di questo non parla: gli preme rassicurare madre, padre,
sorelle sulle sue ottime condizioni di salute, sul morale più che
buono, sull’assenza di pericoli. A volte nella stessa busta infila messaggi
per ogni componente della famiglia, cognati e nipoti compresi: si preoccupa
per i bombardamenti in Italia, è in ansia per la sorella minore, Angelina,
trasferitasi dopo il matrimonio a Milano. Invia a lei una parte della stipendio
e pacchi di generi alimentari acquistati allo spaccio. Da casa insistono
con le raccomandazioni, gli chiedono di curarsi, di non fare l’eroe, lui
replica spiegando che la guerra per ora l’hanno ascoltata nelle parole dei
bollettini: "...mamma carissima, che cosa vuoi che mi succeda? Gildo ha provveduto
a collocare il tuo crocefisso sopra il comodino accanto al letto: ho più
angeli custodi io che il mio generale...". Nell’autunno la corrispondenza
s’infittisce. Pippo scherza sulla neve ("quella dell’Etna è più
bella"), sul buio incombente, sui preparativi per affrontare il freddo. Accenna
a un’imminente offensiva, rievoca l’eccitazione di molti per un discorso
di Mussolini trasmesso dalla radio. Chiede continuamente notizie di tutti,
cerca di ricostituire a migliaia di chilometri l’ambiente e il calore della
famiglia. Si lamenta se non gli rispondono con sollecitudine, invita a usare
la posta aerea, che in sette-dieci giorni viene recapitata. E’ un profluvio
di lettere, intervallate da qualche cartolina speciale in dotazione alle
Forze Armate. Recano stampigliati gl’incitamenti del principe ereditario
Umberto e di Mussolini. Umberto è monocorde, buono per tutti gli usi:
"Temprate le vostre forze, perfezionate il vostro sapere, alimentate la fede".
Mussolini è più vario, a cavallo tra passato e futuro, con
un occhio alla Storia. "Affermo solennemente, e senza tema di essere smentito
né oggi né mai, che la responsabilità della guerra ricade
esclusivamente sulla Gran Bretagna". Oppure: "L’avvenire è nostro,
è nelle nostre mani sicure, poiché sarà il prodotto
del nostro coraggio e della nostra inesauribile volontà di vita e
di vittoria". Ma la vittoria si allontana. A metà dicembre ’42
la 1a armata Guardie e la 6a armata con robusto sostegno di blindati sfondano
nel settore tenuto dalle divisioni ’Ravenna’, ’Cosseria’, ’Pasubio’. E’ l’operazione
’Piccolo Saturno’, seguito dell’operazione ’Urano’ con cui i soldati di
Stalin un mese prima hanno stretto d’assedio la 6a armata tedesca a Stalingrado.
Per mettere un argine e proteggere la precipitosa ritirata delle sei divisioni
di fanteria (nello sfaldamento sono state coinvolte anche la ’Celere’, la
’Sforzesca’ e la ’Torino’) il generale Gariboldi, comandante dell’Armir (Armata
italiana in Russia), ordina alla ’Julia’ di correre in aiuto. In quarantott’ore
gli alpini lasciano la postazione a nord dello schieramento, comprendente
anche la ’Tridentina’ e la ’Cuneense’, e si precipitano nell’ansa del Don
tra Nowo Kalitwa e Krinitschnaja. Con l’apporto di sparuti contingenti germanici
la ’Julia’ è una sorta di frangiflutti in un Oceano in tempesta. L’offensiva
sovietica è in pieno sviluppo: a destra della divisione per duecento
chilometri, fino a Stalingrado, resistono pochissimi reparti italiani, rumeni
e ungheresi. La ’Julia’ diviene da subito l’ostacolo da eliminare per prendere
alle spalle la ’Cuneense’, la ’Tridentina’, la raccogliticcia divisione territoriale
’Vicenza’, subentratale nell’antica posizione. Dal 20 dicembre la lotta
s’inasprisce. Gli attacchi delle divisioni sovietiche, composte da quindici
battaglioni, mentre quelli italiani sono stati ridotti a sei da una geniale
trovata di Mussolini, continuano senza soste. Li appoggiano un gran numero
di carri armati - gli enormi ed agili T34, i mastodontici KV1 e 2 - innumerevoli
squadriglie caccia (ai Mig 3 si affiancano i nuovissimi Lavochkin La-5) e
parecchi esemplari di un bombardiere che appare imperforabile, l’Ilyushin
Il-2. Gli alpini s’inchiodano al terreno nel senso che scavano le buche e
vi rimangono dentro giorno e notte, con i piedi congelati, le mani rattrappite,
i denti bloccati dal freddo. I comandi dei tre reggimenti della ’Julia’ ignorano
che cosa avviene ai loro fianchi, ci si arrangia a vista. I tedeschi faticano
a tenere le posizioni, le penne nere sono spesso chiamate a metterci una
pezza. La temperatura scende a -30°, i magazzini con le nuove divise
vengono bruciati per non farli cadere in mano russa. Non esistono baracche,
tanto meno ricoveri, gli unici sono le buche scavate per combattere. La dotazione
è di una coperta a testa, qualche fortunato ne ha un paio. Alcuni
anfratti sono trasformati in tane: ci si accuccia nelle pause tra un combattimento
e l’altro ed è un gran sollievo passare dai -30° dell’esterno
ai -20° di questi improvvisati rifugi. Si dorme a turno, abbracciati,
mai più di un quarto d’ora per evitare la morte da assideramento.
Si vive in compagnia di topi e pidocchi, il rancio è un blocco di
ghiaccio: le razioni sono ricavate usando le accette. A ognuno viene consegnata
una porzione congelata di minestrone con la pasta, di pane, di formaggio,
di vino. Gli alpini succhiano e leccano come se si trattasse di un gelato,
un ghiacciolo, che sciogliendosi in bocca ha comunque perso l’originario
sapore. Mettono in bocca anche le penne per far tornare liquido l’inchiostro
e poter scrivere. Pippo nelle lettere non accenna all’improvviso trasferimento,
alle prove micidiali, che ogni giorno la ’Julia’ deve affrontare. I riferimenti
sono vaghi: campeggia un enorme affetto per gli alpini, un distaccato rispetto
nei confronti dei sovietici, chiamati sempre avversari, mai nemici. Pippo
scrive di meno, condensa in una facciata ciò che prima occupava diversi
fogli. E’ assorbito ventiquattr’ore su ventiquattro dall’assistenza a feriti
e congelati. Con il comando del gruppo Conegliano si è stabilito nel
villaggio di Golubaja Krinitza, lui e gli altri giocano con la morte a tutte
le ore. Ma nulla traspare dai fogli di carta velina, vergati con una grafia
allungata. Soltanto il 25 dicembre si lascia un po’ andare. "Caro Papà,
Il Natale di quest’anno è trascorso diversamente dagli altri in
una vera e propria atmosfera di guerra, il che ha con più nostalgia
riportato i nostri cuori verso i propri cari. La mia salute é ottima
e vi prego tutti di stare tranquilli perché sono certo di uscirne
sano e felice di vittoria. A questi magnifici e unici soldati d’Italia deve
andare ancora una volta l’imperituro ricordo da parte degli italiani. Si
sono battuti eroicamente, con un coraggio che mai ha avuto pari. Di qui certamente
non passeranno poiché gli animi sono tesi solamente alla conquista
di una vittoria completa. Come state tu e mamma? E tutti? Vi penso con amore
e devoto affetto. State tranquilli. Scriverò il più possibile.
Stamane abbiamo ascoltato in gruppo la messa. Da sei giorni non ho nuove
di voi tutti. Pensatemi e con la vostra fede pregate per i soldati d’Italia.
Bacio tutti. Tu e mamma beneditemi
Pippo" Nei giorni seguenti Pippo continua a inviare
brevi messaggi. E’ inquieto per la mancanza di lettere dei familiari, teme
che sia accaduta qualche disgrazia. Ripete sempre di stare benissimo, di
non correre rischi, qua e là afferma che la resistenza è ferrea,
che gli altri non la spunteranno. Il 29 dicembre il bollettino di guerra
dell’Alto comando tedesco cita "il superbo comportamento della Julia sul
fronte del medio Don". In Italia è una doccia gelata per quanti hanno
un parente nella divisione: si comincia a intuire che in Russia la situazione
volge al peggio. Il 31 dicembre Pippo scrive alla sorella Angelina: accenna
al comunicato della Wermacht, parla del magnifico comportamento di due alpini
siciliani, s’informa sul marito e sul bimbo che Angelina ha avuto da pochi
mesi. Con i genitori è più esplicito. "Carissimi è
l’ultimo giorno dell’anno, proprio quando ci si riuniva negli anni scorsi
per augurarci quanto di meglio poteva il nostro cuore. Oggi mi trovo lontano
e contentissimo egualmente di difendere la mia bella Patria. Avrete appreso
dal comunicato tedesco la menzione fatta alla Julia, che ancora una volta
non smentisce il valore, che in terra di Grecia tanti esaltarono con l’offerta
della propria vita. Ieri, cioè all’indomani della meritevole menzione,
i magnifici soldati veneti sono stati chiamati a un maggiore sacrificio.
In una lotta dura hanno offerto un quadro superbo di valore, che mai potrò
dimenticare. Hanno affrontato con deciso coraggio l’avversario assai più
numeroso e inferocito e a nulla badando gli hanno procurato perdite immense.
Noi per fortuna abbiamo avuto il minimo di perdite. Ieri, in una giornata
di fulgido eroismo, due siciliani si sono fatti onore. Un capitano, di cui
già vi ho parlato, figlio del professor D’Amico dello Spedalieri (uno
dei due licei classici di Catania, nda), e un sergente messinese, Pietro
Pitrillo, che ha immolato la sua giovane vita in uno slancio inarrestabile
di valore. Abbiamo giurato di vendicare i nostri morti e li vendicheremo.
Sono felice di appartenere a questa eroica divisione e spero di non allontanarmi
da essa se non alla fine della guerra. La mia salute è ottima e spero
che sia sempre così. State tutti tranquilli poiché eviterò
ogni pericolo per quanto consente il mio dovere. Vi penso sempre con tanto
tanto affetto, in specie in questi giorni di festa, che per noi debbono essere
precursori di un anno vittorioso. Scrivo sempre quanto più spesso.
Bacio voi, miei adorati genitori, con infinito affetto. A Pippa, Sasai e
nipoti, baci e abbracci cari. A cognati, parenti e amici, saluti cari. A
tutti auguri. Baci. Pensatemi e beneditemi
Pippo" Sul Don hanno brindato all’anno nuovo
con il cognac, l’unico liquido che non solidifica, facendo attenzione a non
poggiare le labbra sui gavettini per non lasciarci brandelli di pelle, come
succede quando si toccano con le mani nude i cannoni e le mitragliatrici.
Fra Natale e l’Epifania i congelati della Juve sono 6mila, meno del dieci
per cento accetta di farsi ricoverare. Il 3 gennaio viene distribuita ai
combattenti la posta. Pippo immediatamente risponde. Mezza paginetta per
il padre, mezza per la madre. E’ felicissimo che la famiglia al completo
abbia abbandonato Catania e si sia trasferita a Mascalucia, un paesino alle
falde dell’Etna. Dice che sapendoli al sicuro, lontano da eventuali bombardamenti,
si è tolto un peso dal cuore. Per il resto, salute ottima, pericoli
zero, alpini straordinari, massima fiducia sulle sorti della guerra, speranza
di essere all’altezza del proprio compito. L’ultima lettera ai genitori
è del 5: un fogliettino di fortuna, vergato con una scrittura malferma.
Pippo da giorni ha febbre alta, tosse, tuttavia rifiuta di abbandonare la
prima linea. Continua a soccorrere i suoi alpini e a stare peggio. Forse
suo padre e sua madre sospettano qualcosa, ma le sue bugie sono granitiche.
"Carissimi, come sempre scrivo quanto più spesso. La mia salute
è ottima. Spero che anche per voi tutti sia così. Qui procede
tutto bene e speriamo di poter stroncare completamente al più presto
ogni velleità dell’avversario, il quale osa tutto. Il morale è
altissimo. Dunque siate tranquilli. Vi penso e vi bacio tutti con immenso
affetto. Pippo". L’ultima lettera giunta in Italia ha la data dell’8 gennaio.
La destinataria è Angelina. "Ogni giorno o quasi ti scrivo e così
spero non ti manchino mie nuove. Comprendo come in questi momenti ti siano
tanto necessari i miei scritti. La mia salute è ottima. E tu ? E Angelo
(il marito, nda) e Salvo (il figlioletto, nda)? Si è rimesso il piccolo?
Sei tornata in paese? Come te la passi? Ti manca qualcosa? Hai avuto il pacco
e il vaglia? Tutte domande cui spero vorrai rispondere. Qui procede bene
ogni cosa e teniamo fortemente duro. Ormai anche l’avversario avrà
perduto ogni speranza sulla riuscita del suo attacco invernale. Il morale
è altissimo e gli alpini si battono audacemente. Quando cesserà
tutto ciò? Non certo prima di aver assestato un buon colpo all’avversario
e auguriamoci che possa essere ben presto. Ti prego di baciarmi tanto affettuosamente
Salvo. Un abbraccio ad Angelo. Pippo". Il 17 gennaio la ’Julia’, la ’Cuneense’,
la ’Tridentina’, la ’Vicenza’ si ritirano dalla linea del Don: s’avventurano
nel gelo per sfuggire all’accerchiamento delle divisioni corazzate sovietiche.
A mezzogiorno del 22 Pippo è a Nowo Georgiewskij. Le sue condizioni
sono critiche, si regge a fatica. Nei giorni precedenti ha partecipato ai
combattimenti con cui l’8° reggimento e il gruppo Conegliano hanno cercato
di farsi strada. Il fuoco dei cannoni, l’imperversare dei carri nemici li
hanno respinti. Pippo è andato all’assalto con baionetta e bombe a
mano. Adesso è sfinito, ha accanto Gildo, il caporale Maggioli, il
sottotenente veterinario Carlo Dodi, amico carissimo dai giorni della Grecia.
Cercano un riparo dal violento fuoco dei carri armati e delle mitragliatrici.
Il villaggio è squassato dalle esplosioni, vedono i soldati sovietici
balzar giù dagli autocarri, che li conducono quasi sulla linea del
fuoco, vengono informati che il colonnello Cimolino, comandante dell’8°,
ha deciso la resa per evitare un inutile massacro. Alcuni come il tenente
colonnello Rossotto riescono a svignarsela su slitte trainati da cavalli.
Pippo e gli altri intorno a lui si lanciano in un vallone (’balka’ in russo).
Sono individuati. Raffiche di mitra feriscono Maggioli al polso, Gildo è
colpito in pieno petto, stramazza sulla neve. Pippo si butta su di lui, lo
copre con il corpo, gli solleva il capo, lo chiama, prova a rianimarlo. Gildo
è morto. Urlando Pippo estrae la pistola, la punta alla tempia. Dodi
gli si lancia di sopra, lo disarma. Sono ormai circondati, si arrendono.
Marciano per tre giorni fino a Rossosch, il primo campo di raccolta dei
prigionieri italiani. Pippo è divorato dalla febbre, ma non cessa
un istante di sorreggere e confortare i compagni, Dodi coadiuva come può.
Non hanno medicine, disinfettante, bende: devono cavarsela con la neve, con
quel niente che c’è di disponibile, che può venir fuori dalle
tasche, da qualche zaino non requisito. Spesso si tratta di guardare i moribondi
morire, di chiudere gli occhi ai defunti. I sovietici non prestano il minimo
aiuto, non soccorrono chi cade, cercano la minima scusa per sparare. A Rossosch
Pippo, che è rimasto in testa alla colonna, viene enucleato assieme
agli ufficiali del comando. Dodi non lo vede più. In autunno al campo
di prigionia 74 il tenente Preli del gruppo Val Piave, proveniente da Tambov,
consegna a Dodi il portafoglio di Pippo, il testamento con le indicazioni
dei libretti di risparmio, alcune lettere dei genitori. Durante una perquisizione
le sentinelle sequestrano ogni cosa. E’ quasi certo che Pippo sia morto
nel marzo del ’43 a Tambov, uno dei campi di concentramento più lugubri,
teatro di atroci sofferenze e di migliaia di decessi, dove i vivi per avere
un posto a sedere dovevano attendere che qualcuno crepasse. La testimonianza
indiretta di Preli, che da lui aveva ricevuto portafoglio, testamento, lettere,
è la più attendibile. Pippo fu stroncato da un attacco di tifo
petecchiale. Fino alle ultime ore aveva cercato di occuparsi degli altri
ammalati. Nel timore del contagio, erano stati rinchiusi in un recinto. Non
tutti i giorni buttavano loro del pane semi congelato, quasi marcio. Dall’autunno
del ’45 la famiglia avvia le ricerche per avere notizie di Pippo. Sono mesi
di grande speranza. I sopravvissuti, quanti rientrano dalla prigionia in
Urss invitano a confidare, dicono che migliaia di soldati, dei quali sono
state perse le tracce, sono vivi. Uno di questi ex reclusi afferma di aver
visto Pippo nel marzo ’45 vicino Mosca. La fiducia di papà Salvatore
e di mamma Graziella è scossa nel ’47 da una lettera di Dodi al parroco
di Mascalucia. Appena tornato dalla prigionia, l’amico del cuore di Pippo
("vi confesso che sono partito per la Russia per stare di nuovo con lui"),
parla per la prima volta della sua morte, spiega il particolare del portafoglio,
del testamento, delle lettere ricevuti da Preli e sottratti dai carcerieri.
"...Il testamento era scritto fin dalla campagna in Jugoslavia e portava
due date, quella di Argos e quella del fronte russo. Io letteralmente non
lo ricordo: parla degli affetti suoi, che dovevano essere tutta la sua vita,
come i miei per me. Parla dei suoi vecchietti, chiede perdono se qualche
volta ha dovuto arrecare loro qualche dispiacere (io credo che non ne abbia
mai dato perché Giuseppe lo conoscevo molto bene intimamente). Per
Maria (credo che la fidanzata si chiami così), dice: il mio amore
imperituro oltre la morte. Queste sono le testuali parole da lui scritte.
Egli parla delle sorelle e finisce dicendo che se dovesse cadere, non gli
dispiace di aver dato la vita per l’Italia...". Fino al 1950 i genitori
e un cognato, il marito di Pippa, non si arrendono. Battono ogni strada,
inseguono qualunque indizio possa confortare la sopravvivenza di Pippo. Tra
le tante indicazioni suggerite per sapere qualcosa, spunta il nome di un
giovane sottotenente medico del Conegliano, il dottor Giulio Bedeschi, il
futuro autore del toccante ’Centomila gavette di ghiaccio’ (duraturo best
seller sull’odissea degli alpini in Grecia e in Russia). Il protagonista
di questa cronaca camuffata da romanzo é un capitano d’artiglieria
di Catania, Ugo Reitani, che nella realtà è il capitano Ugo
D’Amico, comandante della 13ma batteria del Conegliano, il figlio del professore
del liceo Spedalieri lodato da Pippo nella lettera del 31 dicembre. Nel
1954 rincasano dall’Unione Sovietica gli ultimi prigionieri italiani. I La
Greca cedono all’evidenza. Non tutti, però, credono alla morte di
Pippo. Nel 1955 le Poste rispondono che per riscuotere i libretti accesi
dal dottor La Greca serve che il medesimo si presenti allo sportello o che
firmi di suo pugno la delega a un fiduciario. Nel 1956 l’Esercito, tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, chiede il pagamento (lire tremila)
della coperta assegnata in Jugoslavia al capitano medico Giuseppe La Greca
e da questi non restituita. La sola a non rassegnarsi è mamma
Graziella. Morrà novantenne ripetendo che un giorno avrebbero bussato
alla porta, lei sarebbe andata ad aprire... "Pippo..." acquista il libro on line torna all’archivio |
| home | il nuovo libro | archivio | biografia | bibliografia | email |

